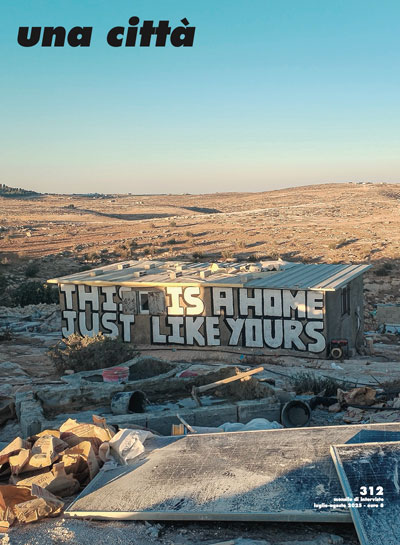Grazie alle cure, dunque, del più fedele e profondo dei suoi amici-discepoli, Nicola Chiaromonte, trecento pagine di scritti di Andrea Caffi, storici morali filosofici, si leggono in un volume bene intitolato "Critica della violenza". Un'altra raccolta, di saggi politici, seguirà tra breve; e l'interesse che è sperabile divampi intorno a questa figura senza rivali, porterà forse al recupero di altre zone di quel chiaro paesaggio di rilievi e di idee che egli giornalmente affidava a quaderni, schede o lettere.
Quel che Caffi pubblicò durante la sua vita è ben poco. Ma i suoi stessi manoscritti, se anche si potessero ritrovar tutti, e perfino questi quindici luminosi saggi (o frammenti di saggi) ora stampati, lo rappresentano soltanto, per così dire, obliquamente. Storico per formazione con speciale interesse al mondo bizantino, ma nemico di ogni sapere accademico, Caffi pensava infatti socraticamente, con gli altri e per gli altri, contro ogni preconcetto e fuori d'ogni schema. Comporre libri e dimostrar tesi, non era affar suo.
Il suo modo naturale di riflettere era lo scambio di idee, e perché presuppone l'amicizia, e perché è legato a un contesto di vita. Sebbene l'ampiezza della sua cultura fosse sconfinata, "quanto" Caffi sapeva colpiva meno di "come" egli sapeva le cose, in primo luogo i fatti storici. Scrive Nicola Chiarornonte, nella sua prefazione a questi saggi, nella quale, leggendo della vita e delle idee, a momenti si coglie come la presenza del maestro-amico: «II dono che si riceveva continuamente da Caffi era la visione del fenomeno "salvo" dai rigori della presunzione intellettuale e del dogmatismo. ...L'originalità profonda del suo pensiero ...era di concepire l'essenza, la verità vìva, la sostanza sacra dei fatti umani come una realtà concreta, non come una idea astratta, un principio ideologico o un precetto morale».
Era nato a Pietroburgo nel 1887, e morì nel 1955 a Parigi, dove era vissuto per decenni; le sue radici intellettuali e affettive erano russe e francesi altrettanto che italiane. Socialista attivo fin dall'adolescenza, a diciotto anni ebbe parte in Russia nella rivoluzione del 1905, per cui scontò due anni di carcere. Della sua biografia così ricca e ancora malnota, in questo cenno si può ricordare soltanto che tutti gli eventi del secolo l'ebbero partecipe coscientissimo e audace: la prima guerra mondiale, la rivoluzione bolscevica, l'antifascismo italiano, la Resistenza, il primo decennio del dopoguerra.
Ma quanto attiva fu la vicinanza di Caffi ai moti ideali e politici del nostro tempo, altrettanto recisa fu la sua noncuranza d'ogni carriera, anzi rifiuto di qualunque "sistemazione". «Era evidente», scrive Chiaromonte, «che non si trattava tanto di riluttanza al compromesso, quanto della volontà di non "inserirsi" in alcun modo in una società che gli dispiaceva profondamente». "Eremita socievole", visse una vita di prodiga povertà, ricchissima di amicizie.
E' naturale che al centro del pensiero di Caffi, come degli scritti di questo volume, sia l'idea di "socievolezza", la "philìa" di Aristotele. Alla dottrina marxistica delle "classi" sociali, Caffi preferisce una tripartizione cara agli storici russi, quella di Governo-Società-Popolo. Governo è chi comanda e in genere opprime; Popolo è la moltitudine, come diceva Proudhon, «che paga e prega»; mentre per Società, peculiarmente ma molto fecondamente, Caffi intende «l'insieme di quei rapporti umani che si possono definire spontanei e in certo modo gratuiti, nel senso che hanno almeno l'apparenza della libertà».
Della "società" così intesa, (quella, suggerisce Chiaromonte, che Leopardi chiamava "l'umana compagnia"), Caffi non si stancava d'inseguire «l' ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!