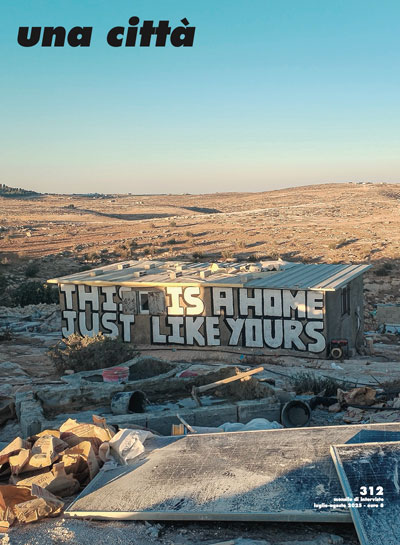Qui, per cominciare, si dimentica che, per rigorosa che fosse la disciplina immaginata da Platone nel suo Stato ideale, la nozione della rigidità di un dogma qualsiasi è del tutto assente dalla sua filosofia. Basti, a ciò indicare, il passo del Politico (294b) dove Platone dice: "La diversità che si avverte negli uomini e nelle loro azioni, l'assenza completa d'immobilità nelle cose umane, sottraggono queste a qualsiasi regola semplice, applicabile a tutti i casi e valida per tutti i tempi; ogni arte umana ha da fare con cose mutevoli e varie, quindi procede tenendo assai minor conto delle regole generali che d'ingegnosi adattamenti alle circostanze." Lo sforzo da fare, per capire Platone, è sempre quello di tener pensieri simili in non minor conto di quelli nei quali si esprime il rigore del filosofo deciso a svolgere fino in fondo un certo ordine di riflessioni, per opporlo alle incertezze velleitarie del comune discorso.
Ma il vero paradosso è che la formazione dell'uomo e del cittadino ideata nell'Accademia, e variamente poi praticata dalle altre scuole filosofiche, mirava anzitutto a risvegliare, a rendere coscienti e efficienti le migliori capacità dell'animo, naturalmente implicite, ma che non potevano spontaneamente esplicarsi nell'ambiente corrotto dalla polis in decadenza, e tanto meno in quello delle monarchie ellenistiche o barbare, e perciò esigevano di essere coltivate in qualche giardino sottratto a ogni ingerenza delle autorità costituite. La conseguenza anche più paradossale era che la politeia alla quale si preparavano i discepoli di queste scuole e verso la quale puntavano le loro positive aspirazioni non poteva assolutamente identificarsi con nessuno Stato esistente, anzi si ergeva spesso di fronte a questi come un punto di appoggio per una critica risoluta.
Ora, quest'autonomia di un consorzio ideale, e l'ascendente che la sua mera affermazione esercitava sulla società reale (contribuendo anche a mantenere vivo il senso di un "diritto naturale" al disopra e al difuori di ogni legislazione coercitiva) non ha mai potuto essere soppressa o addomesticata dai poteri costituiti: i Senati, gli imperatori, i re hanno potuto chiudere scuole, proscrivere in massa i "filosofi"; ma non appena si decidevano a fare un posto alla vita intellettuale, costretti a convincersi che senza questa non avrebbero neppure avuto le risorse e il decoro della civiltà dovevano poi ineluttabilmente lasciarla perseverare in libertà nelle sue proprie vie.
Decisiva fu la determinazione della Chiesa cattolica — dopo parecchie esitazioni e reazioni — di fare una parte congrua a questa eredità del paganesimo: altrimenti non si sarebbe potuta mantenere la preminenza dell'elemento ecclesiastico fra la popolazione di antiche città; tanto più che, la parte più attiva del clero reclutandosi nel ceto colto delle medesime città, non si vede neppure come si sarebbe costituita una gerarchia veramente cattolica, o "ecumenica", senza un compromesso fra le "regole" di una setta, sostenute dalla coercizione, e le "norme" prive d'ogni sanzione che caratterizzano una società civile distinta dallo Stato. Non pare assurdo vedere in ciò un merito dell'imperatore Giuliano, che gli storici hanno forse torto di compatire tanto per le "romantiche chimere" cui sarebbe andato dietro: con l'aver posto in chiara luce i valori propri della tradizione ellenica e invitato i "nazareni" a rinunciarvi se volevano essere coerenti (nel decreto che chiudeva ai cristiani l'accesso alle cattedre di eloquenza, poesia, filosofia), è probabile che Giuliano suscitasse un generale ravvedimento quanto all'insostituibile prestigio dell'alta cultura ellenica, contribuendo così a far nascere l'avido zelo con cui vediamo i Padri Cappadoci da un lato, e Girolamo, Ambrogio, Agostino dall'altro, incorporare quanto più potessero di pensiero greco al patrimonio della civiltà cristiana.
Le Scuole, del cui tipo Oxford e Cambridge conservano oggi gli ultimi vestigi, furono ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!