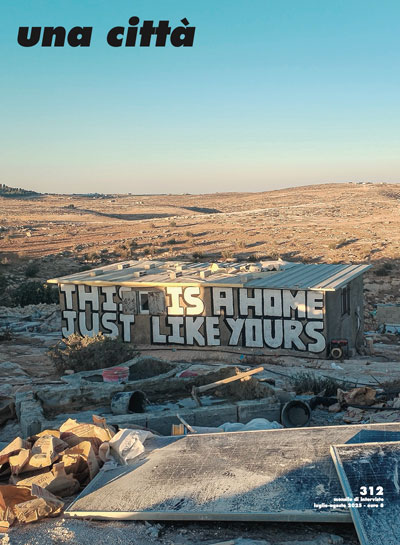Tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30 l’antifascismo si trova ad affrontare il tema del totalitarismo in termini nuovi, suggeriti dall’assonanza tra fascismo e bolscevismo che in questo periodo viene colta e sottolineata con forza nella sfera della politologia accademica, nel dibattito culturale e intellettuale e, soprattutto, nella riflessione specifica dei protagonisti della politica militante
1. Tra gli esiti di tale riflessione si registra una sorta di sentire comune che sembra unire anime della cultura antifascista alquanto eterogenee: socialisti dissidenti rispetto alla linea frontista nenniana, giellisti convinti della praticabilità dell’ircocervo socialista-liberale, anarchici revisionisti disposti a rinunciare al dogma collettivistico. Di fronte alla crescita dei totalitarismi questi diversi gruppi propongono elaborazioni e progettualità che, pur presentando ovvie differenze di impostazione e di indirizzo nell’analisi della nuova realtà socio-politica dello stato totalitario e nella critica delle ideologie tradizionali della sinistra stessa (in particolare quelle più influenzate dal marxismo), innescano un processo di reinvenzione politico-culturale che culmina in una nuova considerazione della civiltà liberale e nella riscoperta della carica libertaria del socialismo autonomistico, portando alla ribalta gli elementi necessari per pensare un’alternativa al frontismo: centralità dell’individuo come cellula sociale primaria e incoartabile (con conseguente accettazione, a volte, della logica del mercato); autonomia della società civile rispetto alla politica; rifiuto della logica verticistica imposta dallo Stato moderno; valorizzazione delle istanze associative dal basso su base federalista, associazionista e consiliare. Questi elementi ispirano una molteplicità di percorsi e di soluzioni che trovano ulteriore raccordo culturale nella tradizione repubblicana-federalista italiana, filtrata dal problemismo di Gaetano Salvemini, che assume l’aspetto di un modello di interazione politica e culturale alternativo al centralismo dello Stato liberale; nelle suggestioni storicistiche, intese come valorizzazione della singolarità storica e culturale di contro a soluzioni universalistiche e per ciò stesso coercitive; nella valorizzazione gobettiana del liberalismo come "passione libertaria” e filosofia della rivoluzione; negli scritti dei revisionisti del marxismo, che valorizzano un approccio etico al pensiero socialista riproponendolo sotto forma di "umanesimo” integrale; nel distacco dal marxismo, sancito a livello europeo dalla diffusione di
Au delà du marxisme del belga Henri De Man, uno dei testi più citati del periodo; infine, principalmente per il tramite di Georges Gurvitch e del suo influente
L’idée de droit social (1932), nelle idee di Proudhon sul federalismo libertario e sull’associazionismo operaio.
L’esito complessivo che emerge da queste elaborazioni assume l’aspetto di un’ipotesi sociale fondata sul rispetto per l’individuo e la libertà di sperimentazione, intesa quest’ultima come un rifiuto sistematico di soluzioni economiche, politiche o sociali statiche e dogmatiche, date da un’ideologia o determinate da una filosofia della storia o da un sistema di pensiero. Un rifiuto che si articola nella rivendicazione di un’organizzazione pluralistica della vita associata, attenta alla specificità culturale di luoghi, comunità e tradizioni, fondata quindi su una molteplicità di istituti ma anche su una molteplicità di soluzioni economiche e sociali: i libertari italiani immaginano la società libera come un insieme (più o meno armonico) di sistemi e varianti che garantiscano a singoli e gruppi la possibilità di dissentire, dubitare e scegliere. Insomma, una sorta di "società aperta”, che porta alle estreme conseguenze il relativismo storicistico ma se ne stacca per radicalità d’approccio e iconoclastia politico-intellettuale. Una "società aperta” che si situa però in un esplicito orizzonte rivoluzionario, che viene cioè immaginata come frutto di una epocale frattura nella storia e non certo come crescita graduale della civiltà liberal-democratica: di fronte ai totalitarismi e alle stesse suggestioni autoritarie apparentemente in crescita negli stati-nazione d’Occidente, l’apologia di una società libera fondata sull’accettazione dell’ethos sperimentalistico viene strettamente legata alla concettualizzazione dei mezzi e degli strumenti che dovrebbero produrre una rivoluzione politi
...[
continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!