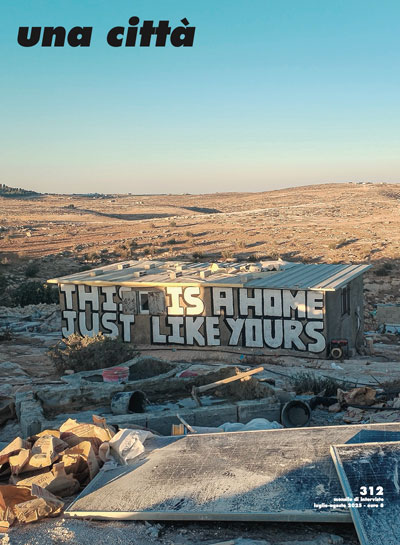Secondo Lasch sono le ideologie del progresso che individuano nel populismo l’avversario da sconfiggere; la posta in gioco riguarderebbe la modernizzazione, con il libero dispiegarsi della lotta di classe, la differenziazione del popolo in classi e lo sviluppo di una produzione ideologica, e anche letteraria, capace di rappresentare il pieno avvento della modernità, la sconfitta dei provincialismi, dei regionalismi, di ogni forma di localismo. Forse qualcuno ricorderà il libro di Alberto Asor Rosa, Scrittori e popolo (1965).
Si potrebbero sviscerare le aporie derivanti dall’uso di una categoria che assume significati diversi a seconda degli ambiti disciplinari e delle culture politiche di riferimento; mi limito invece a richiamare l’attenzione su una specifica dimensione storica, alla luce di un duplice fallimento: quello del marxismo, che non viene nemmeno più argomentato, alimentando una rimozione che avrà effetti esiziali; quello del liberalismo, che trionfa al prezzo del totale svuotamento dei suoi valori ispiratori. Alla luce altresì dell’inaspettato riaffiorare di istanze populiste, quale che sia il giudizio differenziato che ne possiamo dare, anche perché il "popolo padano” non ha nulla a che fare con i tre miliardi di contadini (donne soprattutto) alle prese con i disastri del capitalismo realizzato.
Siccome è chiaro a tutti che qualcosa non ha funzionato propongo un tentativo di rilettura, non del populismo in generale che, per la sua illimitata dilatazione risulta inafferrabile, ma del movimento e della corrente ideologica che, per prima, si è autodefinita populista, vale a dire il populismo rivoluzionario russo dell’800. Si tratta quindi di andare molto indietro nel tempo, però è innegabile l’attualità dei temi che esso solleva, anche al di là di quelli su cui mi soffermerò in questa sede: ricordo solo la questione cruciale della violenza e del terrorismo.
Un altro tema che meriterebbe di essere approfondito riguarda la collocazione di questo movimento nella storia del socialismo, o meglio la sua non-collocazione nella storia del socialismo, nonostante molti sforzi in tale direzione; penso, in particolare, al grande libro di Franco Venturi, che si poneva l’esplicito obiettivo di riportare il populismo russo (dopo gli anatemi marxisti-leninisti) nella storia generale del socialismo. Non è un interrogativo che riguardi solo gli storici. Il problema ha una diversa portata e segnala una debolezza che ha minato alle radici il socialismo e il comunismo, ovvero la loro incapacità, ideologicamente motivata, di rapportarsi in modo non strumentale o distruttivo verso il mondo contadino; un fallimento politico che ha il suo culmine catastrofico nella vicenda sovietica, con conseguenze non ancora riassorbite. In ogni caso la fine dei contadini è considerata una tappa necessaria nella marcia del progresso, perché essi sono l’incarnazione dell’arretratezza, oltre che dell’individualismo e, paradossalmente, del comunitarismo. Su questo versante si concentrano le attenzioni dei populisti russi, incontrando le difficoltà che sono al centro del pensiero e dell’arte di Herzen, Dostoevskij e Tolstoj.
Il problema del comunitarismo, ieri come oggi, è tanto semplice quanto micidiale: per realizzarsi esso presuppone che i soggetti condividano la stessa costellazione di valori e si comportino di conseguenza, pena l’emarginazione, l’espulsione, l’eliminazione dalla comunità. I peggiori esiti novecenteschi e attuali di una tale dinamica li abbiamo ben presenti.
Per uscire dalla condizione moderna, caratterizzata dal politeismo dei valori, in cui la lotta mortale tra di essi è decisa in ultima istanza dalla forza, si ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!