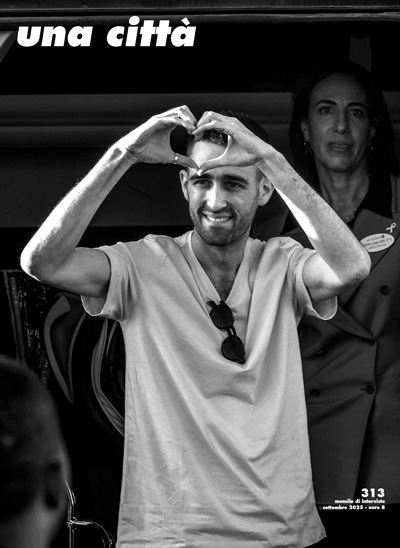Da tempo studiate il bullismo maschile e femminile, possiamo partire da un inquadramento generale del fenomeno?
Giuseppe Burgio. Partiamo dalla definizione. Il bullismo è la vittimizzazione continuata contro uno studente o una studentessa con intenzionalità e con una asimmetria di potere, fisica o semplicemente relazionale, che cristallizza le relazioni, per cui la vittima subisce sempre, il bullo o i bulli attaccano soltanto. Esiste una vastissima letteratura scientifica sul bullismo, anche in lingua italiana, ma è sostanzialmente tutta strutturata nel modo seguente: si descrive il fenomeno, anche in maniera articolata, le varie tipologie di bullo, le varie tipologie di vittime, e poi si propone un intervento educativo di prevenzione e contrasto. Tendenzialmente non c’è alcuna analisi delle cause. Cioè, il bullismo viene descritto come un dato di fatto. Non ci si chiede il perché. Il risultato è che, nonostante da ormai molti anni si facciano interventi anti-bullismo nelle scuole, il fenomeno non accenna a diminuire, anzi sembra crescere.
La nostra ipotesi è che gli strumenti educativi di contrasto, proprio perché mancanti di un’analisi delle cause, siano inefficaci, perché sono generici e non riescono ad aggredire il problema in maniera mirata.
All’interno della letteratura scientifica, però, ci sono in realtà tutta una serie di dati che non sono mai stati messi a sistema; ecco, attraverso questo paradigma indiziario si profilano una causa o più cause che abbiamo cercato di indagare.
Innanzitutto, sappiamo che il bullismo non è un atto individuale, ma è una questione sistemica, relazionale, perché nel bullismo non sono coinvolti solo il bullo e la vittima, ma anche i familiari, gli altri compagni, l’organizzazione scolastica, il contesto sociale, il quartiere, i modelli di riferimento, ecc.
Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che avviene in pubblico. Sarebbe più logico evitare di essere visti per sottrarsi alle sanzioni disciplinari, invece sembra proprio che questa visibilità sia ricercata, che il bullo abbia bisogno di un pubblico. Sappiamo poi che il bullismo diretto, cioè quello caratterizzato da violenza verbale e fisica, è in grande maggioranza agito da maschi su vittime che in gran parte sono maschi. È cioè un fenomeno intragenere (come quello femminile). Nonostante quello che viene detto di solito, cioè che il bullismo può riguardare chiunque, in realtà colpisce delle categorie di persone che sono già vittimizzate nella società, perché la scuola è dentro la società. Per cui qualunque asse di differenza su cui si innesta un’asse di discriminazione viene lì riprodotto.
Essendo un fenomeno intragenere, e sviluppandosi in maniera più violenta nella preadolescenza e nell’adolescenza, deve essere connesso alle specificità di questa fase che è legata alla soggettivazione sessuata, alla costruzione di un’identità di genere e anche alla costruzione della propria reputazione sociale.
Ultima questione, il bullismo avviene a scuola, cosa che viene data di solito per scontata. Avviene anche sull’autobus, all’oratorio, per strada, ma è in grande maggioranza un fenomeno legato alla scuola, che è oggi l’unico contesto, reale e simbolico, dove centinaia di adolescenti si vedono ogni giorno per tante ore. Ed è quindi il palcoscenico dove ci si mette in scena e dove ci si gioca la propria reputazione. La scuola non è un contesto neutro, non solo perché ci sono adolescenti, ma anche perché è un dispositivo di controllo, è un’istituzione totale, per cui i tempi, gli spazi, i corpi sono regolamentati: si va in bagno chiedendo il permesso, ecc. Ed esiste una competizione rispetto alla riuscita scolastica. A ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!