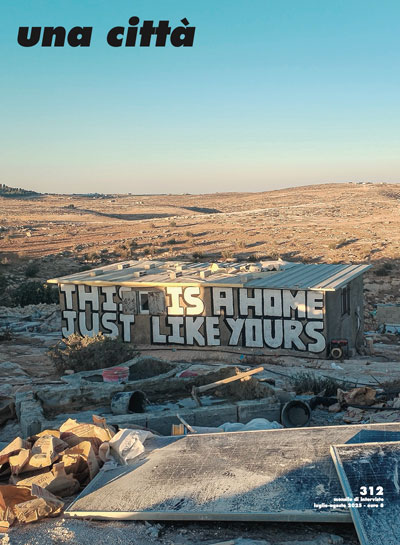Nel suo interessante articolo, Dwight Macdonald distingue: 1) una high culture, che egli inclina a identificare con 1'"avanguardia" in tutte le sue forme; 2) una popular culture for the élite, che prenderebbe la forma dell'"accademismo"; 3) una folk art, che sarebbe "l'istituzione propria del popolo" (ed è abbastanza sintomatico che a questo proposito si parli soltanto dell'arte, e non di tutto il campo della cultura: filosofia, nozioni scientifiche, norme morali, riti di socialità); e, infine, il vero problema: 4) la popular culture per le "masse", la quale sarebbe in primo luogo passabilmente "degradata" e in secondo luogo "strumento di dominio sociale", ma pur sempre "cultura", ossia una forma d'educazione della sensibilità e dell'intelligenza.
Ora, a me pare che una tale costruzione trascuri taluni dati essenziali:
1) "Popolo" e "massa" sono due realtà assai diverse. Si può accettare lo schema di Georges Gurvitch il quale, nel distinguere la "comunione", la "comunità" e la "massa" come tre forme diverse del rapporto sociale, sostiene che, nella massa, quel che importa non è il numero degli individui, bensì un certo modo di stare insieme nel quale la personalità dell'altro è totalmente ignorata e il problema sociale si riduce a quello di coordinare meccanicamente i propri movimenti a quelli degli altri: una socialità, cioè, così elementare e, al tempo stesso, così poco umana da obliterare praticamente la coscienza critica e la facoltà di scelta. Il "popolo", invece, presuppone necessariamente il permanere di una "comunità" e delle possibilità effettive di "comunione" nei riti, nelle feste, nei momenti sia di pericolo che di trionfo della comunità.
2) La massa in quanto tale, e trattata come tale da sfruttatori o da demagoghi, non è suscettibile di alcuna "cultura", in quanto la cultura esige una certa autonomia di colui che "si coltiva" o accetta di "venir coltivato". La massa non può che subire degli chocs psicologici (i quali si traducono per lo più in isteria collettiva) o degli stimoli imperiosi che la riducono alla passività totale, all'automatismo del soldato, al panico (che può anche non esser violento) e all'atonia senza rimpianti e senza speranza della bestia da soma.
3) II dressage prussiano o fascista è il contrario di una "educazione". La deformazione di un'anima secondo i metodi della pedagogia gesuita o calvinista rappresenta il pervertimento di ciò che intendiamo per opera "educativa" o "culturale". Esiste dunque — nell'ambito delle possibilità sociali — un fatto che si può chiamare "anti-cultura". E c'è anche la "incultura", quando manchi un ambiente proprio a generare uno stato di "comunità" o di "comunione". Gli eschimesi hanno una cultura; invece ciò che si racconta dei miseri abitanti della Terra del Fuoco ci fa dubitare che esistano, fra di loro, le basi elementari di una vita religiosa, estetica, o politica in senso lato. Forse non senza esagerazione, Giovenale ci mostra una plebe romana caduta preda della "incultura". Le SS e gli aguzzini di Auschwitz o di Dachau erano radicalmente immunizzati contro ogni germe di "cultura".
4) Ora, la rivoluzione industriale data in Inghilterra dal 1750 circa, ed è fra il 1840 e il 1850 che Friedrich Engels e Herman Melville ne constateranno gli effetti sulla popolazione operaia delle grandi città. Il meno che si possa dire è che questi uomini e queste donne vivevano da due o tre generazioni segregati da tutto ciò che può nutrire una "cultura": incatenati dall'età di sei anni all'inferno dell'officina, per quattordici o sedici ore su ventiquattro, non potevano conservare alcuna memoria di una folk art e di uno "stile d'esistenza" comunitario. Lo stesso fenomeno si è riprodotto dovunque s'è impiantato il capitalismo industriale. Si vedano per la Germania I tessitori di Hauptmann, per la Polonia I minatori di Tetmagr, per la Russia I costumi della via Rasteriajeva di Glieb Uspenski; e infine, per la Cina, le descrizioni delle fabbriche di tessuti di Sciangai. Parigi e Lione sembrano aver resistito meglio: nel secolo diciannovesimo, si sviluppò in quest ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!