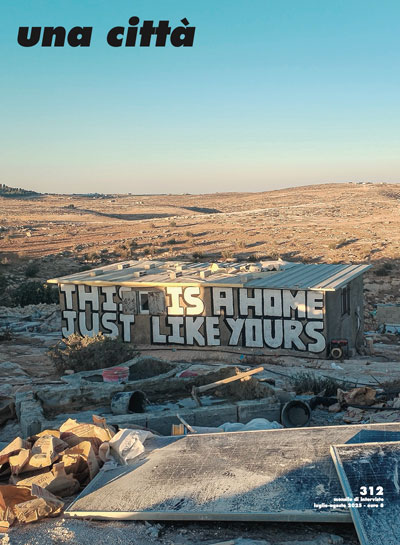Il socialismo di Andrea Caffi è una diretta filiazione dell’intellighentia rivoluzionaria russa del secolo scorso e di quella tradizione il pensiero e la vita di Caffi hanno il tratto inconfondibile. Anche nel carattere volutamente frammentario, non concluso dei suoi scritti così come nell'insistente ritorno al momento autobiografico e gli anni giovanili come esperienze decisive, vi è un segno distintivo della tradizione rivoluzionaria russa. Nato a Pietroburgo nel 1887, a 14 anni Caffi era già socialista. A 16 anni fu tra gli organizzatori del primo sindacato dei tipografi di Pietroburgo e poco tempo dopo, per aver preso parte alla rivoluzione del 1905 nelle file dei menscevichi fu arrestato e condannato a tre anni. Il problema della Russia, le vicende e il destino della rivoluzione bolscevica resteranno un punto di riferimento costante dell'esperienza intellettuale e politica di Caffi. Nonostante si rendesse conto molto bene delle ragioni che stavano dalla parte dei bolscevichi -come del resto egli stesso le aveva esposte nel saggio del 1919 «La Rivoluzione russa e l'Europa» pubblicato nella Voce dei Popoli (e sia detto qui tra parentesi, il più importante e serio scritto -secondo Piero Gobetti- che fosse fino a quel momento apparso sulla rivoluzione russa), nel trionfo dei bolscevichi egli vide «con un accoramento simile a quello provato alla scoppio della guerra, la sconfitta di quanto c'era stato di più schiettamente libertario e socialista, e anche di più europeo, nella tradizione rivoluzionaria russa quale si era iniziata nel dicembre 1825»2.
Tornato a Mosca nel 1920 si schierò dalla parte della rivoluzione e aderì alle posizioni politiche della sinistra menscevica di Martov, fautrice di un governo rivoluzionario dì coalizione dei tre partiti sovietici (social-rivoluzionari, menscevichi e bolscevichi). Non tardò ad accorgersi che la gestione del potere da parte dei soli bolscevichi portava in sé il germe dell'involuzione autoritaria del sistema sovietico e che perseguitando e costringendo all'esilio i socialisti rivoluzionari, i menscevichi e i libertari, la «dittatura proletaria» avrebbe messo capo ad un'autocrazia che era l'esatto contrario di quella società di «liberi ed eguali» in nome della quale la rivoluzione era stata compiuta.
Accusato di essere in contatto con elementi dell'opposizione menscevica e di aver dissuaso i socialisti italiani venuti a Mosca con G. M. Serrati dall'aderire alla Terza Internazionale, fu arrestato e rischiò la condanna a morte. Fu liberato grazie all'intervento di Angelica Balabanov che molto tempo dopo, rievocando quegli anni moscoviti, ha scritto di Caffi con grande calore di simpatia e ammirazione.
Più tardi, negli anni trenta, consolidatosi il potere personale e assolutistico di Stalin con quei tratti di fosca e torbida barbarie che l'uccisione di Kirov e l'ondata di terrore indiscriminato che ne seguì preannunciavano (come Caffi in una nota del settimanale Giustizia e Libertà3 fu tra i primissimi a rilevare), dell'esperienza cui era approdata la rivoluzione sovietica e il comunismo della terza internazionale, Caffi insistentemente ripeteva che si trattava della via opposta a quella che conduce alla democrazia e al socialismo, perché «nessun raggiro dialettico può nella realtà dei fatti c ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!