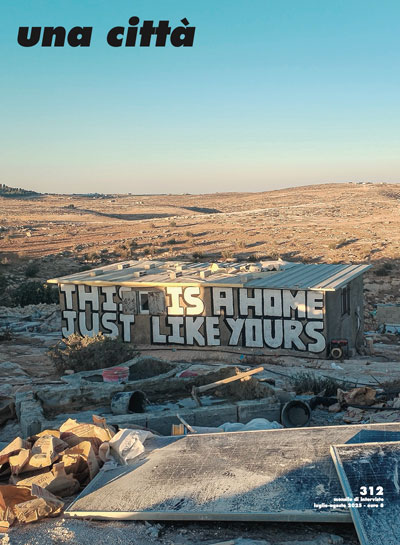O, per meglio dire, Chiaromonte non aveva avuto bisogno di farla propria quella lezione, perché la portava con sé prima di conoscere quel maestro per affinità elettiva. Era sua quando cominciava a parlare in Italia, a discutere in Italia nel periodo più intenso del fascismo, attorno al 1932 o '33. La portava con sé intensa a tal punto, che quando, portato da Vindice Cavallera a contatto con «Giustizia e Libertà», incominciò a collaborare ai «Quaderni», Caffi lo riconobbe subito come uno spirito affine, uno di coloro che (anche in quella che pomposamente si diceva la «lotta» antifascista, e che consisteva per allora nel rifiuto, nella protesta, nel cercare di tessere sottili e indistruttibili legami con spiriti affini in vista di uno scopo che pareva enorme, e mostruoso, come quello di distruggere uno stato accettato passivamente da una intera società, riluttante ma .ancora non ribelle) uno di coloro che in queste condizioni non si facevano illusioni, non fingevano sulla carta realtà che ancora non c'erano, che davano la precedenza su tutto alla disperata volontà di veder chiaro, veder chiaro con rabbia, che portavano in sé; certo la precedenza, sui gesti e sui riti della politica. Non per nulla Chiaromonte s'era scelto in Italia (già prima che l'imminenza del pericolo, con l'arresto dì Vindice Cavallera, l'obbligasse a emigrare) il nome di «Sincero»; e quando, in Francia, cominciò a dare a «G.L.» la sua collaborazione con note settimanali, intitolò quella sua rubrica «Impolitica». Non certo «Apolitica», o «Antipolitica», che sarebbero stati entrambi modi inadeguati di esprimere quel che portava dentro, che sarebbero stati scambiati per inerzia; ma «impolitica»; e cioè, realtà crudamente esposta e satireggiata al di là delle convenienze della opportunità: quella stessa scontrosa reazione di fronte al solido ostacolo che gli altri cercavano di non vedere, che ha poi sempre mantenuto, fino alla fine. Nel clima un po' semplicistico della «G.L.» di Parigi, di cospirazione ottocentesca mista a stimoli provenienti dall'attivismo gobettiano e dalla cultura crociana e a una buona dose d'attivismo libertario, quel giovane, per la diversa origine e generazione o piuttosto per l'innata originalità, portava con sé qualche cosa che testimoniava di una caduta più profonda nell'abisso totalitario, e perciò di un bisogno più profondo di ritrovare la causa e la ragione dell'agire (che fu poi quella grazie alla quale si salvarono, non tanto i giovani della «generazione fascista», quanto le ragioni di quella generazione). Era uno stimolo che portava più a fondo, mostrandone alcune inevitabili contraddizioni, lo stesso revisionismo essenzialmente attivistico di un Rosselli, che negava tutti i miti e le certezze della generazione liberale e socialista, cercando più in fondo socialismo e libertà. Per qualche mese ci fu, nella piccola organizzazione fuoruscita (e il fenomeno doveva ripetersi altre volte), una discussione accesissima, che rimetteva in discussione tutto, tutti i miti del paese, la cultura e la tradizione risorgimentale e quella rivoluzionaria, la «classe eletta» come la «massa» e mostrava a nudo quello che era parte della decadenza d'Europa. Non alla maniera apocalittica del «declino dell'occidente», ma con un richiamo umano e trascendente che il maestro in qualche modo raccordava a Piatone.
Ho detto altrove quel che, a mio parere, l'organizzazione di Ros ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!