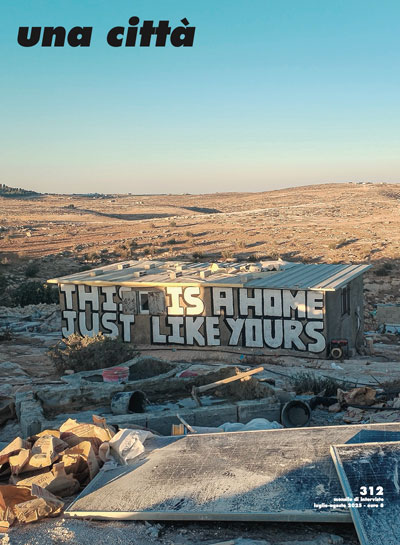Si erano conosciuti a Parigi nel 1932 e già quel primo incontro ha il tratto saliente degli eventi memorabili. Da Roma dov’era rientrato verso la fine dell’anno, Chiaromonte gli scriveva: "Mi manca del tutto il sentimento di una società di spiriti, se non con lei. Sento che vicino a lei, tutto andrebbe meglio per me: o almeno avrei un maestro nel senso piu concreto, un uomo vicino al quale mi sarebbe piu facile vincere la sfiducia e la desolazione”.
Caffi, d’altra parte, riconobbe subito in Chiaromonte uno spirito affine giacché nell’irrequietudine intellettuale di quel giovane c’era l’affermazione della qualità in qualche modo morale dell’intelligenza e la conferma -per diria con Charles Peguy- che anche per un intellettuale "niente è più importante di una vita che rigorosamente si giuoca una volta sola”. All’origine della rivolta di Chiaromonte contro la dittatura mussoliniana c’era qualcosa di più e di diverso rispetto alle motivazioni ideologiche dell’antifascismo ufficiale: il disgusto per la costrizione e per la brutalità meccanica, un’insofferenza di tipo esistenziale che lo rendeva fisicamente incapace di adattarsi a un mondo (e quindi non già soltanto al regime fascista) che gli dispiaceva profondamente per la "sua assenza di valori d’ordine, di forma, di razionalità", la convinzione ragionata, infine, che ogni idea per essere vera, in ultima analisi, deve essere coerentemente vissuta.
E anche in questo aspetto della sensibilita di Nicola, Caffi riconobbe subito un’affinità elettiva.
Nelle interminabili discussioni che negli anni trenta agitavano gli ambienti dell’emigrazione antifascista a Parigi sulle forme di azione di un movimento rivoluzionario, le opinioni di Caffi e Chiaromonte erano evidentemente eterodosse: "per riconoscere un rivoluzionario -scrivono - vogliamo sapere come agisce non colle ‘posizioni’ ma con gli Uomini”.
Di fronte alla crisi che scuoteva la società europea e si estendeva anche ai "valori culturali”, alla degenerazione della rivoluzione russa, all’avvento dei totalitarismi, alla meccanizzazione brutale della società, cominciare "a pensare fuori dalla politica” divenne il programma di questi neo-illuministi. Caffi pensava socraticamente con gli altri e per gli altri, non scriveva saggi o articoli per pubblicarli ma lettere e note agli amici per chiarire od approfondire qualche punto che era stato sollevato nella conversazione (e soltanto per la grande insistenza degli amici alcune di queste lettere o note apparvero sul settimanale e nei Quaderni di Giustizia e Libertà). "Il discorso” che Caffi pianamente faceva era quello di un filosofo antico intento a ricostruire l’immagine di un mondo scisso e frantumato. Il ritorno a Proudhon voleva essere un ritorno "alla filosofia religiosa del popolo”, a un’idea della Giustizia intesa come facoltà che ci permette di "sentire il nostro essere negli altri”. Alla credenza di un progresso lineare indefinito Caffi e Chiaromonte contrappongono la tradizione del socialismo cosiddetto utopistico e la convinzione che "la società umana costituisce un problema sempre presente e sempre risorgente, il quale potrà o non potrà avere una soluzione finale, ma esige ad ogni modo di essere tenuto aperto attraverso tutte le vicende della storia”. Bisognava mettersi fuori dalla politica giacché ritenevano futile "organizzare la Repubblica quando il problema era organizzare la società”.
L’esempio di Platone suggerisce che "con le città corrotte non c’è nulla da fare” e che ci sono momenti nella storia "in cui è ragionevole e lungimirante abbandonare ogni speranza di risultati immediati e massicci”. Ma mettersi fuori della politica non implicava anche mettersi in un punto in cui si rifiutano tutti i principi di corruzione, possibile soltanto con un "ascetismo” senza riguardi per una quantità di cose che in un’altra prospettiva appartengono alla "civiltà” e alla "cultura”? Su un piano astratto e intellettualistico poteva esserci contraddizione, ma su un piano esistenziale no "giacché non si tratta affatto di ‘valori’ ma di moeurs, di influenza diretta e di scoperta di modi di essere”.
C’è un aspetto ulteriore e più vasto nella loro "descrizione della crisi”: la crescente frantumazione de ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!