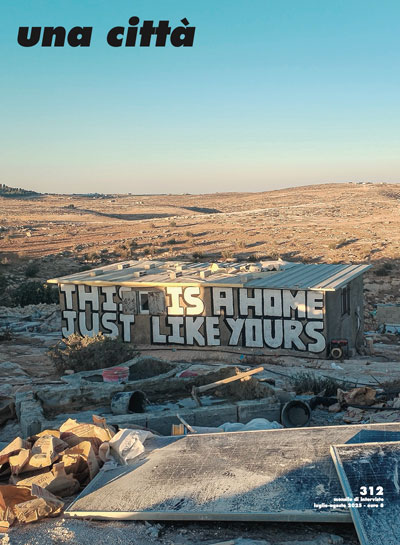Nelle stanze in penombra di "Tempo presente”, dal parquet scricchiolante, si respirava un’aria cosmopolita, e quindi più attraente agli occhi di chi avvertiva il fascino di taluni scrittori. Passavano, visitors eccellenti, Mary McCarthy, Lionel Trilling, Dwight Macdonald e altri che Chiaromonte aveva conosciuto a New York, al tempo in cui, esule antifascista, sbarcato nel Nuovo Mondo dopo le tappe di Parigi, Tolosa, Algeri, Casablanca, lavorava all’"Italia Libera” di Gaetano Salvemini e collaborava alle pubblicazioni della sinistra intellettuale, da "Atlantic Monthly” a "Politics”, da "The New Republic” a "Partisan Review”. E passavano anche Stephen Spender e Francine Camus, conosciuta ad Algeri, nel 1941, insieme al marito Albert, l’autore dello Straniero.
Silone e Chiaromonte non brillavano per abitudini mondane. A tu per tu con gli altri si concedevano frugali arguzie, misurate ironie, e la McCarthy ha ricordato frivolezze, allegrie, divertimenti di Nicola durante il periodo newyorkese, nella casa vicino a Washington Square e nelle vacanze estive sulla spiaggia di Cape Cod. Al di là del carattere, la loro storia personale suscitava nei più giovani una distanza rispettosa e ammirata: il narratore dei "cafoni” di Fontamara per la sua drammatica vicenda politica nell’internazionalismo comunista, segnato per sempre dal lutto del "dio che è fallito”; l’intellettuale anarchico e libertario, diviso fra il pensiero e l’azione, per un cosmopolitismo non provinciale, per l’esperienza di combattente antifranchista nei cieli di Spagna con la squadriglia aerea di André Malraux, e già eletto a figura letteraria sotto le spoglie di Scali nel romanzo L’Espoir.
Due miti insomma, la cui blindata discrezione e un ben riposto snobismo da una parte, l’indifferenza -ricambiata- della sinistra più settaria dall’altra, non lasciarono che assumessero le dimensioni pubbliche che meritavano. E si può affermare, senza tema di smentite, che al cospetto di Chiaromonte e Silone, oggi, allo sguardo del postero, celebrità dell’epoca si sono sbriciolate nel nulla.
Nicola Chiaromonte (nato a Rapolla, Potenza, nel 1905, morto a Roma nel 1972) è stato un saggista parco ma incisivo, colpevolmente trascurato dalla cultura italiana (come in anni non sospetti ripeteva di continuo Vittorio Saltini, studioso di Estetica e romanziere). Quasi tutti i suoi libri sono stati pubblicati postumi. Una trascuratezza che ancora perdura: il suo ricchissimo epistolario nel Fondo Chiaromonte alla Yale University è sempre in attesa di un editore. I suoi interessi spaziavano dal cinema al teatro (di teatro si occupò per "Il Mondo” di Mario Pannunzio, per "L’Espresso”, nei volumi La situazione drammatica, Bompiani 1960, e Scritti sul teatro, Einaudi 1976), dalla filosofia alla letteratura, dall’arte alla politica, come dimostrano in parte i ventiquattro saggi confluiti in Il tarlo della coscienza (a cura di Miriam Chiaromonte, introduzione di Gustaw Herling, il Mulino 1992), già editi in periodici vari e in precedenti antologie. Come questo, i titoli dei suoi libri gli somigliano, riflettono il suo carattere, il suo profilo intellettuale: Credere e non credere (il Mulino 1971), Silenzio e parole (Rizzoli 1978).
La scrittura sobria, affilata sui modelli classici, a cominciare dai greci, si abbandona di rado a sussulti e inarcature di stile, ed è disseminata di gemme concettuali taglienti, soprattutto per quel che riguarda gli aspetti della modernità nell’arte e nel costume di cui Chiaromonte addita gli insidiosi meccanismi, i falsi idoli, le ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!