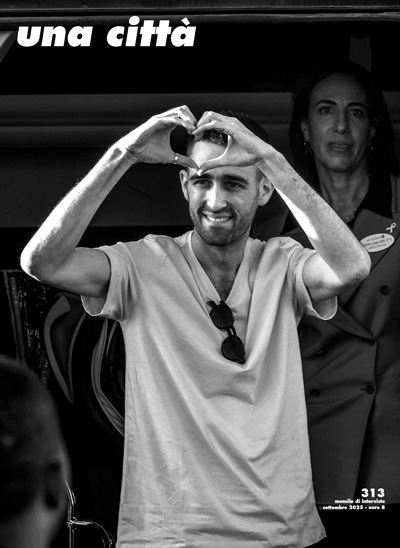Anna Foa
Grazie a tutti per avermi invitata in questa ricorrenza così importante. Uno dei temi forti oggi è proprio come ricordare. Oggi noi commemoriamo questa strage e vorrei sottolineare che questa è una strage di ebrei e partigiani insieme. Non è così ovvio, perché normalmente gli ebrei venivano mandati nei campi e i partigiani venivano fucilati. Per esempio, quando Primo Levi venne arrestato pensò fosse meglio dire di essere un ebreo piuttosto che un partigiano perché era stato emesso un bando che prevedeva la fucilazione immediata dei partigiani. Gli ebrei normalmente furono inviati ai campi, poi uccisi nelle camere a gas; invece la Resistenza venne trattata in un altro modo, i partigiani furono imprigionati o torturati o subito uccisi. In questo caso, forse per la fretta, forse per il fatto che non era più possibile inviare i prigionieri (nell’ottobre le strade verso Auschwitz già si erano chiuse), si verifica questa mescolanza e questa sorte comune per i partigiani e gli ebrei. Questo mi sembra interessante perché ci toglie un po’ dall’ottica in cui la Shoah è sempre una cosa assolutamente unica e tutto il resto, compresi gli altri genocidi, sembrano non avere esistenza rispetto a quella. Personalmente sono molto critica e dubbiosa sull’unicità, a differenza che sulla specificità, e anche su come questa unicità è stata usata nel corso degli ultimi vent’anni, in particolare da Israele, che ne ha fatto una specie di gabbia identitaria. Per cui trovo che sottolineare tutti i casi in cui ci sono state delle uccisioni comuni, in cui gli ebrei hanno subìto la stessa sorte della Resistenza, in cui i resistenti hanno avuto la stessa sorte degli ebrei, è utile anche per i ragazzi, perché elimina questa specie di aura di sacralità, che a mio avviso può essere anche estremamente pericolosa. Lo vediamo in quello che succede oggi.
Noi siamo di fronte al problema grande su cosa e come ricordare. Il prossimo 27 gennaio sono stata invitata al Comune di Bari e mi sto già ora domandando cosa potrò dire, perché le domande che mi verranno poste saranno sul come ricordare. E allora, proprio per la difficoltà di individuare un modo, per non dire -come fanno le comunità ebraiche- che non si parla dell’oggi, avevo pensato di riflettere su una delle grandi conquiste del Dopoguerra, cioè il diritto internazionale. Riflettere su come questo diritto si sia creato, trasformato e di come adesso sia sotto attacco. Di solito nelle scuole e con i ragazzi è molto raro che si affrontino questi temi di giustizia internazionale, che si parli di come sono le corti penali e di come funziona la giustizia internazionale. Ma noi oggi ci troviamo continuamente a fronteggiare questi problemi perché l’accusa di genocidio fatta dal Sudafrica davanti alla Cpi, alla Corte dell’Aja, evidentemente richiede degli organismi che la analizzino.
Ora io non mi soffermerò su questo, anche perché me ne manca la competenza. Vorrei solo dire che né Israele né gli Stati Uniti né la Russia hanno mai aderito a queste corti internazionali e allo Statuto di Roma, per tutta una serie di motivi che riguardavano la loro politica. Fra l’altro c’erano delle risoluzioni dell’Onu che già imponevano a Israele l’abbandono e la restituzione dei territori occupati; risoluzioni che sono sempre state lasciate cadere nel vuoto. La risoluzione degli anni Settanta, invece, che equiparava il sionismo al razzismo, è stata poi modificata e annullata dallo stesso Onu. Anche questo è bene dirlo quando si parla con i ragazzi. Anche se oggi tutto ritorna un po’ in discussione.
Siamo in un momento molto complicato, ma non confuso, perché non credo che ci sia confusione quando si vedono le immagini di uno sterminio, di una distruzione come quella che sta avvenendo a Gaza; quando si vedono le immagini di palestinesi o di beduini nella Cisgiordania, aggrediti dai coloni e dall’esercito. Non credo si possa parlare di confusione, ma di qualcosa che supera le nostre capacità di attesa. Ci aspettavamo un mondo, che non solo si reggesse sulla pace, ma anche su tutta una serie di principi che erano quelli di giustizia; quello che è stato fatto nel Dopoguerra con il diritto internazionale andava proprio in questa direzione.
Non si possono abolire le guerre, le guerre sono difficili da eliminare, però si possono rendere più umane. Si può imporre che l’uccisione volontaria di civili sia punita dal diritto internazionale; si può affermare che una guerra che fa dei civili il propri
...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!