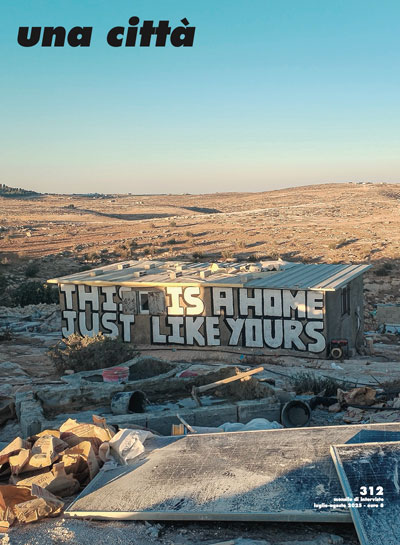Quando le nostre alunne vogliono significarci che non sono venute a scuola per poter fare i servizi domestici, fanno un ampio gesto col braccio che mima lo svuotamento a terra di un’intero recipiente di detersivo. A ben vedere lo stesso gesto potrebbe rappresentare anche un altrettanto generoso spargimento di benzina a terra; lo scopo non sarebbe poi tanto diverso: purificazione e distruzione. Lo sporco deve essere espulso, finché non ne rimanga traccia dentro la casa. Sto parlando delle case “sottoproletarie”, nella loro stragrande maggioranza. La stessa ossessione espulsiva è vigente nei confronti di mosche e altri insetti, del sudore, degli odori (a questi ragazzi, ad esempio, è difficilissimo far fare esercizio fisico, perché non tollerano di sudare). Contemporaneamente, gettano ogni cosa nello spazio esterno a sé. L’essenziale è che sia “fuori”.
Le colline di monnezza che stanno modificando il paesaggio urbano sembrano avere l’effetto di moltiplicare anziché attenuare questo furore espulsivo. Come se la crescita della volumetria dei rifiuti funzionasse da controprova di quanto le case e le persone siano pulite.
Nella mia lontana infanzia le prime immagini libresche della città di Napoli sono state collegate allo sporco, a cominciare dal Renato Fucini di Napoli ad occhio nudo, e via via tutte le altre descrizioni di una miseria localizzata principalmente in abitazioni buie, piccole, fetide e sovraffollate di corpi umani e relativi rifiuti. Corollario inevitabile: il colera. Le denunce di Pasquale Villari (Lettere meridionali, 1878), circostanziate da meticolose visite nei vicoli e nei bassi, vennero definite dall’avvocato capo del comune di Napoli fantasie ed esagerazioni -un’offesa all’immagine della città, nel linguaggio odierno- finché scoppiò, per l’appunto, il colera. Così come di nuovo un centinaio di anni dopo, e fu allora che -divenuta nel frattempo cittadina di Napoli- vidi per la prima volta quell’ampio gesto di rovesciare interi contenitori (nella fattispecie lo strumento dell’ansia disinfettante e purificatrice era l’amuchina).
Se qualcuno si prendesse la briga in questi giorni di analizzare quartiere per quartiere i mucchi di rifiuti e i comportamenti delle persone nei loro riguardi otterrebbe il ritratto antropologico e sociale più dettagliato di questa città. Mi è stato riferito di rioni nei quali la gente si sta organizzando per la raccolta differenziata; non so che dimensioni abbia questa realtà, ma è benedetta: probabilmente è la prima volta che queste persone entrano in contatto fisico con la “parte sporca”, la manipolano, la rimettono in circolo risanandola. Penso che la maggioranza stia semplicemente ad aspettare che qualcuno faccia sparire la monnezza, non fa niente se non semplicemente spostarla un po’ più in là. L’essenziale è non vederla; fanno pensare a Piaget e allo stadio evolutivo in cui il bambino -attorno ai diciotto mesi di età- compie la rivoluzione cognitiva consistente nella conquista della permanenza dell’oggetto: anche quando non lo vedi più, sai che esiste perché tramite il pensiero gli hai dato sostanzialità e localizzazione. Pare che il problema dei rifiuti -e non solo a Napoli- trascini la gente ad una massiccia regressione, convincendola che, dal momento che non li ha più sotto gli occhi, non esistono.
Quelli per i quali l’essenziale è che i rifiuti stiano “fuori” , e se sono visibili è una buona ragione per aumentarne il volume, sono i diretti discendenti di quelli che con i rifiuti hanno coabitato per tanto tempo, e che come rifiuti sono sempre stati trattati. Il ragazzo che dieci anni fa ci disse “spendite tanti soldi pe’ munnezza comme nuje!” aveva una casa luccicante di pulizia ed era, come gli altri, un consumista coatto. Successivamente ha fatto in modo da mettere in pratica il concetto che aveva di se stesso.
Carla Melazzini
dalle città, cosa sta succedendo

Una Città n° 153 / 2008 Febbraio
Articolo di Carla Melazzini
LETTERA DA NAPOLI
Intervento di Carla Melazzini
Archivio
Risposte degli studenti di Carla Melazzini
Una Città n° 35 / 1994 ottobre
DOMANDE
1- Quante persone sono morte, a partire dal 1980, in Sicilia, Campania, Calabria, a causa delle organizzazioni criminali?
2- Elenca i settori di attività di tali organizzazioni che conosci.
3- Quale è, secondo te, il l...
Leggi di più
SE SENTIRETE ANCORA PARLARE DI PONTICELLI...
Una Città n° 157 / 2008 Giugno-Luglio
Stiamo tornando a pessimi accordi nell’uso del linguaggio: parole di significato incerto vengono giorno dopo giorno appesantite da un alone magico-esorcistico che le rende tanto più pericolose quanto più indefinite e indifferenziate. Sicurezza, prima di t...
Leggi di più
DOVE VIVERE NON E’ BELLO
Una Città n° 54 / 1996 Novembre
Perché il senso della propria inadeguatezza non diventi frustrante fino alla paralisi, penso che sia opportuno cercare di farsi un’idea della dimensione dei problemi in campo. Mi pare che una rappresentazione utile potrebbe essere quella di immaginare dei...
Leggi di più
Lo scarrafone
Una Città n° 251 / 2018 agosto-settembre
Questo saggio è disponibile nel libro Almanacco delle buone pratiche di cittadinanza I - ed. Una città, 2004
...
Leggi di più
I NOMI DEL MAESTRO
Una Città n° 38 / 1995 Gennaio-Febbraio
LyceumE’ stata quasi commovente la sollevazione di un popolo di ex-liceali -allo stato presente dottori a vario titolo- in difesa dell’inestimabile Istituto minacciato di estinzione, per la verità solo nel nome. Avendo frequentato un decorosissimo liceo d...
Leggi di più