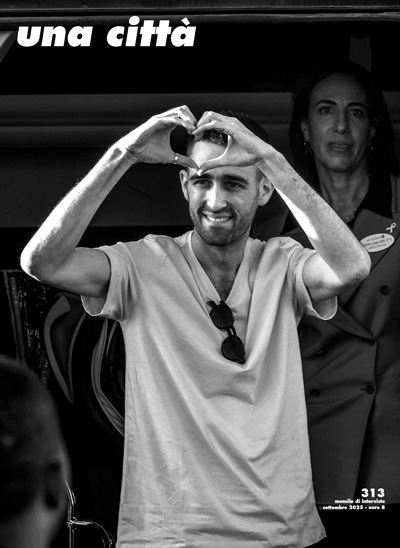Nel gruppo puoi anche piangere
buone pratiche di cittadinanza
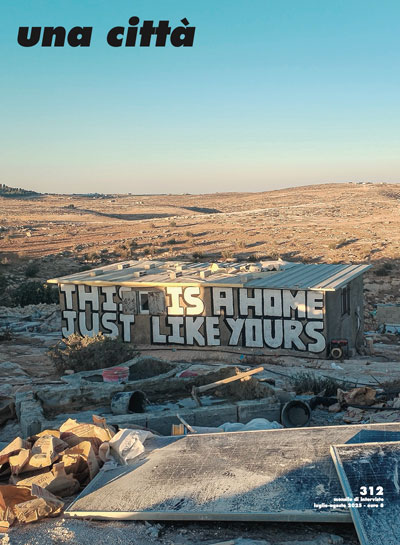
Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto
Intervista a Antonella Cornale
Realizzata da Barbara Bertoncin
NEL GRUPPO PUOI ANCHE PIANGERE
Un’associazione per accompagnare chi si trova a fronteggiare un disagio, quello legato ai disturbi dell’alimentazione, che travolge intere famiglie e che lascia i genitori disorientati, quando invece proprio il fattore tempo è cruciale per avviare un percorso efficace. I tanti errori che si commettono e l’importanza di un luogo in cui poter confrontarsi con chi è nella stessa situazione. La dignità della salute mentale. Intervista ad Antonella Cornale.
Antonella Cornale è presidente dell’Associazione Midori, fondata nel 2015 da genitori e famiglie di persone con disturbi della nutrizione e della alimentazione. Oggi opera principalmente nel territorio di Vicenza e della sua provincia.
Puoi raccontare dell’associazione?
L’associazione è nata dieci anni fa. Eravamo cinque famiglie con le figlie nello stesso centro di cura. L’idea è arrivata anche su sollecitazione dei terapeuti, per fornire un aiuto alle famiglie e venire incontro al nostro bisogno di informazioni e condivisione di percorsi. Volevamo essere una sorta di ponte tra un’assenza totale di informazioni e almeno un orientamento su dove andare e cosa fare rispetto ai disturbi alimentari. È molto importante che un genitore, nel momento in cui si accorge che qualcosa non va, non perda tempo prezioso. Purtroppo, i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, quando diventano evidenti, sono già presenti da un po’. All’inizio noi genitori non ci rendiamo conto di nulla e quando poi cominciamo a capire, rimaniamo scioccati e sconvolti. Una volta che si conosce la malattia, che si capisce come funziona, capita di andare a ritroso e individuare la presenza di alcuni segnali di allarme.
Queste sono patologie che coinvolgono molti aspetti della persona, non solo l’alimentazione pura, ma anche la mente, il comportamento, i pensieri, che sono la parte più difficile da modificare. Infatti il recupero, nella persona che ne è affetta, avviene in due fasi distinte. Dapprima c’è il recupero dell’alimentazione e poi quello dei pensieri “sani”. Quest’ultimo è molto più lento e difficile da ottenere. Ecco perché il tempo della cura è molto lungo.
Ecco, noi, come genitori, all’epoca abbiamo pensato che, con un’associazione, avremmo potuto aiutare altre famiglie. Ovviamente non siamo medici, siamo solo persone che hanno attraversato questa esperienza, però possiamo dare indicazioni su dove cercare aiuto, poi saranno gli specialisti a formulare una diagnosi.
La nostra associazione ha prevalentemente lo scopo di supportare le famiglie, sensibilizzare l’opinione pubblica, creare rete, con il territorio, le scuole, le istituzioni, ecc.
Come avete visto cambiare questi disturbi negli anni?
Il nostro obiettivo è anche quello di aumentare la conoscenza di questo spettro di disturbi, così che sia più facile chiedere aiuto e di conseguenza arrivare in tempo. Spesso si pensa che solo le persone estremamente magre possano avere questo tipo di problema. Ma non è sempre così, ci sono persone che soffrono di bulimia e nessuno se ne accorge perché sono normopeso.
Una volta i disturbi alimentari erano più puri, c’erano casi di sola anoressia o sola bulimia, adesso invece ci sono anche altre patologie associate, ad esempio ci può essere qualcuno che soffre allo stesso tempo di anoressia e bulimia, e a queste si possono aggiungere depressione, disturbi della personalità, bipolarismo ecc...
Ultimamente, si è molto abbassata l’età di esordio e c’è un coinvolgimento maggiore dei maschi. Ci sono ora pazienti con un’età che va dai dieci, undici anni fino a oltre i cinquanta. Questi disturbi non nascono per una causa specifica, ma per un insieme di situazioni; a volte c’è anche forse una predisposizione genetica.
In certo momento della propria vita, sia una ragazza giovane che una persona adulta, può incontrare una difficoltà che viene avvertita come enorme, inaffrontabile e spesso questo sfocia nel disturbo alimentare. Ci si sente talmente non idonei, inadeguati… Siccome l’unica cosa su cui si può esercitare un controllo è il proprio corpo e le sue reazioni, ci si concentra su quello. Se riesco a non mangiare, cioè metto in atto una restrizione, e vedo che ce la faccio, quella cosa mi dà una grande gratificazione.
Infatti all’inizio chi soffre di disturbi della nutrizione non riconosce la propria malattia, perché in realtà avverte il proprio comportamento come una soluzione. Anche visivamente, c’è come una distorsione della propria immagine corporea: continuo a guardare in modo specifico e ossessivo alcune parti del mio corpo, fino a che il mio cervello non mi fa più percepire realmente le immagini, per cui continuo, ad esempio, a vedermi con dei fianchi enormi, quando non lo sono affatto.
Ora, è chiaro, che tutto questo non può certo essere risolto dalle parole di chi ti dice che non è così. Servono un percorso e un trattamento terapeutico mirato anche sull’immagine corporea.
Quello che ci teniamo a dire è che, per questi disturbi, esistono i terapeuti, esistono le cure, è importante sapere che è una condizione reversibile. Certo non bisogna affidarsi a persone che non sono competenti perché, ripeto, più si perde tempo, più la malattia mette radici e così sarà sempre più difficile uscirne.
Noi in provincia di Vicenza siamo fortunati perché abbiamo dei buoni servizi pubblici. Per molte province e regioni d’Italia non è così. Siamo anche una delle regioni che ha più associazioni, quasi in ogni provincia. Chi non ha queste possibilità, rischia di doversi spostare in un’altra regione, situazione che per le famiglie è veramente drammatica.
Stare accanto a chi sta male non è facile. Quali sono gli errori più comuni che si commettono?
Stare vicino a una persona che ha questi problemi è molto stancante. Il percorso è lungo e impegnativo; se poi l’accesso alle cure costringe ad allontanarsi dalla propria città, questo destabilizza tutta la famiglia. Quando arrivano queste problematiche, la famiglia ne viene letteralmente travolta, perché la compromissione del fisico, del tono, dell’umore è molto pesante e costringe tutti a cambiare.
Le stesse parole che noi diciamo vanno scelte con cura, perché anche se dietro ci sono le migliori intenzioni, possono mettere a repentaglio il lavoro terapeutico.
Per dire, una domanda che spesso si fa a chi soffre di questi disturbi è: “Ma cosa ti manca?” ed è una domanda sbagliata, perché non è che manca qualcosa, il problema è che ci si sente inadeguati. Questo tipo di disturbo è molto democratico: non conta la condizione sociale, l’istruzione, è un disagio che azzera tutto.
Oppure quando una persona ti confida che si vede grossa e tu rispondi di no, che è normalissima, ma lei ti ha detto che si vede così, non che lo è. Ancora, si accusa chi non mangia di essere una persona ingrata, perché al mondo ci sono tante persone che muoiono di fame. Ma così si colpevolizza inutilmente chi comunque non lo sta facendo apposta.
A volte capita che queste ragazzine giovani improvvisamente non vogliano più uscire. Rifiutano di stare in mezzo agli altri e tutte le situazioni conviviali.
Ecco, spronarle ad andare a prendere un gelato, “così socializza” vuol dire chiedere loro qualcosa di impossibile.
Oppure la frase: “Da te mi aspettavo di più”, che una ragazzina in difficoltà traduce con “Non valgo nulla!”. O ancora gli apprezzamenti sull’aspetto fisico che enfatizzano un “troppo”, troppo bassa, troppo alta, troppo seno...
Insieme ai gruppi di auto aiuto del Veneto, anni fa abbiamo stampato un libretto, intitolato proprio “Senti chi sparla”, tutto incentrato sulla comunicazione, in cui abbiamo raccolto tutte quelle frasi che a nostra volta abbiamo pronunciato; spesso sono le frasi più comuni.
Chi si rivolge a voi?
In genere i genitori, ma negli ultimi anni, con l’aumento dell’età in cui compaiono questi disturbi, anche mariti, compagni, perché si accorgono, che la persona che hanno a fianco non sta bene. Ultimamente, abbiamo avuto anche qualche caso di ragazze giovani che hanno chiesto aiuto in prima persona.
Va detto che spesso i giovani non vengono accompagnati dai genitori. Magari confidano questo loro malessere a qualche insegnante o a qualche istruttore sportivo.
A me è capitato di ricevere una persona con il proprio allenatore perché aveva paura di coinvolgere la famiglia. Poi noi l’abbiamo aiutata a parlare con i genitori che non si erano accorti del suo stare male.
Da noi comunque arrivano in modo prevalente i genitori o perché non hanno capito bene di cosa si tratta e hanno bisogno di ricevere informazioni, oppure perché magari, sempre tramite il lavoro sulla sensibilizzazione che svolgiamo anche nelle scuole, qualche insegnante si è accorto di qualcosa e li ha consigliati di prendere contatto con noi.
Abbiamo fatto un grande lavoro di formazione per gli insegnanti, copriamo tante scuole; è una parte del nostro lavoro molto importante perché i ragazzi trascorrono tantissime ore a scuola, l’insegnante li incontra e sta con loro tutti i giorni, li vede crescere, trasformarsi. Bisognerebbe fare di più. Rispetto al passato, ora i genitori sono meno presenti in casa per problemi lavorativi, così spesso i ragazzi a pranzo sono soli.
Quali sono le varie forme di disturbo alimentare?
Abbiamo anoressia e bulimia. In entrambe, c’è la paura di ingrassare e il cibo viene visto come un nemico. A volte la bulimia è più insidiosa, più difficile da individuare perché la ragazza può essere normopeso. Nella bulimia un genitore può però trovare in casa dei segni, che possono essere residui di vomito, involucri di cibo, cartocci nascosti negli armadi, dentro le scarpe, negli zaini, in posti impensabili. Oppure possono verificarsi sparizioni importanti di cibo. Spesso queste persone, per mascherare il disturbo, si sottopongono a una iperattività fisica. La bulimia è caratterizzata dall’abbuffata, che è una perdita del controllo: si mangiano diversi tipi di alimenti, cotti, crudi, surgelati, tutti insieme, salvo dopo sentirsi malissimo perché si è pieni, quindi si ha bisogno di svuotarsi e le modalità per farlo sono il vomito indotto, i lassativi e l’iperattività fisica. Solo che dopo rimane il senso di colpa, quindi tutto questo viene fatto di nascosto. Diversa la dinamica nell’anoressia: la persona che ha questo disturbo, va a tavola insieme agli altri, ma non riesce a mangiare. Quello che accomuna questi disturbi, e di cui inevitabilmente ci si accorge, è il cambiamento del tono dell’umore. Con mia figlia, per esempio, questo mutamento è stato un indicatore, più che il dimagrimento: era diventata triste e si isolava.
Qual è il problema? Che le persone appunto, non rendendosene conto per tempo, arrivano tardi alla diagnosi e oggi sappiamo che la bulimia causa i danni maggiori agli organi interni, come sovraccarico del cuore, problemi legati all’esofago, allo stomaco, corrosione dei denti. Ci sono conseguenze gravi anche nella anoressia, che può perfino portare alla morte, però nella bulimia gli effetti sono mediamente peggiori proprio perché si rivela tardi, quando i problemi creati sono più difficili da risolvere.
Dicevi prima che le famiglie vengono travolte. Cosa intendevi?
Ti capita una cosa di cui non sai e non capisci nulla, e di fronte alla quale sei totalmente impotente, perché fino a che non incontri dei terapeuti che prendono in mano la situazione e ti indirizzano, da solo non puoi risolvere nulla. La tua vita viene travolta perché all’improvviso non sai più cosa fare, come comportarti, hai questa persona che sta male e non puoi fare niente, devi stare attenta alle parole, i rapporti con gli altri diventano difficili, perché c’è ancora un senso di vergogna, di pregiudizio.
Inoltre parliamo di un percorso di cura che è molto lungo. Se anche hai la fortuna che tua figlia o tuo figlio vengano presi in carico, poi c’è un piano alimentare da seguire, devi preparare tutta una serie di cibi, che all’inizio la persona ammalata non mangerà e così sei continuamente sottoposto a enormi frustrazioni, con tutto quello che ne consegue. Pensi: “Ma cosa le costa mangiare quei pochi grammi di pasta?”. Senza capire che per lei è una fatica enorme e che lo farà, ma solo quando avrà gli strumenti necessari.
In passato, si imputava l’origine di questi disturbi al rapporto con la madre...
Oggi non più. Il disturbo alimentare arriva per un insieme di fattori di rischio e non per colpa della madre. Probabilmente quella era una semplificazione perché tradizionalmente era la mamma a preparare da mangiare, a stare più vicino ai figli e quindi nasceva un conflitto. Tra l’altro, spesso si creano situazioni spiacevoli anche con i nonni. Potete immaginare, per loro è un affronto se la nipote va da loro e non mangia. Un classico: la nonna prepara il pasticcio... per la ragazza è una tragedia! Cioè il pasticcio è una di quelle cose che non verrà mai mangiata da chi è affetto da disturbi alimentari. Nella sua testa scatta immediatamente la domanda relativa a chissà cosa c’è dentro, quanto olio, quanto burro, quante calorie... la persona ammalata va veramente in tilt. E la nonna, poveretta, ovviamente ha preparato il pasto con le sue migliori intenzioni, perché una volta a sua nipote quel cibo piaceva tanto. Ecco perché abbiamo organizzato anche dei corsi per i nonni.
Poi c’è il tema dei fratelli, che in genere sono più piccoli. Una famiglia viene talmente assorbita da questo disturbo che fatica a reggere il quotidiano e questo rischia di avere delle ripercussioni sugli altri membri. Infatti è importante fare interventi anche sugli altri figli. Ci sono capitati casi in cui un fratellino diceva: “Devo ammalarmi anch’io perché tu ti accorga che esisto?”, perché il genitore appunto è travolto, è più forte di lui.
Quindi io mi sento di spezzare una lancia in favore dei genitori, che vengono attraversati in tutti i modi da questa malattia, e sono costretti a costruirsi una specie di armatura per potersi difendere...
Sono percorsi che durano per anni: una volta iniziato il lavoro terapeutico, non è detto che poi vada tutto liscio e che nel giro di poco si stia bene. I tragitti sono altalenanti, qualcuno va bene per un po’ di tempo, poi c’è una ricaduta, poi si ritorna a stare bene. Ci vuole del tempo per uscire da questo disturbo.
Quindi il genitore viene molto provato. Noi organizziamo dei gruppi di auto aiuto. Una volta venivano solo le mamme, ora invece vengono anche i papà e verifichiamo che c’è una differenza di accettazione. I papà fanno più fatica a dire: “Mia figlia ha questo problema”. Pensano che sia impossibile.
Puoi parlarci della componente maschile che viene colpita da questo disturbo?
I casi sono in aumento, adesso siamo su una percentuale del 7%. I maschi presentano gli stessi disturbi, ma si approcciano in modo diverso, si nascondono di più tramite lo sport, sono quasi sempre iperattivi.
Si parla molto del ruolo dei social...
Un’altra cosa che ci tengo a dire è che l’aumento dei casi non è imputabile ai social, come invece molti affermano. Questi disturbi ci sono da molti anni. Sappiamo che l’anoressia ha un’origine che risale molto indietro nel tempo. La bulimia invece è stata diagnosticata più tardi, negli anni Settanta, quindi ha una storia più recente. Oggi qual è la differenza? Che se una volta lo sapevi dai giornali o dalla Tv, perché qualche modella ne era affetta, ora invece sono i social a trasmettere l’informazione. Ci sono addirittura degli influencer sui disturbi alimentari. Non lo fanno per un guadagno economico, però quello che fanno è terribile. Dietro non c’è infatti uno scopo educativo, informativo nel senso buono; non è un modo per condividere e per fa sì che altri non ci caschino dentro. Tutt’altro: queste ragazzine mostrano con soddisfazione quante ore di attività fisica fanno; alcune arrivano a farsi vedere con il sondino, mentre sono in ospedale. Queste cose certo non aiutano, occorre stare molto attenti. Detto questo, non sono i social ad aver portato a un aumento dei casi, e nemmeno la pandemia. Perlopiù parliamo di persone che già stavano male, dopodiché il Covid ha fatto esplodere la situazione. Durante il lockdown siamo stati tutti costretti a rimanere chiusi in casa. Immagina cos’ha voluto dire per una persona con questi disturbi, all’improvviso senza alcuna privacy, obbligata a dividere gli spazi abitativi con gli altri, a mangiare senza la possibilità di compensare…
Questa cosa è stata potente. Noi ad esempio come associazione durante il covid abbiamo continuato a fare i gruppi di auto mutuo aiuto online, proprio perché le famiglie non potevano non incontrarsi, anzi durante la pandemia abbiamo ospitato gente anche da molto lontano.
Sui disturbi alimentari, poi, non esiste una cura unica, ogni centro ha messo a punto un proprio metodo, quello di Vicenza è diverso da quello di Villa Garda o di Portogruaro, ciascuno ha le sue peculiarità. L’importante è mettersi nelle mani di persone competenti e non perdere tempo prezioso.
Aggiungo una riflessione. Chi intraprende un percorso di cura, alla fine sarà una persona diversa da quella che era prima della malattia, perché ha dovuto lavorare dentro di sé. Noi genitori abbiamo spesso l’illusione che quando nostra figlia guarirà, tornerà quella di prima. Dobbiamo sapere invece che arriverà una persona diversa e che dovremo accettarla. Sarà un persona con una cicatrice, perché non è che non sia successo niente: c’era una ferita, che è stata guarita, quindi la cicatrice non è qualcosa di cui vergognarsi, ma il segno che qualcosa è stato superato.
Mia figlia oggi è diversa, ma perché, per stare meglio, è stata costretta a cambiare. La malattia ha provocato dei cambiamenti che la rendono, per certi versi, anche migliore, con un minimo di sicurezza in più, quindi capace anche di dire no, mentre prima sentiva di dover sempre dire sì, ma per paura di scontentare gli altri.
Voi siete riusciti a costruire un modello collettivo di ascolto e sostegno su un problema ancora tabù, segnato dall’isolamento, dalla vergogna...
In questi anni ho conosciuto tante realtà che si occupano di salute mentale. Quello che ho imparato è che intanto l’informazione rende liberi, di agire, di scegliere, ecc. e quindi è fondamentale. Noi abbiamo quattro sportelli di ascolto. E poi ci sono i gruppi di auto aiuto. Il genitore durante il lavoro nel gruppo si trasforma. Io dico sempre che, se facessi una foto della mamma o del papà al loro arrivo, e gliela facessi vedere dopo sei mesi, ma anche dopo due o tre incontri, si vedrebbero già delle persone diverse. La condivisione, il poter dire a un altro come ci si sente è un aiuto davvero prezioso. Il gruppo serve proprio ai familiari; alla figlia e al figlio ci pensano i terapeuti. È uno spazio in cui, per un paio d’ore, puoi parlare, ascoltare, puoi anche piangere perché quello è il tuo stato d’animo; è un luogo di ascolto attivo, in cui ci si scambiano suggerimenti, si riflette assieme, si fanno decantare le cose. Quando poi si torna a casa ci si ripensa, si parla con il partner, con i figli stessi, si possono coinvolgere altre persone nel confronto.
Che tipo di suggerimenti avete raccolto in questi momenti di mutuo aiuto?
Quando i genitori portano il proprio figlio o figlia al centro, c’è il desiderio e la speranza che le cose cambino velocemente, invece la prima cosa da imparare è di non avere fretta. Quando si vede il ragazzo o la ragazza che stanno chiusi in camera, sul divano, che non vogliono fare niente, l’impulso è di proporre mille cose, per scuoterli, per vederli reagire. Di nuovo: non funziona così. Noi cerchiamo di dare qualche orientamento su come comportarsi; ovviamente non è un suggerimento terapeutico, però è un insegnamento che arriva dalla nostra esperienza. Bisogna anche stare in guardia da aspettative eccessive, che rischiano di assorbire energie che potresti dedicare ad altro. Proprio perché il cammino è lungo, è necessario non spendere un sacco di energie su qualcosa che in quel momento non funziona. Poi è necessario saper accogliere la rabbia, che tante volte è enorme; non si deve reprimerla o ignorarla. A volte è importante anche riuscire ad ammettere di non poterne più, di aver bisogno di qualche giorno per staccare, per allontanarsi da una situazione che fa troppo male.
Altri suggerimenti possono riguardare il comportamento da tenere quando si è a tavola: ad esempio, rispettare al grammo il piano alimentare perché se no viene meno la fiducia; non comprare abiti in questa fase, perché se in quel momento lui o lei è molto magra, la prima cosa che succede quando si recupera un po’ di peso sarà di sentirsi grassi e di riprendere con la restrizione del cibo.
Ma come si tiene assieme questa cosa dell’imparare a non avere fretta con la paura della gravità della malattia e della sua progressione?
Ovviamente dipende dalla gravità della situazione. Detto questo, in generale non bisogna aspettarsi che, iniziato un trattamento, si vedano subito i risultati, o che, tornati a casa dopo un ricovero, sia tutto a posto.
Bisogna abbassare le aspettative del genitore che vorrebbe che le cose cambiassero subito e che è portato a pensare che più cose fa, più veloce arriva il cambiamento.
La parola cronicità spaventa molto e tende a togliere speranze, quindi non è appropriata, tuttavia è importante assumere consapevolezza che alcuni disturbi, specie se trascurati, possono assumere una forma di lunga durata.
Da cosa si capisce che si è in qualche modo invertita la rotta?
Il primo segnale è il cambiamento dell’approccio con il cibo: la persona comincia ad assumerlo mentre prima lo rifiutava. Poi il rapporto con alcuni alimenti può rimanere problematico, se prima avevi dieci cibi fobici, magari uno o due rimangano, però il grosso è fatto.
Questo però è solo il primo passo. Con il tempo, lentamente, torna anche la capacità e la voglia di stare in mezzo agli altri, la vita sociale, il lavoro o lo studio.
Avete tanti volontari: chi sono?
Una buona parte dei nostri volontari sono genitori che hanno vissuto questo problema con i propri figli. Ci sono anche persone che provengono da altre esperienze e che a un certo punto scelgono di condividere con noi un pezzo di strada. Noi ne abbiamo diciannove, non è un numero altissimo, anche perché è un tipo di volontariato molto particolare, però l’associazione vive proprio perché ci sono loro.
Sono comunque volontari formati, non può farlo chiunque. La formazione viene svolta dai terapeuti, dalle diverse figure professionali. Noi non facciamo pagare nulla a nessuno, quello di cui disponiamo lo raccogliamo con donazioni, con il cinque per mille, con la partecipazione a bandi; certo se non ci fosse il volontario che mette a disposizione il suo tempo, sarebbe veramente difficile stare in piedi.
Le persone che hanno sofferto di questi disturbi, qualche volta si sono offerte come volontarie. Su questo siamo molto prudenti perché parliamo di persone che vanno comunque protette. In passato, le abbiamo accolte, abbiamo tentato, ma rimanere a contatto con persone ammalate per chi ha vissuto questa esperienza è davvero faticoso e potrebbe esserci un ritorno negativo.
Per concludere, quale messaggio vorresti lasciare?
Il più importante è di non vergognarsi. Di chiedere aiuto. Di prendere contatto. Di non sottovalutare. Se un genitore vede che la figlia inizia a cambiare, non deve minimizzare o aspettare, perché il tempo è prezioso. Esiste il servizio pubblico, internet; il Ministero della Salute ha fatto una mappa di tutti i centri pubblici e dei servizi convenzionati dove poter andare a curarsi. Sono centri validati.
Poi esistono i siti delle associazioni, a cui chiedere informazioni. Se abbiamo dubbi, andiamo dal medico di base, dal pediatra, cerchiamo di approfondire.
Un messaggio forte che vorrei lanciare in questa intervista è che la salute mentale ha la stessa dignità della salute fisica: se la mia mente sta male non vado da nessuna parte perché viene compromesso il mio rendimento scolastico, lavorativo, i miei affetti. Il cervello è una parte del corpo che devo poter curare senza vergogna.
Quindi, la dignità della salute mentale. Qui bisogna veramente cambiare. Una cosa a cui penso sempre è che si dovrebbe lanciare una campagna per ripensare i reparti di psichiatria, affinché smettano di essere così tetri, brutti e anche così stigmatizzanti. Perché solo nei reparti di pediatria si dipingono murales, le stanze sono colorate, accoglienti, piacevoli?
Anche questo porta a una comunicazione distorta, perché ti fa vedere quel luogo come un ambiente terrificante, invece, la psichiatria dovrebbe aiutare la persona a stare meglio e a contenere il suo disagio quando sta male.
(a cura di Barbara Bertoncin)
Puoi raccontare dell’associazione?
L’associazione è nata dieci anni fa. Eravamo cinque famiglie con le figlie nello stesso centro di cura. L’idea è arrivata anche su sollecitazione dei terapeuti, per fornire un aiuto alle famiglie e venire incontro al nostro bisogno di informazioni e condivisione di percorsi. Volevamo essere una sorta di ponte tra un’assenza totale di informazioni e almeno un orientamento su dove andare e cosa fare rispetto ai disturbi alimentari. È molto importante che un genitore, nel momento in cui si accorge che qualcosa non va, non perda tempo prezioso. Purtroppo, i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, quando diventano evidenti, sono già presenti da un po’. All’inizio noi genitori non ci rendiamo conto di nulla e quando poi cominciamo a capire, rimaniamo scioccati e sconvolti. Una volta che si conosce la malattia, che si capisce come funziona, capita di andare a ritroso e individuare la presenza di alcuni segnali di allarme.
Queste sono patologie che coinvolgono molti aspetti della persona, non solo l’alimentazione pura, ma anche la mente, il comportamento, i pensieri, che sono la parte più difficile da modificare. Infatti il recupero, nella persona che ne è affetta, avviene in due fasi distinte. Dapprima c’è il recupero dell’alimentazione e poi quello dei pensieri “sani”. Quest’ultimo è molto più lento e difficile da ottenere. Ecco perché il tempo della cura è molto lungo.
Ecco, noi, come genitori, all’epoca abbiamo pensato che, con un’associazione, avremmo potuto aiutare altre famiglie. Ovviamente non siamo medici, siamo solo persone che hanno attraversato questa esperienza, però possiamo dare indicazioni su dove cercare aiuto, poi saranno gli specialisti a formulare una diagnosi.
La nostra associazione ha prevalentemente lo scopo di supportare le famiglie, sensibilizzare l’opinione pubblica, creare rete, con il territorio, le scuole, le istituzioni, ecc.
Come avete visto cambiare questi disturbi negli anni?
Il nostro obiettivo è anche quello di aumentare la conoscenza di questo spettro di disturbi, così che sia più facile chiedere aiuto e di conseguenza arrivare in tempo. Spesso si pensa che solo le persone estremamente magre possano avere questo tipo di problema. Ma non è sempre così, ci sono persone che soffrono di bulimia e nessuno se ne accorge perché sono normopeso.
Una volta i disturbi alimentari erano più puri, c’erano casi di sola anoressia o sola bulimia, adesso invece ci sono anche altre patologie associate, ad esempio ci può essere qualcuno che soffre allo stesso tempo di anoressia e bulimia, e a queste si possono aggiungere depressione, disturbi della personalità, bipolarismo ecc...
Ultimamente, si è molto abbassata l’età di esordio e c’è un coinvolgimento maggiore dei maschi. Ci sono ora pazienti con un’età che va dai dieci, undici anni fino a oltre i cinquanta. Questi disturbi non nascono per una causa specifica, ma per un insieme di situazioni; a volte c’è anche forse una predisposizione genetica.
In certo momento della propria vita, sia una ragazza giovane che una persona adulta, può incontrare una difficoltà che viene avvertita come enorme, inaffrontabile e spesso questo sfocia nel disturbo alimentare. Ci si sente talmente non idonei, inadeguati… Siccome l’unica cosa su cui si può esercitare un controllo è il proprio corpo e le sue reazioni, ci si concentra su quello. Se riesco a non mangiare, cioè metto in atto una restrizione, e vedo che ce la faccio, quella cosa mi dà una grande gratificazione.
Infatti all’inizio chi soffre di disturbi della nutrizione non riconosce la propria malattia, perché in realtà avverte il proprio comportamento come una soluzione. Anche visivamente, c’è come una distorsione della propria immagine corporea: continuo a guardare in modo specifico e ossessivo alcune parti del mio corpo, fino a che il mio cervello non mi fa più percepire realmente le immagini, per cui continuo, ad esempio, a vedermi con dei fianchi enormi, quando non lo sono affatto.
Ora, è chiaro, che tutto questo non può certo essere risolto dalle parole di chi ti dice che non è così. Servono un percorso e un trattamento terapeutico mirato anche sull’immagine corporea.
Quello che ci teniamo a dire è che, per questi disturbi, esistono i terapeuti, esistono le cure, è importante sapere che è una condizione reversibile. Certo non bisogna affidarsi a persone che non sono competenti perché, ripeto, più si perde tempo, più la malattia mette radici e così sarà sempre più difficile uscirne.
Noi in provincia di Vicenza siamo fortunati perché abbiamo dei buoni servizi pubblici. Per molte province e regioni d’Italia non è così. Siamo anche una delle regioni che ha più associazioni, quasi in ogni provincia. Chi non ha queste possibilità, rischia di doversi spostare in un’altra regione, situazione che per le famiglie è veramente drammatica.
Stare accanto a chi sta male non è facile. Quali sono gli errori più comuni che si commettono?
Stare vicino a una persona che ha questi problemi è molto stancante. Il percorso è lungo e impegnativo; se poi l’accesso alle cure costringe ad allontanarsi dalla propria città, questo destabilizza tutta la famiglia. Quando arrivano queste problematiche, la famiglia ne viene letteralmente travolta, perché la compromissione del fisico, del tono, dell’umore è molto pesante e costringe tutti a cambiare.
Le stesse parole che noi diciamo vanno scelte con cura, perché anche se dietro ci sono le migliori intenzioni, possono mettere a repentaglio il lavoro terapeutico.
Per dire, una domanda che spesso si fa a chi soffre di questi disturbi è: “Ma cosa ti manca?” ed è una domanda sbagliata, perché non è che manca qualcosa, il problema è che ci si sente inadeguati. Questo tipo di disturbo è molto democratico: non conta la condizione sociale, l’istruzione, è un disagio che azzera tutto.
Oppure quando una persona ti confida che si vede grossa e tu rispondi di no, che è normalissima, ma lei ti ha detto che si vede così, non che lo è. Ancora, si accusa chi non mangia di essere una persona ingrata, perché al mondo ci sono tante persone che muoiono di fame. Ma così si colpevolizza inutilmente chi comunque non lo sta facendo apposta.
A volte capita che queste ragazzine giovani improvvisamente non vogliano più uscire. Rifiutano di stare in mezzo agli altri e tutte le situazioni conviviali.
Ecco, spronarle ad andare a prendere un gelato, “così socializza” vuol dire chiedere loro qualcosa di impossibile.
Oppure la frase: “Da te mi aspettavo di più”, che una ragazzina in difficoltà traduce con “Non valgo nulla!”. O ancora gli apprezzamenti sull’aspetto fisico che enfatizzano un “troppo”, troppo bassa, troppo alta, troppo seno...
Insieme ai gruppi di auto aiuto del Veneto, anni fa abbiamo stampato un libretto, intitolato proprio “Senti chi sparla”, tutto incentrato sulla comunicazione, in cui abbiamo raccolto tutte quelle frasi che a nostra volta abbiamo pronunciato; spesso sono le frasi più comuni.
Chi si rivolge a voi?
In genere i genitori, ma negli ultimi anni, con l’aumento dell’età in cui compaiono questi disturbi, anche mariti, compagni, perché si accorgono, che la persona che hanno a fianco non sta bene. Ultimamente, abbiamo avuto anche qualche caso di ragazze giovani che hanno chiesto aiuto in prima persona.
Va detto che spesso i giovani non vengono accompagnati dai genitori. Magari confidano questo loro malessere a qualche insegnante o a qualche istruttore sportivo.
A me è capitato di ricevere una persona con il proprio allenatore perché aveva paura di coinvolgere la famiglia. Poi noi l’abbiamo aiutata a parlare con i genitori che non si erano accorti del suo stare male.
Da noi comunque arrivano in modo prevalente i genitori o perché non hanno capito bene di cosa si tratta e hanno bisogno di ricevere informazioni, oppure perché magari, sempre tramite il lavoro sulla sensibilizzazione che svolgiamo anche nelle scuole, qualche insegnante si è accorto di qualcosa e li ha consigliati di prendere contatto con noi.
Abbiamo fatto un grande lavoro di formazione per gli insegnanti, copriamo tante scuole; è una parte del nostro lavoro molto importante perché i ragazzi trascorrono tantissime ore a scuola, l’insegnante li incontra e sta con loro tutti i giorni, li vede crescere, trasformarsi. Bisognerebbe fare di più. Rispetto al passato, ora i genitori sono meno presenti in casa per problemi lavorativi, così spesso i ragazzi a pranzo sono soli.
Quali sono le varie forme di disturbo alimentare?
Abbiamo anoressia e bulimia. In entrambe, c’è la paura di ingrassare e il cibo viene visto come un nemico. A volte la bulimia è più insidiosa, più difficile da individuare perché la ragazza può essere normopeso. Nella bulimia un genitore può però trovare in casa dei segni, che possono essere residui di vomito, involucri di cibo, cartocci nascosti negli armadi, dentro le scarpe, negli zaini, in posti impensabili. Oppure possono verificarsi sparizioni importanti di cibo. Spesso queste persone, per mascherare il disturbo, si sottopongono a una iperattività fisica. La bulimia è caratterizzata dall’abbuffata, che è una perdita del controllo: si mangiano diversi tipi di alimenti, cotti, crudi, surgelati, tutti insieme, salvo dopo sentirsi malissimo perché si è pieni, quindi si ha bisogno di svuotarsi e le modalità per farlo sono il vomito indotto, i lassativi e l’iperattività fisica. Solo che dopo rimane il senso di colpa, quindi tutto questo viene fatto di nascosto. Diversa la dinamica nell’anoressia: la persona che ha questo disturbo, va a tavola insieme agli altri, ma non riesce a mangiare. Quello che accomuna questi disturbi, e di cui inevitabilmente ci si accorge, è il cambiamento del tono dell’umore. Con mia figlia, per esempio, questo mutamento è stato un indicatore, più che il dimagrimento: era diventata triste e si isolava.
Qual è il problema? Che le persone appunto, non rendendosene conto per tempo, arrivano tardi alla diagnosi e oggi sappiamo che la bulimia causa i danni maggiori agli organi interni, come sovraccarico del cuore, problemi legati all’esofago, allo stomaco, corrosione dei denti. Ci sono conseguenze gravi anche nella anoressia, che può perfino portare alla morte, però nella bulimia gli effetti sono mediamente peggiori proprio perché si rivela tardi, quando i problemi creati sono più difficili da risolvere.
Dicevi prima che le famiglie vengono travolte. Cosa intendevi?
Ti capita una cosa di cui non sai e non capisci nulla, e di fronte alla quale sei totalmente impotente, perché fino a che non incontri dei terapeuti che prendono in mano la situazione e ti indirizzano, da solo non puoi risolvere nulla. La tua vita viene travolta perché all’improvviso non sai più cosa fare, come comportarti, hai questa persona che sta male e non puoi fare niente, devi stare attenta alle parole, i rapporti con gli altri diventano difficili, perché c’è ancora un senso di vergogna, di pregiudizio.
Inoltre parliamo di un percorso di cura che è molto lungo. Se anche hai la fortuna che tua figlia o tuo figlio vengano presi in carico, poi c’è un piano alimentare da seguire, devi preparare tutta una serie di cibi, che all’inizio la persona ammalata non mangerà e così sei continuamente sottoposto a enormi frustrazioni, con tutto quello che ne consegue. Pensi: “Ma cosa le costa mangiare quei pochi grammi di pasta?”. Senza capire che per lei è una fatica enorme e che lo farà, ma solo quando avrà gli strumenti necessari.
In passato, si imputava l’origine di questi disturbi al rapporto con la madre...
Oggi non più. Il disturbo alimentare arriva per un insieme di fattori di rischio e non per colpa della madre. Probabilmente quella era una semplificazione perché tradizionalmente era la mamma a preparare da mangiare, a stare più vicino ai figli e quindi nasceva un conflitto. Tra l’altro, spesso si creano situazioni spiacevoli anche con i nonni. Potete immaginare, per loro è un affronto se la nipote va da loro e non mangia. Un classico: la nonna prepara il pasticcio... per la ragazza è una tragedia! Cioè il pasticcio è una di quelle cose che non verrà mai mangiata da chi è affetto da disturbi alimentari. Nella sua testa scatta immediatamente la domanda relativa a chissà cosa c’è dentro, quanto olio, quanto burro, quante calorie... la persona ammalata va veramente in tilt. E la nonna, poveretta, ovviamente ha preparato il pasto con le sue migliori intenzioni, perché una volta a sua nipote quel cibo piaceva tanto. Ecco perché abbiamo organizzato anche dei corsi per i nonni.
Poi c’è il tema dei fratelli, che in genere sono più piccoli. Una famiglia viene talmente assorbita da questo disturbo che fatica a reggere il quotidiano e questo rischia di avere delle ripercussioni sugli altri membri. Infatti è importante fare interventi anche sugli altri figli. Ci sono capitati casi in cui un fratellino diceva: “Devo ammalarmi anch’io perché tu ti accorga che esisto?”, perché il genitore appunto è travolto, è più forte di lui.
Quindi io mi sento di spezzare una lancia in favore dei genitori, che vengono attraversati in tutti i modi da questa malattia, e sono costretti a costruirsi una specie di armatura per potersi difendere...
Sono percorsi che durano per anni: una volta iniziato il lavoro terapeutico, non è detto che poi vada tutto liscio e che nel giro di poco si stia bene. I tragitti sono altalenanti, qualcuno va bene per un po’ di tempo, poi c’è una ricaduta, poi si ritorna a stare bene. Ci vuole del tempo per uscire da questo disturbo.
Quindi il genitore viene molto provato. Noi organizziamo dei gruppi di auto aiuto. Una volta venivano solo le mamme, ora invece vengono anche i papà e verifichiamo che c’è una differenza di accettazione. I papà fanno più fatica a dire: “Mia figlia ha questo problema”. Pensano che sia impossibile.
Puoi parlarci della componente maschile che viene colpita da questo disturbo?
I casi sono in aumento, adesso siamo su una percentuale del 7%. I maschi presentano gli stessi disturbi, ma si approcciano in modo diverso, si nascondono di più tramite lo sport, sono quasi sempre iperattivi.
Si parla molto del ruolo dei social...
Un’altra cosa che ci tengo a dire è che l’aumento dei casi non è imputabile ai social, come invece molti affermano. Questi disturbi ci sono da molti anni. Sappiamo che l’anoressia ha un’origine che risale molto indietro nel tempo. La bulimia invece è stata diagnosticata più tardi, negli anni Settanta, quindi ha una storia più recente. Oggi qual è la differenza? Che se una volta lo sapevi dai giornali o dalla Tv, perché qualche modella ne era affetta, ora invece sono i social a trasmettere l’informazione. Ci sono addirittura degli influencer sui disturbi alimentari. Non lo fanno per un guadagno economico, però quello che fanno è terribile. Dietro non c’è infatti uno scopo educativo, informativo nel senso buono; non è un modo per condividere e per fa sì che altri non ci caschino dentro. Tutt’altro: queste ragazzine mostrano con soddisfazione quante ore di attività fisica fanno; alcune arrivano a farsi vedere con il sondino, mentre sono in ospedale. Queste cose certo non aiutano, occorre stare molto attenti. Detto questo, non sono i social ad aver portato a un aumento dei casi, e nemmeno la pandemia. Perlopiù parliamo di persone che già stavano male, dopodiché il Covid ha fatto esplodere la situazione. Durante il lockdown siamo stati tutti costretti a rimanere chiusi in casa. Immagina cos’ha voluto dire per una persona con questi disturbi, all’improvviso senza alcuna privacy, obbligata a dividere gli spazi abitativi con gli altri, a mangiare senza la possibilità di compensare…
Questa cosa è stata potente. Noi ad esempio come associazione durante il covid abbiamo continuato a fare i gruppi di auto mutuo aiuto online, proprio perché le famiglie non potevano non incontrarsi, anzi durante la pandemia abbiamo ospitato gente anche da molto lontano.
Sui disturbi alimentari, poi, non esiste una cura unica, ogni centro ha messo a punto un proprio metodo, quello di Vicenza è diverso da quello di Villa Garda o di Portogruaro, ciascuno ha le sue peculiarità. L’importante è mettersi nelle mani di persone competenti e non perdere tempo prezioso.
Aggiungo una riflessione. Chi intraprende un percorso di cura, alla fine sarà una persona diversa da quella che era prima della malattia, perché ha dovuto lavorare dentro di sé. Noi genitori abbiamo spesso l’illusione che quando nostra figlia guarirà, tornerà quella di prima. Dobbiamo sapere invece che arriverà una persona diversa e che dovremo accettarla. Sarà un persona con una cicatrice, perché non è che non sia successo niente: c’era una ferita, che è stata guarita, quindi la cicatrice non è qualcosa di cui vergognarsi, ma il segno che qualcosa è stato superato.
Mia figlia oggi è diversa, ma perché, per stare meglio, è stata costretta a cambiare. La malattia ha provocato dei cambiamenti che la rendono, per certi versi, anche migliore, con un minimo di sicurezza in più, quindi capace anche di dire no, mentre prima sentiva di dover sempre dire sì, ma per paura di scontentare gli altri.
Voi siete riusciti a costruire un modello collettivo di ascolto e sostegno su un problema ancora tabù, segnato dall’isolamento, dalla vergogna...
In questi anni ho conosciuto tante realtà che si occupano di salute mentale. Quello che ho imparato è che intanto l’informazione rende liberi, di agire, di scegliere, ecc. e quindi è fondamentale. Noi abbiamo quattro sportelli di ascolto. E poi ci sono i gruppi di auto aiuto. Il genitore durante il lavoro nel gruppo si trasforma. Io dico sempre che, se facessi una foto della mamma o del papà al loro arrivo, e gliela facessi vedere dopo sei mesi, ma anche dopo due o tre incontri, si vedrebbero già delle persone diverse. La condivisione, il poter dire a un altro come ci si sente è un aiuto davvero prezioso. Il gruppo serve proprio ai familiari; alla figlia e al figlio ci pensano i terapeuti. È uno spazio in cui, per un paio d’ore, puoi parlare, ascoltare, puoi anche piangere perché quello è il tuo stato d’animo; è un luogo di ascolto attivo, in cui ci si scambiano suggerimenti, si riflette assieme, si fanno decantare le cose. Quando poi si torna a casa ci si ripensa, si parla con il partner, con i figli stessi, si possono coinvolgere altre persone nel confronto.
Che tipo di suggerimenti avete raccolto in questi momenti di mutuo aiuto?
Quando i genitori portano il proprio figlio o figlia al centro, c’è il desiderio e la speranza che le cose cambino velocemente, invece la prima cosa da imparare è di non avere fretta. Quando si vede il ragazzo o la ragazza che stanno chiusi in camera, sul divano, che non vogliono fare niente, l’impulso è di proporre mille cose, per scuoterli, per vederli reagire. Di nuovo: non funziona così. Noi cerchiamo di dare qualche orientamento su come comportarsi; ovviamente non è un suggerimento terapeutico, però è un insegnamento che arriva dalla nostra esperienza. Bisogna anche stare in guardia da aspettative eccessive, che rischiano di assorbire energie che potresti dedicare ad altro. Proprio perché il cammino è lungo, è necessario non spendere un sacco di energie su qualcosa che in quel momento non funziona. Poi è necessario saper accogliere la rabbia, che tante volte è enorme; non si deve reprimerla o ignorarla. A volte è importante anche riuscire ad ammettere di non poterne più, di aver bisogno di qualche giorno per staccare, per allontanarsi da una situazione che fa troppo male.
Altri suggerimenti possono riguardare il comportamento da tenere quando si è a tavola: ad esempio, rispettare al grammo il piano alimentare perché se no viene meno la fiducia; non comprare abiti in questa fase, perché se in quel momento lui o lei è molto magra, la prima cosa che succede quando si recupera un po’ di peso sarà di sentirsi grassi e di riprendere con la restrizione del cibo.
Ma come si tiene assieme questa cosa dell’imparare a non avere fretta con la paura della gravità della malattia e della sua progressione?
Ovviamente dipende dalla gravità della situazione. Detto questo, in generale non bisogna aspettarsi che, iniziato un trattamento, si vedano subito i risultati, o che, tornati a casa dopo un ricovero, sia tutto a posto.
Bisogna abbassare le aspettative del genitore che vorrebbe che le cose cambiassero subito e che è portato a pensare che più cose fa, più veloce arriva il cambiamento.
La parola cronicità spaventa molto e tende a togliere speranze, quindi non è appropriata, tuttavia è importante assumere consapevolezza che alcuni disturbi, specie se trascurati, possono assumere una forma di lunga durata.
Da cosa si capisce che si è in qualche modo invertita la rotta?
Il primo segnale è il cambiamento dell’approccio con il cibo: la persona comincia ad assumerlo mentre prima lo rifiutava. Poi il rapporto con alcuni alimenti può rimanere problematico, se prima avevi dieci cibi fobici, magari uno o due rimangano, però il grosso è fatto.
Questo però è solo il primo passo. Con il tempo, lentamente, torna anche la capacità e la voglia di stare in mezzo agli altri, la vita sociale, il lavoro o lo studio.
Avete tanti volontari: chi sono?
Una buona parte dei nostri volontari sono genitori che hanno vissuto questo problema con i propri figli. Ci sono anche persone che provengono da altre esperienze e che a un certo punto scelgono di condividere con noi un pezzo di strada. Noi ne abbiamo diciannove, non è un numero altissimo, anche perché è un tipo di volontariato molto particolare, però l’associazione vive proprio perché ci sono loro.
Sono comunque volontari formati, non può farlo chiunque. La formazione viene svolta dai terapeuti, dalle diverse figure professionali. Noi non facciamo pagare nulla a nessuno, quello di cui disponiamo lo raccogliamo con donazioni, con il cinque per mille, con la partecipazione a bandi; certo se non ci fosse il volontario che mette a disposizione il suo tempo, sarebbe veramente difficile stare in piedi.
Le persone che hanno sofferto di questi disturbi, qualche volta si sono offerte come volontarie. Su questo siamo molto prudenti perché parliamo di persone che vanno comunque protette. In passato, le abbiamo accolte, abbiamo tentato, ma rimanere a contatto con persone ammalate per chi ha vissuto questa esperienza è davvero faticoso e potrebbe esserci un ritorno negativo.
Per concludere, quale messaggio vorresti lasciare?
Il più importante è di non vergognarsi. Di chiedere aiuto. Di prendere contatto. Di non sottovalutare. Se un genitore vede che la figlia inizia a cambiare, non deve minimizzare o aspettare, perché il tempo è prezioso. Esiste il servizio pubblico, internet; il Ministero della Salute ha fatto una mappa di tutti i centri pubblici e dei servizi convenzionati dove poter andare a curarsi. Sono centri validati.
Poi esistono i siti delle associazioni, a cui chiedere informazioni. Se abbiamo dubbi, andiamo dal medico di base, dal pediatra, cerchiamo di approfondire.
Un messaggio forte che vorrei lanciare in questa intervista è che la salute mentale ha la stessa dignità della salute fisica: se la mia mente sta male non vado da nessuna parte perché viene compromesso il mio rendimento scolastico, lavorativo, i miei affetti. Il cervello è una parte del corpo che devo poter curare senza vergogna.
Quindi, la dignità della salute mentale. Qui bisogna veramente cambiare. Una cosa a cui penso sempre è che si dovrebbe lanciare una campagna per ripensare i reparti di psichiatria, affinché smettano di essere così tetri, brutti e anche così stigmatizzanti. Perché solo nei reparti di pediatria si dipingono murales, le stanze sono colorate, accoglienti, piacevoli?
Anche questo porta a una comunicazione distorta, perché ti fa vedere quel luogo come un ambiente terrificante, invece, la psichiatria dovrebbe aiutare la persona a stare meglio e a contenere il suo disagio quando sta male.
(a cura di Barbara Bertoncin)
Archivio
L'ANGOLO PER LA MANICURE
Una Città n° 298 / 2023 dicembre 2023 - gennaio 2024
Realizzata da Gianni Saporetti
Realizzata da Gianni Saporetti
Antonella Agnoli, esperta di progettazione di biblioteche, ha pubblicato, tra gli altri, Caro sindaco, parliamo di biblioteche (2009), La biblioteca che vorrei. Spazi, creatività, partecipazione (2014) per Editrice Bibliografica e Le piazze del sap...
Leggi di più
LA FOODBANK
Una Città n° 298 / 2023 dicembre 2023 - gennaio 2024
Helena Aksentijevic è Project Manager della Foodbank di Euston, a Londra.
Puoi raccontarci la storia di questa Foodbank?
Siamo nati nel 2017. La vecchia sede era più piccola, avevamo molti meno utenti. Nella sede attuale, che è di...
Leggi di più
Le buone pratiche
Una Città n° 251 / 2018 agosto-settembre
Ogni problema sociale, per quanto limitato, presenta ormai una grande complessità. Innumerevoli sono le connessioni fra famiglia, quartiere, scuola e luogo di lavoro; fra paesi e culture di provenienza, spesso lontanissimi, e luoghi di residenza; f...
Leggi di più
Imparare facendo
Una Città n° 244 / 2017 novembre
Stella Sorgente è vicesindaca di Livorno, Comune che ha posto in agenda come problema prioritario il ripensamento radicale dell’organizzazione e del funzionamento della PA a livello comunale; Maurizio Giacobbe è esperto di democrazia sperimentale; Susan G...
Leggi di più
L'irriverenza democratica
Una Città n° 269 / 2020 OTTOBRE
È in atto la riscoperta anche in Europa, in questi ultimi anni, del community organizing, ovvero dei due dispositivi politici
-“l’organizzazione di comunità ad ampio raggio” e il ruolo “dell’organizzatore di co...
Leggi di più