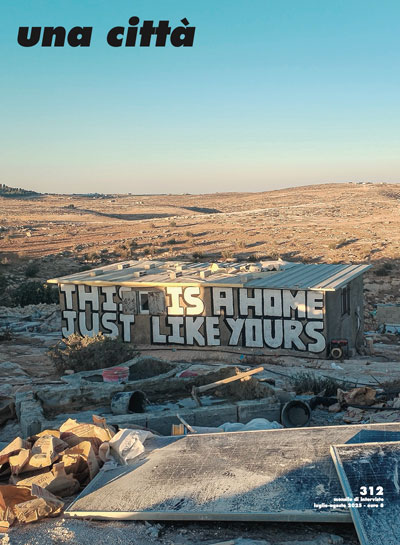Questa intervista è disponibile nel libro Cosa intendi dire?, ed. Una città, aprile 2023
pagine di storia

Una Città n° 65 / 1998 Febbraio
Intervista a Chiara Frugoni
Realizzata da Gianni Saporetti
QUEI LUMINI
Un brulicare di attività all’aperto, le donne che vanno al mercato e a prendere l’acqua o il fuoco, gli artigiani che aprono bottega, i bambini che giocano, il banditore che dà le ultime notizie. Ma anche case anguste, senza vetri, dove ci si ammassa per dormire, quando, al tramonto, la città sprofonda in un buio pesto. Il successo strabiliante dei frati predicatori. Una giornata in una città del Trecento. Intervista a Chiara Frugoni.
Archivio
LA REGOLA CHE NON PASSO'
Una Città n° 226 / 2015 Novembre
Realizzata da Gianni Saporetti
Realizzata da Gianni Saporetti
Questa intervista è disponibile nel libro Cosa intendi dire?, ed. Una città, aprile 2023...
Leggi di più
IN LAMBRETTA COL BABBO
Una Città n° 211 / 2014 marzo
Realizzata da Gianni Saporetti
Realizzata da Gianni Saporetti
Questa intervista è disponibile nel libro Cosa intendi dire?, ed. Una città, aprile 2023...
Leggi di più
L'ELEMOSINA E LA GIUSTIZIA
Una Città n° 195 / 2012 Giugno-Luglio
Realizzata da Gianni Saporetti
Realizzata da Gianni Saporetti
Questa intervista è disponibile nel libro Cosa intendi dire?, ed. Una città, aprile 2023...
Leggi di più
SE I RAGGI SONO BIANCHI O ROSSI...
Una Città n° 174 / 2010 Maggio
Realizzata da Gianni Saporetti
Realizzata da Gianni Saporetti
Questa intervista è disponibile nel libro Cosa intendi dire?, ed. Una città, aprile 2023...
Leggi di più
Cosa intendi dire?
Una Città n° 283 / 2022 aprile
Realizzata da Gianni Saporetti
Realizzata da Gianni Saporetti
Questa intervista è disponibile nel libro Cosa intendi dire?, ed. Una città, aprile 2023...
Leggi di più