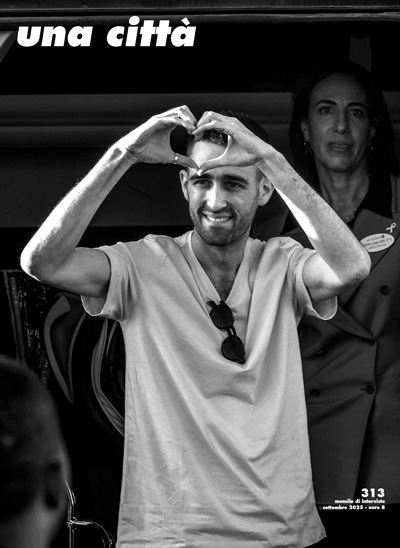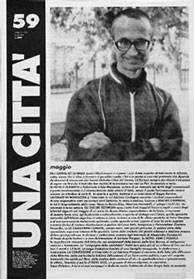Scorgiamo, in queste storie, generalmente prodotte in paesi del Nord America e del Nord Europa, in quei ritratti, affetti importanti, socialità dense di relazioni significative e, frequentemente, anche in situazioni estreme, l’esistenza di comunità solidali.
Poiché ciò che vive nel nostro immaginario appartiene anche alla nostra vita, si verifica una generalizzazione impropria per la quale l’esistenza di un movimento politico di liberazione delle omosessualità sarebbe di per sé sinonimo di comunità. Non è così.
Manuali come quello di Ezio Menzione, o altri elaborati da Giovanni Dall’Orto, pensati per chi voglia crescere e affermare i propri diritti, parrebbero indicare che la comunità esiste. Ma se il "prendersi cura" costituisce, come credo, l’indicatore più sicuro dell’esistenza di una rete di persone tra loro solidali, noi omosessuali italiani ancora non sembriamo averla strutturata.
Le differenze tra il nostro paese e quelli più a nord sono tracciabili a grandi linee:
1) Da quasi cent’anni in Italia non esiste alcuna legge specificamente rivolta contro gay e lesbiche. L’età del consenso è la stessa, sia per i rapporti etero che omosessuali. In Francia e in Germania leggi discriminatorie sono state rimosse solo negli anni Ottanta da Mitterrand e Schmidt. In Gran Bretagna, esistono tuttora. Negli Usa variano da Stato a Stato e talvolta sono gravemente vessatorie.
Questi elementi di aperta oppressione in stati democratici hanno favorito il coagularsi delle popolazioni omosessuali attorno alla richiesta della loro rimozione e hanno fatto nascere forme di autodifesa e autotutela, in ultima analisi hanno prodotto il senso di comunità del quale parliamo.
2) Francia, Gran Bretagna, Germania, Usa, Australia, Canada, vedono la presenza di grandi agglomerati urbani, talvolta vere e proprie megalopoli. Un forte flusso migratorio interno ha condotto migliaia di gay e lesbiche verso queste grandi città, dove hanno dato vita ad una scena ampia, articolata e visibile. L’Italia è invece caratterizzata da un tessuto di piccoli comuni (si pensi che Bologna e Firenze hanno circa 400.000 abitanti) e le stesse città più importanti (Roma, Napoli, Milano) hanno popolazioni limitate.
Anche qui gay e lesbiche, se possono, emigrano da piccoli paesi verso le città, ma si tratta di un fenomeno, tutto sommato, recente e non ancora sufficientemente evoluto.
3) La straordinaria presenza del Vaticano e di una Chiesa Cattolica controriformata determina gran parte degli atteggiamenti politici, sociali e culturali del nostro Paese.
In definitiva, operiamo e viviamo all’interno di una realtà socioculturale e antropologica, che non ha favorito la crescita e il consolidarsi di una comunità lesbo-gay.
Il motto cattolico e mediterraneo, "si fa, ma non si dice", assommato alle ragioni sopra riportate, ha fatto sì che gran parte delle persone omosessuali occultasse la propria scelta e vivesse una schizofrenia tra la vita di relazione di ogni giorno e la propria identità.
L’occultamento sociale dell’identità omosessuale, la conseguente frattura che questa scelta provoca negli individui, l’assenza di amore e di rispetto per se stessi, l’insignificanza che si intende attribuire al proprio essere, inducono alla costruzione di rapporti fortemente segnati dalla negazione di qualsiasi autenticità. Ciò che si interroga, allora, non sarà tanto la carenza di motivazioni politiche unitarie nel movimento degli e delle omosessuali (che quest’anno ha condotto a due diverse manifestazioni nazionali per il Lesbian&Gay Pride), quanto invece l’io spezzato che vive nei corpi degli e delle omosessuali. La frantumazione dell’io si riflette nella vicenda Aids. Al di là delle cifre relative al numero di omosessuali colpiti dal virus (da 4 a 6 volte inferiori a quelle di Francia, Germania, Usa), non v’è dubbio che le metafore prodotte dalla sua diffusione abbiano riguardato e riguardino intimamente ognuno di noi, mettendo in gioco la qualità delle nostre reciproche relazioni. N ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!