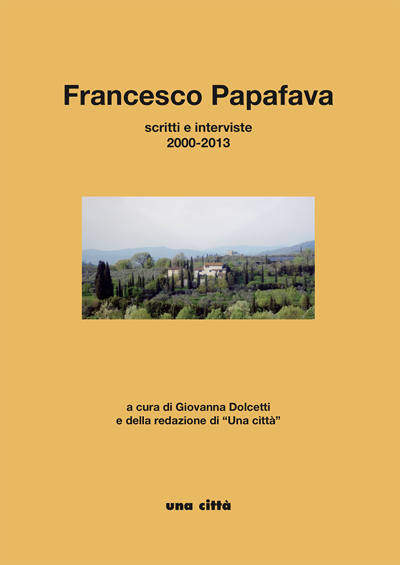
Francesco Papafava, editore, è membro dell’International Commette of Museum (Icom)
di letteratura e altro, internazionalismo, problemi di fede

Una Città n° 88 / 2000 Settembre
Intervista a Francesco Papafava
Realizzata da Gianni Saporetti
BENI DI TUTTI
La salvaguardia dei monasteri ortodossi del Kosovo, di inestimabile valore artistico, e storico, oggi garantita dalla forza internazionale, così come di tutti gli altri beni architettonici, anche quelli mussulmani spesso distrutti, potrebbe diventare fattore di disgelo fra le due comunità. L’importanza di un’assunzione di responsabilità internazionale per il restauro. Intervista a Francesco Papafava.
Questa intervista è disponibile nel libro Francesco Papafava - scritti e interviste, ed. Una città, 2017
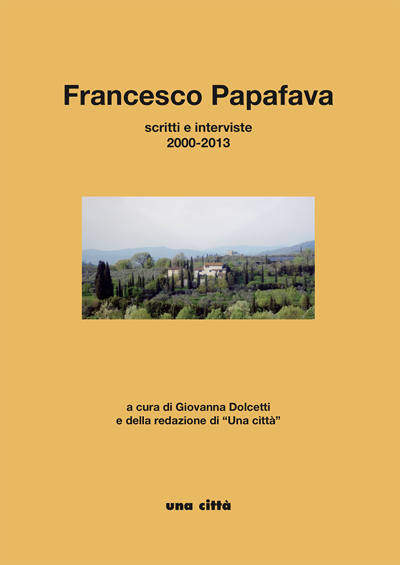
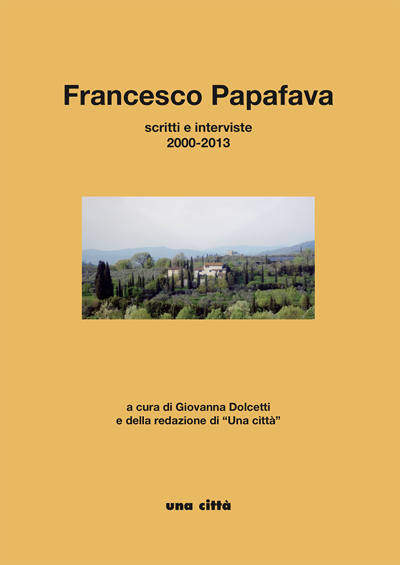
Archivio
Nord e Sud
Una Città n° 303 / 2024 settembre
Nord e Sud di F. Papafava
È divertente vedere come queste elucubrazioni sul Nord e sul Sud si allargano e penetrano sulla folla. Giorni sono ho sentito da un’operaio socialista che i proprietari nell’Italia settentrionale suono buoni a...
Leggi di più
FRA ISRAELE E STATI UNITI
Una Città n° 194 / 2012 Maggio
Nella stampa, alla radio e alla televisione non è stata sottolineata la svolta nei rapporti americo-israeliani che si è manifestata in modo clamoroso all’annuale Conferenza dell’Aipac a Washington nei tre giorni 4-6 di marzo.Occorre precisare che l’Aipac ...
Leggi di più
RICORDIAMO FRANCESCO PAPAFAVA
Una Città n° 237 / 2017 marzo
"Francesco Papafava”, ed. Una città, 248 pp, 12 euro. Per acquistarlo Tel: 054321422 Fax: 0543 30421 Pagina web acquisti: goo.gl/S0VVDCVjosa Dobruna... Ma non finisce qui: i rom, pare perché costretti a dichiararsi serbi, albanesi o turchi, come reazione...
Leggi di più
IL 2% AL POSTO DEL 100%
Una Città n° 189 / 2011 novembre
Dal "Channel 10” israeliano è stato trasmesso in ebraico il 17 luglio 2010 un video in cui Netanyahu, nel 2001, a sua insaputa, veniva ripreso durante una visita in un’abitazione di coloni a Ofra, un insediamento ebraico a circa otto chilometri da Ramalla...
Leggi di più
I TIMORATI
Una Città n° 200 / 2013 febbraio
Da alcune stagioni l’attenzione sul Medio Oriente è stata assorbita dalla preoccupazione di un probabile prossimo armamento atomico dell’Iran e di un conseguente attacco preventivo israeliano agli impianti nucleari di quel paese. Non è la sola questione c...
Leggi di più


















