Una fede concreta
storie
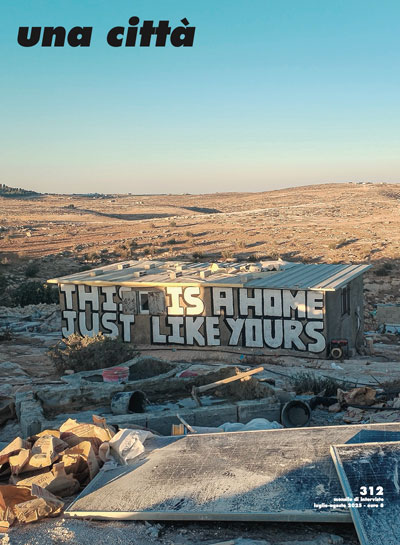
Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto
Intervista a Benito Fusco
Realizzata da Gianni Saporetti
UNA FEDE CONCRETA
L’amicizia con Francesco Lorusso, nata a fare i barellieri a Lourdes, il ritrovarsi all’università, la militanza in Lotta Continua fino al suo scioglimento, l’11 marzo del 1977; l’impegno da assessore, un matrimonio fallito, l’aereo militare che cade sulla scuola e gli undici ragazzi morti; il Brasile, l’incontro con padre Bruno e la scelta di diventare frate; una fede per “riprendersi la vita” e l’impegno per una Chiesa “gentile”, non irrigidita nelle regole. Intervista a Benito Fusco.
Benito Fusco è frate servita e sacerdote. Vive a Bologna. L’intervista è stata fatta prima della morte di papa Francesco.
Partiamo dalla tua decisione di farti frate: quando e come è successa?
C’è un fatto storico, chiamiamolo così, e poi c’è un’amicizia spirituale con un frate che adesso non c’è più, padre Bruno Quercetti, missionario in Brasile, mandato via dalla dittatura alla fine degli anni Settanta. Il fatto storico è questo: il 6 dicembre del 1990, un aereo militare cade sulla scuola Salvemini di Casalecchio di Reno causando la morte di undici ragazze e di un ragazzino. Io allora ero assessore ai Servizi sociali e alla Sanità di Casalecchio. Subito dopo il disastro il sindaco ci chiamò a raccolta e ci ritrovammo di fronte alla scuola che stava ancora bruciando. Fu sconvolgente. Poi, nella suddivisione dei compiti, il sindaco mi chiese di andare in via Irnerio, alla Medicina legale, per accompagnare i genitori al riconoscimento dei cadaveri. Le salme erano allineate a terra, carbonizzate, quindi difficili da riconoscere se non per i pochi oggetti, orecchini, apparecchi dentali... Ricordo l’odore di kerosene e le urla dei familiari. Ecco, lì ho avuto… ho sentito una domanda pesante, del tipo “io cosa ci faccio qui? Che responsabilità ho di questa cosa terribile?”. Sì, fu il dolore dei familiari a entrarmi dentro. Mi arrabbiai anche con alcuni giornalisti che erano invadenti nel momento più drammatico dopo l’incidente stesso. Poi ci fu la calca negli ospedali per andare dai feriti, che erano novanta, chi con ustioni, a volte su tutto il corpo, chi con fratture, perché qualcuno si era buttato dalla finestra del secondo piano dell’altra ala della scuola. E poi seguì il periodo del recupero della memoria dei ragazzi, dei funerali, e di quello che poteva essere il corso delle indagini. Lì poi il ministero della Difesa la fece da padrone rispetto a quello della Pubblica istruzione, tant’è che ci fu pure un conflitto anche legale per chi dovesse pagare i danni. Il ministero della Difesa voleva liquidare in quattro e quattr’otto i familiari per rimuovere il fatto che il giovane pilota si era lanciato giù dall’aereo in panne durante quella che era un’esercitazione prebellica. Il 18 gennaio ci fu l’attacco all’Iraq.
Questo è il fatto storico, dicevi di uno più personale...
Il fatto personale, diciamo di tipo spirituale, è stato un insieme di concomitanze, di incontri con persone, con memorie, e anche con una mia fragilità spirituale, che si può pensare anomala in chi ha fatto politica, in uno che veniva da Lotta continua. Un insieme di incroci ha fatto venire alla luce quello che ho chiamato a suo tempo un sangue teologico che chiedeva delle risposte. Ma anche qui furono due fatti a spingermi a cambiare la mia vita. Uno fu la morte di Francesco Lo Russo, un amico carissimo, ucciso a Bologna dai carabinieri durante uno scontro con noi ex di Lotta continua. Francesco l’avevo conosciuto a Lourdes, facevamo i barellieri dei malati. Lui era uno scout del Pesaro 1. C’è il libro di Guidelli, un giornalista di Pesaro del “Resto del Carlino”, in cui racconta la storia di Francesco, anche quella religiosa. C’è una foto in cui lui è inginocchiato e in fondo, dietro, si intravedono degli scout della squadriglia cui apparteneva. Quel giorno l’assistente spirituale li confessava. Erano in una route e nella route era compreso quel momento religioso. Sì, ci siamo conosciuti a Lourdes e certamente quando sei fuori, e per di più in posto come quello, accampati con le tende, non è difficile fare amicizia. Poi ci siamo sentiti, avevamo 15-16 anni, adesso non ricordo bene, siamo comunque negli anni Sessanta, gli anni del liceo, io del classico, lui dello scientifico. Io sono del ’52 come Francesco. Quindi, sì, eravamo diventati amici da prima della politica tosta. Il suo papà, comandante della caserma dei soldati a Pesaro, fu trasferito a Bologna e quindi ci ritrovammo insieme all’università negli anni Settanta. Ci siamo iscritti nel ’71, avevamo 19 anni… E su Lotta continua ci abbiamo sbattuto il muso subito. Ovviamente avevamo dei maestri, Gianni Sofri, Franco Travaglini, tanto per dirne due, tutti personaggi storici, insomma.
Dopo la morte di Francesco mandai all’aria e al diavolo tutto quello che avevo fatto fino a quel momento lì, che non era niente di che, ma era importante da un punto di vista morale perché, e apro una parentesi, mi ero pure avvicinato alla lotta armata, avendo toccato un distaccamento di Prima linea. Intendiamoci, dal punto di vista, diciamo, terroristico, non ho mai partecipato a niente, ho offerto da dormire a qualcuno e qualche volta ho consegnato dei pacchi da Bologna a non ricordo dove, e senza sapere cosa ci fosse dentro. Francesco non ne sapeva niente, glielo raccontai, lo ricordo bene, dopo un paio di anni.
E lo scioglimento di Lotta continua, come l’hai vissuto?
Di quel periodo in cui ci fu il congresso di fine ottobre, a Rimini, mi ricordo solo una cosa, che adesso darà fastidio a qualcuno se la leggerà, che sentii durante l’unico giorno in cui fui presente, l’ultimo, e più per curiosità che per altro, perché oramai lo scioglimento era nell’aria. Ebbene, a congresso finito sentii un gruppetto di donne che dicevano: “Maschio, represso, masturbati nel cesso!”, e dei maschi che rispondevano: “Figa, cretina, masturbati in cantina”. Goliardate. Mi dissi che non era più roba per me. Mi avvicinai al movimento, non dico dell’Autonomia, ma a quello più indiano-metropolitano, e soprattutto continuai l’amicizia con Francesco. Anche se, in verità, ci sentivamo ancora di Lotta continua, perché c’erano ancora i locali, c’era il nostro archivio e anche diversi compagni che sapevamo capaci di riaprire un percorso nuovo con altre motivazioni.
Poi arriva l’11 marzo del ’77...
Sì, come ho detto, è quella la data. La morte di Francesco mi fece fare la prima scelta antipolitica, per come intendevo la politica fino ad allora: essere un amministratore che va in mezzo alla gente e non più un contestatore che fa azioni sempre più difficili da considerare legittime, man mano che si andava avanti. Così sono stato amministratore per undici anni a Casalecchio di Reno. In quel periodo mi sono anche sposato con una ragazza friulana, abbastanza ricca e soprattutto bella, ma abbiamo divorziato dopo nove mesi, non abbiamo fatto in tempo neanche a fare un bambino.
Ruppi il rapporto con lei, anche maleducatamente, dopo che mi aveva chiesto di partecipare, essendo lei molto carina, a quella trasmissione con Columbro, a Canale 5, “Tra moglie e marito”; “il gioco delle coppie” lo chiamavano. Siamo rimasti ventitré puntate. Immagini cosa vuol dire ventitré puntate? Eravamo la coppia che aveva vinto di più anche in termini di gettoni di presenza… Sì, ha vinto lei. Poi abbiamo interrotto, ho sciolto la liberatoria, ho detto che non potevo più partecipare perché non eravamo più una coppia, che avevamo litigato proprio per colpa loro... Ma questo è gossip. Quindi ho divorziato…
Questo quando?
Erano i primi anni Ottanta. Comunque, dopo circa dieci anni, quando ero alla terza legislatura da assessore, il disastro della scuola di quel 6 dicembre mi portò a chiedere l’aspettativa. Ero in crisi, volevo pensare a cosa fare, come rapportare le mie idee al mio impegno, se aveva ancora un senso la mia presenza nel mondo politico o amministrativo. Ed è stato in quel periodo che nella mia vita si intrufolò anche un certo Gesù Cristo. Un giorno, e questo è il secondo fatto decisivo di cui ti dicevo, incontrai per caso, proprio sotto i portici dei Servi a Bologna, in Strada Maggiore, padre Bruno Quercetti, che conoscevo già perché era stato educatore al liceo. Era subito dopo Natale. Ci facemmo un po’ di feste, poi lui, dopo aver saputo tutto quello che era successo, mi disse: “Benito guarda, ti do qualche suggerimento su come superare questa tua fatica di credere e soprattutto di vivere”. Io mi fidai. Mi fece l’offerta di andare con lui in Brasile due-tre mesi insieme a un gruppo di scout…
Così passai tre mesi in Amazzonia, in una missione dei frati serviti, nella regione di Rio Branco, la capitale, di cui era vescovo Moacyr Grechi, teologo della liberazione. Era la terra dei fratelli Boff. Per cui fu un trimestre anche molto istruttivo. Vedendo come si viveva in quelle terre, ci schierammo subito con i seringueiros perseguitati dai fazendeiros che li volevano scacciare dalla foresta. Poi c’erano queste nuove truppe di bianchi, legate alle multinazionali, che cercavano di bruciare mezza foresta per alimentare le mucche per gli hamburger della McDonalds.
In quel periodo per tanti religiosi la violenza poteva essere giustificata...
Sul piano interiore, dal punto di vista della volontà, avevo chiuso con la violenza, però avendo visto come venivano trattati i serenguieros e tutto il resto, era inevitabile sentire un’attrazione legata al senso della giustizia, insomma. Poi, certo, se avessi dovuto difendermi non avrei esitato a colpire. Pensa che Chico Mendez era un nostro catechista, dei servi di Maria di Xapuri, vicino a Sena Madureira, distante da Rio Branco un centinaio di chilometri. Apro un’altra parentesi: fu un frate bastardo, un servita, Pellegrino si chiamava
-aveva preso il nome dal santo- a far catturare Che Guevara, indicando il giorno, l’ora e il luogo in cui si sarebbe trovato coi suoi. Lo disse ai servizi segreti brasiliani, che avvisarono quelli boliviani. Non so come l’avesse saputo, ma è lui il colpevole della cattura di Che Guevara da parte dell’esercito boliviano, e quindi anche della sua uccisione.
Per dire, insomma, come il senso della violenza veniva vissuto, anche perché non eri solo, ti sentivi già perdonato se c’era qualcosa che non andava.
Padre Bruno Quercetti però era una persona di grande tenerezza, una persona fragile, piangeva se vedeva piangere un bambino. Con Bruno avevo un rapporto molto personale, spirituale. Ricordo delle serate a cielo aperto, il bellissimo cielo brasiliano, che fa luce, perché non disturbato da quella artificiale, e guardando le stelle dicevamo sì le nostre sciocchezze, ma cercando di apprendere meglio quali erano i punti di vista della Chiesa, i punti di vista spirituali, la verità o meno della Bibbia, tutte domande nuove per uno come me, malgrado la formazione cattolica ricevuta da una mamma ragazza madre.
Dopo quell’esperienza padre Bruno mi mise con le spalle al muro, mi disse che era ora che prendessi una strada diversa. Abbiamo cercato di fare una preparazione libera, piena di sentimenti e anche di ideali… Allora seguire la teologia della liberazione era come essere partigiani nascosti, anche rispetto alla titolarità dei religiosi, cioè ai vescovi. In Brasile avevamo avuto quel benedetto vescovo lì e avevamo succhiato tutto quello che si poteva per affrontare anche dentro la chiesa un percorso di vita. Allora mi hanno accolto all’eremo di Rozzano, dei Serviti, che è lì da 1.200 anni, sopra Bologna. Lì ho respirato un’aria molto tranquilla, serena. Ne parlarono i giornali, perché ovviamente passare da assessore a frate fa un poco notizia, e poi anche il cardinale Biffi, ammiccò un pochino perché aveva letto dei miei precedenti politici… Poi la giunta di Casalecchio era sempre stata di sinistra, Pci e Psi. Ultimamente con il Pd non si capisce più niente, però la storia di Casalecchio è quella di un Partito comunista tosto, duro, che ha avuto come sindaco anche Floriano Ventura, uno che girava con la pistola a Reggio Calabria quando ci fu il “boia chi molla”… Avevano mandato lui come commissario del partito. Ed era stato proprio lui, quando divenne sindaco di Casalecchio, a invitarmi in pizzeria per una chiacchierata, e così divenni assessore.
Io ero con la componente socialista, perché avevo fatto amicizia all’università con Franco Piro. Franco era una persona molto intelligente, ma con un carattere anche un po’ difficile, forse per il suo stato di salute e anche per il fatto di essere in carrozzina. Quando morì fui io a fargli il funerale e alla basilica dei Servi c’era mezzo Partito socialista .
Veniamo alla fede. Quindi, decidi di farti frate. Eri sempre rimasto credente?
Credente, però non praticante. La mamma era religiosissima, è stata anche nel consiglio pastorale di Casalecchio. Sì, ho seguito le orme di padre Bruno Quercetti che era, tra l’altro, uno degli ultimi allievi di David Turoldo. Era responsabile del centro missionario servita, dove ha lavorato bene e mi ha insegnato bene, tant’è che quell’incarico nazionale in seguito lo assunsi anch’io. Così cominciai a girare, a fare propaganda, portando ad esempio proprio quello che era successo a me, quel che chiamavo “il riprendersi la vita”. Ogni anno portavo quindici, venti ragazzi, con me, in missione. Per ventitré anni sono stato due mesi all’anno nel sud dell’India, nel Tamil Nadu, con ragazzi che facevano volontariato. Sono stato in Brasile, certo, in Messico due volte. Poi ho fatto la campagna del Kosovo, sono stato anche premiato a suo tempo per il servizio di raccolta dei rifugiati e per aver difeso le donne rifugiate che gli albanesi andavano a rapire.
Un episodio che tengo a citare è l’incontro che con Michele Smargiassi riuscimmo a organizzare fra Giovanni Lorusso e Massimo Tramontani, il carabiniere che aveva ucciso Francesco. Su, all’eremo di Ronzano. Venne il fratello di Francesco, perché Agostino, il papà di Francesco, non era favorevole a incontrarlo né a perdonare. In realtà poi si venne a scoprire che quella di sparare non era stata l’iniziativa isolata di Tramontani, ma che ai carabinieri della camionetta colpita da una prima nostra molotov fu dato l’ordine da un carabiniere di cui non ricordo più il nome.
Loro hanno sparato dopo che voi avevato lanciato le molotov...
Sì, erano già state lanciate…
E loro hanno reagito sparando.
Esatto. Proprio così.
C’era in corso un’assemblea di Comunione e liberazione. Cosa volevate fare voi?
Disturbare, sì. Anche perché senza che i compagni avessero mosso un dito, quelli di Cl avevano chiamato la polizia tramite il rettore. E questo fu considerato uno sgarbo. Allora si è detto: se siamo già stati bollati per aver fatto qualcosa che non abbiamo ancora fatto cominciamo a fare qualcosa. Adesso non ricordo, ma qualche cazzottone arrivò a qualcuno, nessuno però aveva bastoni.
Torniamo alla fede. Ne discutiamo ogni tanto, l’impressione è che la fede sia in una crisi profonda, come una cosa astratta.
Sì, si deve ripartire dal concreto. La parte della concretezza della fede è importante perché è quella che ti consente di assumerti delle responsabilità dell’altro. Responsabilità non contro l’altro, ma con l’altro. Una chiesa della partecipazione.
Quella che noi chiamavamo “la chiesa dei poveri”, adesso, in questo tempo, quella ideale la chiamiamo “la chiesa della tenerezza”, cioè dei modi gentili. La fede dell’innamoramento di Dio ha dentro anche visioni che non sono esclusivamente cristiane o cattoliche, ma universali. Tu che hai avuto la fortuna di conoscere e di leggere il suo amico Camillo de Piaz, leggi Turoldo e allora capirai che tra il nulla e niente c’è differenza. Che Dio può essere chiamato anche “il nulla”, il nulla che ti coinvolge e che ti fa perdere te stesso per identificarti nell’altro. So di dire cose che sembrano slogan... Anche in Lotta continua alla sua fondazione la componente cattolica credo sia stata importante, almeno per metà direi. E alcuni di noi venivano dallo scoutismo che è la ricerca di una formazione alla libertà anche dentro la chiesa. Infatti non è che lo scoutismo sia stato accolto facilmente dalle parrocchie. Questa idea del frate, della persona di riferimento, che ha esperienza, come padre Bruno per me, questo c’è anche nello scoutismo. Non è un caso che in tutte le nostre case parrocchiali, noi serviti non ne abbiamo tante, ma in quelle poche ci sono anche i gruppi scout. Lì, più che degli insegnamenti, si fa esperienza della comprensione degli altri, dello stare in comunità non egocentriche... Ti decentra lo scoutismo. Non c’è il leader, ci sono delle figure o delle contro-figure. Ecco.
Poi, riprendendo il discorso della fede, voglio dire che per me Dio non va antropomoformizzato. Dio per me è più legato a un sistema tra virgolette “elettrico”. Di luce. Di qualche cosa di meraviglioso che può entrare e uscire da te con indifferenza, senza rovinarti, oppure per rovinare per sempre quelli che sono i tuoi disegni più… diciamo, di bassa lega. Tenendo però sempre presente che dalla bassa lega ci si passa sempre. Questo l’ho sperimentato. C’è un noviziato da fare, per toglierci di dosso quelle che possono essere le ferite che l’altro non vede in te o che addirittura ti procura con le sue scelte.
E poi ci sono figure legate alla cristianità molto belle. Quella che ci ha fatto più sognare è certamente quella di san Francesco, che, infatti, era concretissima. Ci sono poi uomini e donne nascosti, senza una visibilità particolare, persi qua e là, che sono santi meravigliosi. Francesco è riuscito anche a dare una visibilità, però di quello che lui ha detto è stato fatto quello che ha detto di peggio, non di meglio.
Poi noi serviti abbiamo questa caratteristica della femminilità, da corredare con l’umanità maschile. Perché la figura di Maria è sempre una figura di viscere, di un amore che ti provoca nel corpo e che quindi può dare anche delle misure di come vivere o cambiare vita. Perché il femminile dà la vita, no? Anche nei verbi che usiamo, l’uomo penetra, è sgarbato, la donna invece accoglie.
Sulla scelta di farti frate non hai mai avuto un ripensamento?
No, un ripensamento mai. Ho tanta gente che mi vuole bene, anche tante donne che mi vogliono bene. Forse prima ero un po’ più libertino, e però io ho consumato tutte le possibilità di fare il peggio. Adesso ho solo la possibilità di fare il meglio.
Ho 72 anni, ne faccio 73 tra dieci giorni, se dovessi tornare indietro farei più o meno gli stessi passi, con un po’ di saggezza in più e qualche cosa, forse, di più coraggioso. Poi vorrei recuperare alcune cose. Mi mancano tre esami per due lauree. Tre esami, due di giurisprudenza e uno di scienze politiche. Poi una laurea ce l’ho, quella teologica.
Ti sei fatto anche prete?
Sì, sono prete. L’anno scorso ho compiuto trent’anni di frate, quest’anno ho compiuto venticinque anni di sacerdozio. Quindi ho fatto anche quel cammino lì.
Ecco, ad esempio, la possibilità di confessare io l’ho sempre vista come il dare del tu all’altro. Che vuol dire che ci sono affinità, da mettere insieme, se sono affettive o meno, se sono in qualche modo macchiate da qualche cosa. Quello che ha dato fastidio a tanta gente, anche a me, anche adesso, è questo rigore, questa rigidità della Chiesa nelle sue norme canoniche. è qualche cosa di talmente staccato da quello che ci insegna il Vangelo, talmente fuori misura... Per questo ho perso tempo ad approfondire, insomma, ho dovuto trovare il tempo di studiare anche da solo, non seguito, e mi sono scelto i biblisti migliori, quelli viventi e quelli morti, grandi come Turoldo. Studiosi che spesso sono anche poeti. Tante volte diciamo le cose con la poesia, che secondo me è una feritoia di luce importante per ogni singola persona. Non solo per il prete o il frate. Allora no, non ritorno indietro, tant’è vero che adesso sono fuori dal convento, sono in extra claustra, che vuol dire che ci è consentito di prendere uno, o tre anni, di vita fuori dal convento, di vita vagabonda, si direbbe. Con motivazioni, con progetti, scritti, insomma, però libero di fare le cose dove mi pare e quando mi pare.
Poi adesso sono nell’incertezza se diventare diocesano...
Che vuol dire?
Vuol dire legarsi alla diocesi e non all’ordine. Perché tanto l’ordine non lo getto più via, anche se non ci vado sono frate, lo sarò sempre. Le tre dichiarazioni, di castità, povertà e obbedienza, rimangono sempre, misurandole su di te, con l’aiuto anche di altre persone che ti consigliano nelle difficoltà che si hanno nel rispettare i tre voti. Bisogna avere infatti sempre un riferimento spirituale altro da te, per aiutarti a dare un tuo volto ai voti. Io mi sono avvicinato al buon padre Giancarlo Bruni, figlio di anarchici e pieno di anarchia anche lui; mi ha dato delle risposte di libertà molto importanti che mi hanno aiutato a superare anche delle piccole crisi...
Come vedi la Chiesa?
Per adesso la vedo molto, troppo esposta a dei confronti che non riesce a superare. Si riescono a superare di più dei negoziati di pace, faccio per dire, che non dei negoziati di libertà all’interno della Chiesa. Noi abbiamo un castello che non si riesce a conquistare: il Vaticano. Attualmente il Papa ha dato disponibilità a tanti ruoli primari come vescovati e cardinalizi, gli si vuole certamente più bene rispetto a tutti gli altri papi per come si comporta, però rischia di fare esplodere all’interno la parte che se diventa vincente siamo tutti rovinati, rovinati nel senso che non ci sarà più spazio di libertà nella Chiesa. Noi non ce ne accorgiamo, ma papa Francesco ha tagliato con delle cesoie ben solide tanti aspetti che prima erano intoccabili. Poi spontaneamente dice anche cose spiacevoli per chi ascolta come per esempio questo benedetto rapporto sul fatto che non ci siano donne prete, insomma, o con un ruolo diverso ma importante… Forse lui lo farebbe in un quarto d’ora, il problema è che un quarto d’ora dopo che l’ha fatto ci sarà qualcuno che fa scismi se non di più.
La misura di come sta la Chiesa la danno i ciellini. Già adesso li vedo, io li riconosco subito, sono sempre stato inseguito dai ciellini, sapevano come la pensavo. Quando ero a Misano Adriatico, perché ero il direttore dell’istituto San Pellegrino, un liceo linguistico, non mi hanno voluto neanche nel consiglio presbiterale. Sono migliori solo quando non toccano la Compagnia delle Opere, perché quella è proprio una banda armata. A dirlo così sembra quasi che ce l’abbia con loro, ma non è vero. Al liceo ho avuto un grande amico, morto poi in un incidente stradale, Enzo Piccinini, che era il capo dei ciellini di Modena e Bologna e amico intimo di don Giussani. No, non sono prevenuto, vedo quello che fanno. Stanno rimbambendo le nuove generazioni.
Mi sembra che ci sia tutta una parte che rimprovera questo Papa ed esalta quello precedente per la questione, se ho capito bene, della verità. Questa cosa della verità mi sembra fuori dal tempo, anche perché moltissimi non ci credono più e allora un cristianesimo vincolato solo alla verità non avrebbe più nulla da dire. Bah, questa mia è sicuramente una sciocchezza, lasciamola perdere...
Ma non è una sciocchezza, è una cosa seria. La verità è qualcosa che devi imparare a memoria, invece la fede è qualcosa di concreto e quotidiano. Chi sceglie la verità sceglie la religione. Ma quando è nato Gesù Cristo la religione è morta, con lui è nata la fede. La fede è il nuovo modo di esprimere la verità, non una verità da imparare a memoria, ma una verità da fare. È da fare, la verità. E non ha tutti quei contorni rigidi, inflessibili, impetuosi e assolutistici che esprimi con la verità. Con la fede puoi esprimere tutta la fantasia che Dio ha in te. Tutta. E quindi sei uno sperimentatore, sei un dio, hai una parte divina in te. Questo è concretezza. Cristo si è consegnato alla fede sulla croce, perché sulla croce perdeva la luce e ha detto al Signore: “Perdonami e non abbandonarmi”. E quindi è qualche cosa che è ancora da raccogliere, ancora da fare. Lì ha fatto fino a un certo punto. Poi sulla risurrezione, è vera o non è vera, la luce è vera o non è vera? Noi abbiamo un rapporto umano con Dio, il quale ci dà la possibilità di abbracciare la sua divinità ed essere divini anche noi, il che non ha nulla a che fare con i miracolismi vari che si accompagnano da sempre a questa parola e che vanno spazzati via. Sì, una concretezza labile, ma profonda nello stesso tempo. Qualche cosa che può farti cambiare la vita, insomma.
Concludiamo con una curiosità. Prima di iniziare avevi fatto un accenno alla maledizione del nome, “Benito”...
Ho dovuto lottare tutta la vita contro il mio nome. Sì, lo devo a mia madre, “Benito”. Lei me l’ha sempre raccontata così: “L’avevo promesso allo zio, lo zio l’hanno ucciso e così ti ho dato quel nome”. Per fortuna poi mia madre era molto avveduta, aveva molta creatività, e mi mandò a fare amicizia con il figlio Nino del sindaco Renato Giorgi, dottore e capo partigiano. La sua brigata fu la prima a entrare a Casalecchio di Reno nel ’44, circa. Liberarono prima Casalecchio e dopo Bologna, il 21 aprile. Fra un po’ c’è l’anniversario dei partigiani che furono legati con il fil di ferro in una stradina di Casalecchio, oggi diventata una piazza dedicata a loro.
E lo zio fu ucciso dagli antifascisti?
Sì. Perché lui era il podestà fascista di Bondeno, fratello gemello del papà di mia madre. Questi però non era fascista per niente, anzi erano in lite, loro due. Ma mio nonno morì. Per una sciocchezza: la notte del 6 gennaio si era vestito da befanone e, attraversando un ponticello mezzo ghiacciato su un canale lì a Bondeno, scivolò e si infilò una scheggia di legno nella mano. Dopo una settimana aveva il braccio nero: tetano. Aveva undici figli, mia madre aveva dieci anni. A quel punto la nonna vedova, non potendo allevarli tutti da sola, li distribuì ai fratelli, gli zii cioè, numerosi anche loro. Mia madre capitò sotto lo zio Pietro, quello più politicizzato. Infatti lo diceva a mia madre, che lui avrebbe fatto una brutta fine, perché aveva distribuito molto olio di ricino durante la sua militanza e poi, si diceva, che facesse del mercato nero con altri leader fascisti di quella zona lì, del ferrarese dove i fascisti non mancavano. Però i partigiani segnavano conto e quando ebbero possibilità di farlo, ne uccisero parecchi. Lo zio con altri fu seppellito vivo, dicono, sulla sponda del Po. Per mia madre fu come perdere il secondo papà. E allora cosa fai ai partigiani per vendicare lo zio? Chiami tuo figlio Benito! Cazzo, me la sono dovuta vedere io, dopo, questa cosa qui!
(a cura di Gianni Saporetti)
Partiamo dalla tua decisione di farti frate: quando e come è successa?
C’è un fatto storico, chiamiamolo così, e poi c’è un’amicizia spirituale con un frate che adesso non c’è più, padre Bruno Quercetti, missionario in Brasile, mandato via dalla dittatura alla fine degli anni Settanta. Il fatto storico è questo: il 6 dicembre del 1990, un aereo militare cade sulla scuola Salvemini di Casalecchio di Reno causando la morte di undici ragazze e di un ragazzino. Io allora ero assessore ai Servizi sociali e alla Sanità di Casalecchio. Subito dopo il disastro il sindaco ci chiamò a raccolta e ci ritrovammo di fronte alla scuola che stava ancora bruciando. Fu sconvolgente. Poi, nella suddivisione dei compiti, il sindaco mi chiese di andare in via Irnerio, alla Medicina legale, per accompagnare i genitori al riconoscimento dei cadaveri. Le salme erano allineate a terra, carbonizzate, quindi difficili da riconoscere se non per i pochi oggetti, orecchini, apparecchi dentali... Ricordo l’odore di kerosene e le urla dei familiari. Ecco, lì ho avuto… ho sentito una domanda pesante, del tipo “io cosa ci faccio qui? Che responsabilità ho di questa cosa terribile?”. Sì, fu il dolore dei familiari a entrarmi dentro. Mi arrabbiai anche con alcuni giornalisti che erano invadenti nel momento più drammatico dopo l’incidente stesso. Poi ci fu la calca negli ospedali per andare dai feriti, che erano novanta, chi con ustioni, a volte su tutto il corpo, chi con fratture, perché qualcuno si era buttato dalla finestra del secondo piano dell’altra ala della scuola. E poi seguì il periodo del recupero della memoria dei ragazzi, dei funerali, e di quello che poteva essere il corso delle indagini. Lì poi il ministero della Difesa la fece da padrone rispetto a quello della Pubblica istruzione, tant’è che ci fu pure un conflitto anche legale per chi dovesse pagare i danni. Il ministero della Difesa voleva liquidare in quattro e quattr’otto i familiari per rimuovere il fatto che il giovane pilota si era lanciato giù dall’aereo in panne durante quella che era un’esercitazione prebellica. Il 18 gennaio ci fu l’attacco all’Iraq.
Questo è il fatto storico, dicevi di uno più personale...
Il fatto personale, diciamo di tipo spirituale, è stato un insieme di concomitanze, di incontri con persone, con memorie, e anche con una mia fragilità spirituale, che si può pensare anomala in chi ha fatto politica, in uno che veniva da Lotta continua. Un insieme di incroci ha fatto venire alla luce quello che ho chiamato a suo tempo un sangue teologico che chiedeva delle risposte. Ma anche qui furono due fatti a spingermi a cambiare la mia vita. Uno fu la morte di Francesco Lo Russo, un amico carissimo, ucciso a Bologna dai carabinieri durante uno scontro con noi ex di Lotta continua. Francesco l’avevo conosciuto a Lourdes, facevamo i barellieri dei malati. Lui era uno scout del Pesaro 1. C’è il libro di Guidelli, un giornalista di Pesaro del “Resto del Carlino”, in cui racconta la storia di Francesco, anche quella religiosa. C’è una foto in cui lui è inginocchiato e in fondo, dietro, si intravedono degli scout della squadriglia cui apparteneva. Quel giorno l’assistente spirituale li confessava. Erano in una route e nella route era compreso quel momento religioso. Sì, ci siamo conosciuti a Lourdes e certamente quando sei fuori, e per di più in posto come quello, accampati con le tende, non è difficile fare amicizia. Poi ci siamo sentiti, avevamo 15-16 anni, adesso non ricordo bene, siamo comunque negli anni Sessanta, gli anni del liceo, io del classico, lui dello scientifico. Io sono del ’52 come Francesco. Quindi, sì, eravamo diventati amici da prima della politica tosta. Il suo papà, comandante della caserma dei soldati a Pesaro, fu trasferito a Bologna e quindi ci ritrovammo insieme all’università negli anni Settanta. Ci siamo iscritti nel ’71, avevamo 19 anni… E su Lotta continua ci abbiamo sbattuto il muso subito. Ovviamente avevamo dei maestri, Gianni Sofri, Franco Travaglini, tanto per dirne due, tutti personaggi storici, insomma.
Dopo la morte di Francesco mandai all’aria e al diavolo tutto quello che avevo fatto fino a quel momento lì, che non era niente di che, ma era importante da un punto di vista morale perché, e apro una parentesi, mi ero pure avvicinato alla lotta armata, avendo toccato un distaccamento di Prima linea. Intendiamoci, dal punto di vista, diciamo, terroristico, non ho mai partecipato a niente, ho offerto da dormire a qualcuno e qualche volta ho consegnato dei pacchi da Bologna a non ricordo dove, e senza sapere cosa ci fosse dentro. Francesco non ne sapeva niente, glielo raccontai, lo ricordo bene, dopo un paio di anni.
E lo scioglimento di Lotta continua, come l’hai vissuto?
Di quel periodo in cui ci fu il congresso di fine ottobre, a Rimini, mi ricordo solo una cosa, che adesso darà fastidio a qualcuno se la leggerà, che sentii durante l’unico giorno in cui fui presente, l’ultimo, e più per curiosità che per altro, perché oramai lo scioglimento era nell’aria. Ebbene, a congresso finito sentii un gruppetto di donne che dicevano: “Maschio, represso, masturbati nel cesso!”, e dei maschi che rispondevano: “Figa, cretina, masturbati in cantina”. Goliardate. Mi dissi che non era più roba per me. Mi avvicinai al movimento, non dico dell’Autonomia, ma a quello più indiano-metropolitano, e soprattutto continuai l’amicizia con Francesco. Anche se, in verità, ci sentivamo ancora di Lotta continua, perché c’erano ancora i locali, c’era il nostro archivio e anche diversi compagni che sapevamo capaci di riaprire un percorso nuovo con altre motivazioni.
Poi arriva l’11 marzo del ’77...
Sì, come ho detto, è quella la data. La morte di Francesco mi fece fare la prima scelta antipolitica, per come intendevo la politica fino ad allora: essere un amministratore che va in mezzo alla gente e non più un contestatore che fa azioni sempre più difficili da considerare legittime, man mano che si andava avanti. Così sono stato amministratore per undici anni a Casalecchio di Reno. In quel periodo mi sono anche sposato con una ragazza friulana, abbastanza ricca e soprattutto bella, ma abbiamo divorziato dopo nove mesi, non abbiamo fatto in tempo neanche a fare un bambino.
Ruppi il rapporto con lei, anche maleducatamente, dopo che mi aveva chiesto di partecipare, essendo lei molto carina, a quella trasmissione con Columbro, a Canale 5, “Tra moglie e marito”; “il gioco delle coppie” lo chiamavano. Siamo rimasti ventitré puntate. Immagini cosa vuol dire ventitré puntate? Eravamo la coppia che aveva vinto di più anche in termini di gettoni di presenza… Sì, ha vinto lei. Poi abbiamo interrotto, ho sciolto la liberatoria, ho detto che non potevo più partecipare perché non eravamo più una coppia, che avevamo litigato proprio per colpa loro... Ma questo è gossip. Quindi ho divorziato…
Questo quando?
Erano i primi anni Ottanta. Comunque, dopo circa dieci anni, quando ero alla terza legislatura da assessore, il disastro della scuola di quel 6 dicembre mi portò a chiedere l’aspettativa. Ero in crisi, volevo pensare a cosa fare, come rapportare le mie idee al mio impegno, se aveva ancora un senso la mia presenza nel mondo politico o amministrativo. Ed è stato in quel periodo che nella mia vita si intrufolò anche un certo Gesù Cristo. Un giorno, e questo è il secondo fatto decisivo di cui ti dicevo, incontrai per caso, proprio sotto i portici dei Servi a Bologna, in Strada Maggiore, padre Bruno Quercetti, che conoscevo già perché era stato educatore al liceo. Era subito dopo Natale. Ci facemmo un po’ di feste, poi lui, dopo aver saputo tutto quello che era successo, mi disse: “Benito guarda, ti do qualche suggerimento su come superare questa tua fatica di credere e soprattutto di vivere”. Io mi fidai. Mi fece l’offerta di andare con lui in Brasile due-tre mesi insieme a un gruppo di scout…
Così passai tre mesi in Amazzonia, in una missione dei frati serviti, nella regione di Rio Branco, la capitale, di cui era vescovo Moacyr Grechi, teologo della liberazione. Era la terra dei fratelli Boff. Per cui fu un trimestre anche molto istruttivo. Vedendo come si viveva in quelle terre, ci schierammo subito con i seringueiros perseguitati dai fazendeiros che li volevano scacciare dalla foresta. Poi c’erano queste nuove truppe di bianchi, legate alle multinazionali, che cercavano di bruciare mezza foresta per alimentare le mucche per gli hamburger della McDonalds.
In quel periodo per tanti religiosi la violenza poteva essere giustificata...
Sul piano interiore, dal punto di vista della volontà, avevo chiuso con la violenza, però avendo visto come venivano trattati i serenguieros e tutto il resto, era inevitabile sentire un’attrazione legata al senso della giustizia, insomma. Poi, certo, se avessi dovuto difendermi non avrei esitato a colpire. Pensa che Chico Mendez era un nostro catechista, dei servi di Maria di Xapuri, vicino a Sena Madureira, distante da Rio Branco un centinaio di chilometri. Apro un’altra parentesi: fu un frate bastardo, un servita, Pellegrino si chiamava
-aveva preso il nome dal santo- a far catturare Che Guevara, indicando il giorno, l’ora e il luogo in cui si sarebbe trovato coi suoi. Lo disse ai servizi segreti brasiliani, che avvisarono quelli boliviani. Non so come l’avesse saputo, ma è lui il colpevole della cattura di Che Guevara da parte dell’esercito boliviano, e quindi anche della sua uccisione.
Per dire, insomma, come il senso della violenza veniva vissuto, anche perché non eri solo, ti sentivi già perdonato se c’era qualcosa che non andava.
Padre Bruno Quercetti però era una persona di grande tenerezza, una persona fragile, piangeva se vedeva piangere un bambino. Con Bruno avevo un rapporto molto personale, spirituale. Ricordo delle serate a cielo aperto, il bellissimo cielo brasiliano, che fa luce, perché non disturbato da quella artificiale, e guardando le stelle dicevamo sì le nostre sciocchezze, ma cercando di apprendere meglio quali erano i punti di vista della Chiesa, i punti di vista spirituali, la verità o meno della Bibbia, tutte domande nuove per uno come me, malgrado la formazione cattolica ricevuta da una mamma ragazza madre.
Dopo quell’esperienza padre Bruno mi mise con le spalle al muro, mi disse che era ora che prendessi una strada diversa. Abbiamo cercato di fare una preparazione libera, piena di sentimenti e anche di ideali… Allora seguire la teologia della liberazione era come essere partigiani nascosti, anche rispetto alla titolarità dei religiosi, cioè ai vescovi. In Brasile avevamo avuto quel benedetto vescovo lì e avevamo succhiato tutto quello che si poteva per affrontare anche dentro la chiesa un percorso di vita. Allora mi hanno accolto all’eremo di Rozzano, dei Serviti, che è lì da 1.200 anni, sopra Bologna. Lì ho respirato un’aria molto tranquilla, serena. Ne parlarono i giornali, perché ovviamente passare da assessore a frate fa un poco notizia, e poi anche il cardinale Biffi, ammiccò un pochino perché aveva letto dei miei precedenti politici… Poi la giunta di Casalecchio era sempre stata di sinistra, Pci e Psi. Ultimamente con il Pd non si capisce più niente, però la storia di Casalecchio è quella di un Partito comunista tosto, duro, che ha avuto come sindaco anche Floriano Ventura, uno che girava con la pistola a Reggio Calabria quando ci fu il “boia chi molla”… Avevano mandato lui come commissario del partito. Ed era stato proprio lui, quando divenne sindaco di Casalecchio, a invitarmi in pizzeria per una chiacchierata, e così divenni assessore.
Io ero con la componente socialista, perché avevo fatto amicizia all’università con Franco Piro. Franco era una persona molto intelligente, ma con un carattere anche un po’ difficile, forse per il suo stato di salute e anche per il fatto di essere in carrozzina. Quando morì fui io a fargli il funerale e alla basilica dei Servi c’era mezzo Partito socialista .
Veniamo alla fede. Quindi, decidi di farti frate. Eri sempre rimasto credente?
Credente, però non praticante. La mamma era religiosissima, è stata anche nel consiglio pastorale di Casalecchio. Sì, ho seguito le orme di padre Bruno Quercetti che era, tra l’altro, uno degli ultimi allievi di David Turoldo. Era responsabile del centro missionario servita, dove ha lavorato bene e mi ha insegnato bene, tant’è che quell’incarico nazionale in seguito lo assunsi anch’io. Così cominciai a girare, a fare propaganda, portando ad esempio proprio quello che era successo a me, quel che chiamavo “il riprendersi la vita”. Ogni anno portavo quindici, venti ragazzi, con me, in missione. Per ventitré anni sono stato due mesi all’anno nel sud dell’India, nel Tamil Nadu, con ragazzi che facevano volontariato. Sono stato in Brasile, certo, in Messico due volte. Poi ho fatto la campagna del Kosovo, sono stato anche premiato a suo tempo per il servizio di raccolta dei rifugiati e per aver difeso le donne rifugiate che gli albanesi andavano a rapire.
Un episodio che tengo a citare è l’incontro che con Michele Smargiassi riuscimmo a organizzare fra Giovanni Lorusso e Massimo Tramontani, il carabiniere che aveva ucciso Francesco. Su, all’eremo di Ronzano. Venne il fratello di Francesco, perché Agostino, il papà di Francesco, non era favorevole a incontrarlo né a perdonare. In realtà poi si venne a scoprire che quella di sparare non era stata l’iniziativa isolata di Tramontani, ma che ai carabinieri della camionetta colpita da una prima nostra molotov fu dato l’ordine da un carabiniere di cui non ricordo più il nome.
Loro hanno sparato dopo che voi avevato lanciato le molotov...
Sì, erano già state lanciate…
E loro hanno reagito sparando.
Esatto. Proprio così.
C’era in corso un’assemblea di Comunione e liberazione. Cosa volevate fare voi?
Disturbare, sì. Anche perché senza che i compagni avessero mosso un dito, quelli di Cl avevano chiamato la polizia tramite il rettore. E questo fu considerato uno sgarbo. Allora si è detto: se siamo già stati bollati per aver fatto qualcosa che non abbiamo ancora fatto cominciamo a fare qualcosa. Adesso non ricordo, ma qualche cazzottone arrivò a qualcuno, nessuno però aveva bastoni.
Torniamo alla fede. Ne discutiamo ogni tanto, l’impressione è che la fede sia in una crisi profonda, come una cosa astratta.
Sì, si deve ripartire dal concreto. La parte della concretezza della fede è importante perché è quella che ti consente di assumerti delle responsabilità dell’altro. Responsabilità non contro l’altro, ma con l’altro. Una chiesa della partecipazione.
Quella che noi chiamavamo “la chiesa dei poveri”, adesso, in questo tempo, quella ideale la chiamiamo “la chiesa della tenerezza”, cioè dei modi gentili. La fede dell’innamoramento di Dio ha dentro anche visioni che non sono esclusivamente cristiane o cattoliche, ma universali. Tu che hai avuto la fortuna di conoscere e di leggere il suo amico Camillo de Piaz, leggi Turoldo e allora capirai che tra il nulla e niente c’è differenza. Che Dio può essere chiamato anche “il nulla”, il nulla che ti coinvolge e che ti fa perdere te stesso per identificarti nell’altro. So di dire cose che sembrano slogan... Anche in Lotta continua alla sua fondazione la componente cattolica credo sia stata importante, almeno per metà direi. E alcuni di noi venivano dallo scoutismo che è la ricerca di una formazione alla libertà anche dentro la chiesa. Infatti non è che lo scoutismo sia stato accolto facilmente dalle parrocchie. Questa idea del frate, della persona di riferimento, che ha esperienza, come padre Bruno per me, questo c’è anche nello scoutismo. Non è un caso che in tutte le nostre case parrocchiali, noi serviti non ne abbiamo tante, ma in quelle poche ci sono anche i gruppi scout. Lì, più che degli insegnamenti, si fa esperienza della comprensione degli altri, dello stare in comunità non egocentriche... Ti decentra lo scoutismo. Non c’è il leader, ci sono delle figure o delle contro-figure. Ecco.
Poi, riprendendo il discorso della fede, voglio dire che per me Dio non va antropomoformizzato. Dio per me è più legato a un sistema tra virgolette “elettrico”. Di luce. Di qualche cosa di meraviglioso che può entrare e uscire da te con indifferenza, senza rovinarti, oppure per rovinare per sempre quelli che sono i tuoi disegni più… diciamo, di bassa lega. Tenendo però sempre presente che dalla bassa lega ci si passa sempre. Questo l’ho sperimentato. C’è un noviziato da fare, per toglierci di dosso quelle che possono essere le ferite che l’altro non vede in te o che addirittura ti procura con le sue scelte.
E poi ci sono figure legate alla cristianità molto belle. Quella che ci ha fatto più sognare è certamente quella di san Francesco, che, infatti, era concretissima. Ci sono poi uomini e donne nascosti, senza una visibilità particolare, persi qua e là, che sono santi meravigliosi. Francesco è riuscito anche a dare una visibilità, però di quello che lui ha detto è stato fatto quello che ha detto di peggio, non di meglio.
Poi noi serviti abbiamo questa caratteristica della femminilità, da corredare con l’umanità maschile. Perché la figura di Maria è sempre una figura di viscere, di un amore che ti provoca nel corpo e che quindi può dare anche delle misure di come vivere o cambiare vita. Perché il femminile dà la vita, no? Anche nei verbi che usiamo, l’uomo penetra, è sgarbato, la donna invece accoglie.
Sulla scelta di farti frate non hai mai avuto un ripensamento?
No, un ripensamento mai. Ho tanta gente che mi vuole bene, anche tante donne che mi vogliono bene. Forse prima ero un po’ più libertino, e però io ho consumato tutte le possibilità di fare il peggio. Adesso ho solo la possibilità di fare il meglio.
Ho 72 anni, ne faccio 73 tra dieci giorni, se dovessi tornare indietro farei più o meno gli stessi passi, con un po’ di saggezza in più e qualche cosa, forse, di più coraggioso. Poi vorrei recuperare alcune cose. Mi mancano tre esami per due lauree. Tre esami, due di giurisprudenza e uno di scienze politiche. Poi una laurea ce l’ho, quella teologica.
Ti sei fatto anche prete?
Sì, sono prete. L’anno scorso ho compiuto trent’anni di frate, quest’anno ho compiuto venticinque anni di sacerdozio. Quindi ho fatto anche quel cammino lì.
Ecco, ad esempio, la possibilità di confessare io l’ho sempre vista come il dare del tu all’altro. Che vuol dire che ci sono affinità, da mettere insieme, se sono affettive o meno, se sono in qualche modo macchiate da qualche cosa. Quello che ha dato fastidio a tanta gente, anche a me, anche adesso, è questo rigore, questa rigidità della Chiesa nelle sue norme canoniche. è qualche cosa di talmente staccato da quello che ci insegna il Vangelo, talmente fuori misura... Per questo ho perso tempo ad approfondire, insomma, ho dovuto trovare il tempo di studiare anche da solo, non seguito, e mi sono scelto i biblisti migliori, quelli viventi e quelli morti, grandi come Turoldo. Studiosi che spesso sono anche poeti. Tante volte diciamo le cose con la poesia, che secondo me è una feritoia di luce importante per ogni singola persona. Non solo per il prete o il frate. Allora no, non ritorno indietro, tant’è vero che adesso sono fuori dal convento, sono in extra claustra, che vuol dire che ci è consentito di prendere uno, o tre anni, di vita fuori dal convento, di vita vagabonda, si direbbe. Con motivazioni, con progetti, scritti, insomma, però libero di fare le cose dove mi pare e quando mi pare.
Poi adesso sono nell’incertezza se diventare diocesano...
Che vuol dire?
Vuol dire legarsi alla diocesi e non all’ordine. Perché tanto l’ordine non lo getto più via, anche se non ci vado sono frate, lo sarò sempre. Le tre dichiarazioni, di castità, povertà e obbedienza, rimangono sempre, misurandole su di te, con l’aiuto anche di altre persone che ti consigliano nelle difficoltà che si hanno nel rispettare i tre voti. Bisogna avere infatti sempre un riferimento spirituale altro da te, per aiutarti a dare un tuo volto ai voti. Io mi sono avvicinato al buon padre Giancarlo Bruni, figlio di anarchici e pieno di anarchia anche lui; mi ha dato delle risposte di libertà molto importanti che mi hanno aiutato a superare anche delle piccole crisi...
Come vedi la Chiesa?
Per adesso la vedo molto, troppo esposta a dei confronti che non riesce a superare. Si riescono a superare di più dei negoziati di pace, faccio per dire, che non dei negoziati di libertà all’interno della Chiesa. Noi abbiamo un castello che non si riesce a conquistare: il Vaticano. Attualmente il Papa ha dato disponibilità a tanti ruoli primari come vescovati e cardinalizi, gli si vuole certamente più bene rispetto a tutti gli altri papi per come si comporta, però rischia di fare esplodere all’interno la parte che se diventa vincente siamo tutti rovinati, rovinati nel senso che non ci sarà più spazio di libertà nella Chiesa. Noi non ce ne accorgiamo, ma papa Francesco ha tagliato con delle cesoie ben solide tanti aspetti che prima erano intoccabili. Poi spontaneamente dice anche cose spiacevoli per chi ascolta come per esempio questo benedetto rapporto sul fatto che non ci siano donne prete, insomma, o con un ruolo diverso ma importante… Forse lui lo farebbe in un quarto d’ora, il problema è che un quarto d’ora dopo che l’ha fatto ci sarà qualcuno che fa scismi se non di più.
La misura di come sta la Chiesa la danno i ciellini. Già adesso li vedo, io li riconosco subito, sono sempre stato inseguito dai ciellini, sapevano come la pensavo. Quando ero a Misano Adriatico, perché ero il direttore dell’istituto San Pellegrino, un liceo linguistico, non mi hanno voluto neanche nel consiglio presbiterale. Sono migliori solo quando non toccano la Compagnia delle Opere, perché quella è proprio una banda armata. A dirlo così sembra quasi che ce l’abbia con loro, ma non è vero. Al liceo ho avuto un grande amico, morto poi in un incidente stradale, Enzo Piccinini, che era il capo dei ciellini di Modena e Bologna e amico intimo di don Giussani. No, non sono prevenuto, vedo quello che fanno. Stanno rimbambendo le nuove generazioni.
Mi sembra che ci sia tutta una parte che rimprovera questo Papa ed esalta quello precedente per la questione, se ho capito bene, della verità. Questa cosa della verità mi sembra fuori dal tempo, anche perché moltissimi non ci credono più e allora un cristianesimo vincolato solo alla verità non avrebbe più nulla da dire. Bah, questa mia è sicuramente una sciocchezza, lasciamola perdere...
Ma non è una sciocchezza, è una cosa seria. La verità è qualcosa che devi imparare a memoria, invece la fede è qualcosa di concreto e quotidiano. Chi sceglie la verità sceglie la religione. Ma quando è nato Gesù Cristo la religione è morta, con lui è nata la fede. La fede è il nuovo modo di esprimere la verità, non una verità da imparare a memoria, ma una verità da fare. È da fare, la verità. E non ha tutti quei contorni rigidi, inflessibili, impetuosi e assolutistici che esprimi con la verità. Con la fede puoi esprimere tutta la fantasia che Dio ha in te. Tutta. E quindi sei uno sperimentatore, sei un dio, hai una parte divina in te. Questo è concretezza. Cristo si è consegnato alla fede sulla croce, perché sulla croce perdeva la luce e ha detto al Signore: “Perdonami e non abbandonarmi”. E quindi è qualche cosa che è ancora da raccogliere, ancora da fare. Lì ha fatto fino a un certo punto. Poi sulla risurrezione, è vera o non è vera, la luce è vera o non è vera? Noi abbiamo un rapporto umano con Dio, il quale ci dà la possibilità di abbracciare la sua divinità ed essere divini anche noi, il che non ha nulla a che fare con i miracolismi vari che si accompagnano da sempre a questa parola e che vanno spazzati via. Sì, una concretezza labile, ma profonda nello stesso tempo. Qualche cosa che può farti cambiare la vita, insomma.
Concludiamo con una curiosità. Prima di iniziare avevi fatto un accenno alla maledizione del nome, “Benito”...
Ho dovuto lottare tutta la vita contro il mio nome. Sì, lo devo a mia madre, “Benito”. Lei me l’ha sempre raccontata così: “L’avevo promesso allo zio, lo zio l’hanno ucciso e così ti ho dato quel nome”. Per fortuna poi mia madre era molto avveduta, aveva molta creatività, e mi mandò a fare amicizia con il figlio Nino del sindaco Renato Giorgi, dottore e capo partigiano. La sua brigata fu la prima a entrare a Casalecchio di Reno nel ’44, circa. Liberarono prima Casalecchio e dopo Bologna, il 21 aprile. Fra un po’ c’è l’anniversario dei partigiani che furono legati con il fil di ferro in una stradina di Casalecchio, oggi diventata una piazza dedicata a loro.
E lo zio fu ucciso dagli antifascisti?
Sì. Perché lui era il podestà fascista di Bondeno, fratello gemello del papà di mia madre. Questi però non era fascista per niente, anzi erano in lite, loro due. Ma mio nonno morì. Per una sciocchezza: la notte del 6 gennaio si era vestito da befanone e, attraversando un ponticello mezzo ghiacciato su un canale lì a Bondeno, scivolò e si infilò una scheggia di legno nella mano. Dopo una settimana aveva il braccio nero: tetano. Aveva undici figli, mia madre aveva dieci anni. A quel punto la nonna vedova, non potendo allevarli tutti da sola, li distribuì ai fratelli, gli zii cioè, numerosi anche loro. Mia madre capitò sotto lo zio Pietro, quello più politicizzato. Infatti lo diceva a mia madre, che lui avrebbe fatto una brutta fine, perché aveva distribuito molto olio di ricino durante la sua militanza e poi, si diceva, che facesse del mercato nero con altri leader fascisti di quella zona lì, del ferrarese dove i fascisti non mancavano. Però i partigiani segnavano conto e quando ebbero possibilità di farlo, ne uccisero parecchi. Lo zio con altri fu seppellito vivo, dicono, sulla sponda del Po. Per mia madre fu come perdere il secondo papà. E allora cosa fai ai partigiani per vendicare lo zio? Chiami tuo figlio Benito! Cazzo, me la sono dovuta vedere io, dopo, questa cosa qui!
(a cura di Gianni Saporetti)
Archivio
L'ICTUS
Una Città n° 256 / 2019 marzo-aprile
Abbiamo ricevuto, tramite amici comuni, il testo di Arcipelago ictus, di Samsa Gregor, reperibile su Youcanprint.it, che ci ha colpito per la gravità del colpo e la vitalità del recupero. Ne pubblichiamo il primo capitolo, "Il contesto”, con il permesso d...
Leggi di più
LA CURIOSITA'
Una Città n° 306 / 2024 dicembre 2024-gennaio 2025
Realizzata da Barbara Bertoncin, Giovanni Maragno
Realizzata da Barbara Bertoncin, Giovanni Maragno
Michael Hill, geografo, insegnante e viaggiatore; è Fellow della Royal Geographical Society. Vive a Londra.
Partiamo dall’inizio: come ti sei appassionato alla geografia?
Quando avevo 12 anni, avevo un’insegnante di geografia davver...
Leggi di più
Aldo Moro e Gianni Baget Bozzo
Una Città n° 260 / 2019 ottobre
Le lettere che seguono si trovano tra le carte di Aldo Moro presso l’Archivio centrale dello Stato. Si riferiscono a due momenti diversi: la scelta di Baget Bozzo di divenire prete e la richiesta, sei anni dopo, da parte di don Gianni ad Aldo Moro d...
Leggi di più
Lo chopin partiva...
Una Città n° 251 / 2018 agosto-settembre
Il fascino dei racconti di vita, quando conservano le movenze della parola, gli scatti della voce, le emozioni del narratore o della narratrice, è che non si vorrebbe mai che finissero. Come capita da bambini, viene da dire "ancora!”, pe...
Leggi di più
HO INCONTRATO CARLA...
Una Città n° 298 / 2023 dicembre 2023 - gennaio 2024
Realizzata da Luciano Coluccia
Realizzata da Luciano Coluccia
Ciro Naturale, “allievo” della maestra Carla Melazzini, ha lavorato per tanti anni come educatore nelle attività scolastiche e territoriali che fanno capo ai Maestri di strada napoletani; dal 2008 vive a Marsciano con la moglie Melissa ...
Leggi di più

















