Tra le tante occasioni che questo terribile periodo ci sta fornendo, perlomeno laddove non siamo azzoppati dal contagio, c’è quello preponderante del rapporto con il lavoro. È interessante guardarsi attorno. Noi dal 20 aprile abbiamo riaperto lo studio legale anche (ma non solo) per non consumare troppe ferie delle segretarie, ma appare tutto sincopato: nessuna udienza in Tribunale (tutte rinviate, anche quelle di impugnazione di licenziamento: non sono considerate urgenti da molti Giudici del Lavoro, evidentemente), neanche da remoto, colleghi che lavorano da casa e altri che preferiscono farlo sul posto di lavoro, rapporti mediati da interfono, teleriunioni con le piattaforme più strampalate (consiglio iorestoacasa.work, niente male), incontri con rarissimi clienti accettati a tre metri di distanza e forniti obbligatoriamente di guanti e mascherina (mancava solo che li spruzzassimo di detergenti alcolici), lunghe sessioni telefoniche con altri clienti che hanno problemi di lavoro. E silenzio in studio per lunghi tratti della giornata.
Nessun atto giudiziale presentato o ricevuto nel frattempo. Una situazione particolare… Anche la distanza sociale tra noi (per protezione, con mascherine se si esce dalla propria stanza, senza passaggio di documenti cartacei, ecc.) ha contribuito a rendere estraniante la vicenda, ma le questioni che si stanno presentando, e che verranno inevitabilmente al pettine, sono le più varie, pericolose, stancanti, stravaganti e finanche esistenziali. Questo che segue è un piccolo florilegio di casi umani che ci hanno contattato in questi due mesi.
1. L’operatore sanitario di Rsa. Questa figura, assieme a paramedici e medici, è sicuramente una delle più esposte al contagio. Sino a metà marzo la casa di riposo ove lavora (e lavorava) l’infermiera T. era del tutto priva di mascherine (“spaventano gli ospiti”!), priva di prove di positività (i tamponi sono stati completati nelle case di riposo nella settimana tra il 20 ed il 25 aprile), priva di protocolli rigidi di protezione sia dei lavoratori che degli ospiti: il risultato è che molte di queste strutture sono state travolte dal contagio, con grave nocumento sia degli ospiti (che data la loro fragilità hanno avuto un grande tasso di mortalità) che dei lavoratori. T. al terzo giorno di febbre, tormentata da una improvvisa tosse, è stata lasciata a casa - dopo dieci giorni è riuscita ad ottenere un tampone presso la Asl (quindi non presso la propria abitazione, a domicilio!) risultando positiva, quindi è stata dapprima invitata a stare ancora a casa e, quando ha iniziato ad avere qualche difficoltà respiratoria, è stata ricoverata. Qui è iniziato il calvario vero e proprio, con la necessità di somministrazione di ossigeno, ma non ha dovuto subire intubazioni. Ci telefona dall’ospedale visibilmente provata e arrabbiata per sapere che cosa si può fare per tutelare la sua situazione. Sul punto (circolare n. 13/2020) l’Inail si è già espressa: un evento viene considerato infortunio quando sono contemporaneamente presenti la causa violenta, la lesione e l’occasione di lavoro, e la lesione di tipo virale viene considerata causa violenta e non malattia (v. epatite di tipo C, ecc.).
Ma può profilarsi anche una causa di responsabilità del datore di lavoro (civile e/o penale) per violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 271 e ss. D. lgs. 81/08 (Testo unico infortuni) sul rischio biologico? La risposta non può che essere positiva, ovviamente a seconda delle circostanze; un primo brivido ci si profila però, di fare o fomentare uno sciacallaggio intorno a questa situazione tragica. Poi leggiamo tutti i dati delle varie Rsa in Italia e nel Veneto: perché in alcune i dati di contagio e di mortalità (dei pazienti ma anche degli operatori sanitari addetti) sono altissimi e in altre no? Perché in molte strutture sarebbe dunque stato predisposto un evidentemente efficace sistema preventivo ed in altre no? Temo che ci si dovrà confrontare con questo problema -per ora consigliamo la nostra cliente di chiedere il riconoscimento di infortunio all’Inail, di attendere la guarigione completa per verificare che cosa si determinerà a seguito di questa “malattia” in termini di inabilità permanente e temporanea e poi si valuterà con attenzione il prosieguo: a seconda che l’eventuale violazione sia considerata di natura contrattuale o extracontrattuale abbiamo ben cinque o dieci anni in termini di prescrizione dall’evento per decidere che fare. Ma la questione ci turba, si sta aprendo forse un altro fronte da incubo?
2. L’impiegato di banca addetto allo sportello. Mi chiama il signor S., addetto allo sportello di una banca cittadina, che dalla fine di marzo è stato lasciato dapprima a casa a consumare tutte le ferie del 2019 non fruite, e poi invitato caldamente a lavorare da casa. Ma in telelavoro o smart working? Per smart working, o lavoro agile, si intende una modalità lavorativa di rapporto di lavoro subordinato in cui c’è un’assenza di vincoli a livello di orario e di spazio. L’organizzazione avviene per fasi, cicli e obiettivi ed è stabilita con un accordo tra dipendente e datore di lavoro; infatti il termine inglese “smart” si riferisce all’obiettivo di migliorare produttività del lavoratore grazie alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Nell’ordinamento italiano la legge che regola il lavoro agile è la numero 81 del 2017. La flessibilità organizzativa e la volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale sono due punti cardine di tale pratica. L’utilizzo di mezzi adatti a svolgere parte del lavoro anche in altri luoghi diversi dalla sede ordinaria è un altro requisito fondamentale e comune anche alla pratica del telelavoro, che è possibile solamente con strumenti che permettono di lavorare da remoto quali pc, tablet, smartphone ecc., generalmente forniti dal datore stesso.
Altre particolarità sono: la responsabilità del datore di lavoro sulla sicurezza del lavoratore; le regole per gli accordi tra le parti; la parità di trattamento economico e normativo tra chi lavora in modalità agile e chi svolge le sue mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda; il potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore; l’obbligo per il datore di lavoro di presentazione dell’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro; le regole sulla copertura assicurativa del lavoratore.
La differenza principale tra lavoro agile e telelavoro è che il secondo è invece basato su un altro concetto di fondo: in questo caso il lavoratore ha una postazione fissa che però si trova in un luogo diverso da quello dell’azienda. Si può riscontrare una maggiore rigidità che si traduce non solo sul piano spaziale, ma anche su quello temporale: nel caso del telelavoro gli orari sono più rigidi e, di norma, ricalcano quelli stabiliti per il personale che svolge le stesse mansioni all’interno dell’azienda. Anche in questo caso è necessario un accordo scritto delle parti, lavoratore e datore di lavoro.
Quindi, la nostra prima domanda è stata se il lavoratore doveva essere considerato in telelavoro o in smartworking: non lo sapeva! Gli era stato detto semplicemente di collegarsi secondo una certa piattaforma da casa, di non recarsi in azienda, e di svolgere il lavoro che gli sarebbe stato assegnato, solo che veniva sollecitato e chiamato a qualsiasi ora anche di sera, oltre il proprio normale orario di lavoro. Non gli risultava di avere firmato alcun accordo in passato, neanche in sede di assunzione, e voleva sapere se tutto ciò fosse corretto o possibile. Al sindacato non gli rispondeva nessuno.
Mi metto a studiare: il Governo è intervenuto sullo svolgimento dello smart working con numerosi interventi ultimamente: Dpcm del 1 marzo 2020, Dpcm del 4 marzo 2020, Dpcm dell’11 marzo 2020 e infine con un Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18. Tutti questi strumenti prevedono però un consenso scritto dell’interessato. Gli abbiamo dunque consigliato di scrivere all’azienda chiedendo precisamente come si configura il suo rapporto di lavoro e di farci sapere.
3. La panettiera. S. è una dolcissima persona di circa cinquant’anni che abbiamo da poco assistito per il suo secondo divorzio. Vicende alterne, che però si sono risolte con una decisione alla fine consensuale tra i coniugi. S. fa la panettiera, nel senso che è addetta alla vendita in una panetteria che nel retro si occupa di portare a cottura il pane semilavorato preparato in un altro forno a circa una decina di chilometri di distanza. Quando si è manifestato il problema del contagio da Covid-19, i panifici, al pari dei negozi alimentari, sono stati tra i pochi negozi che, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e di protezione (guanti, mascherine Ffp3 per il personale, e mascherine Ffp2 o chirurgiche a disposizione della clientela), hanno potuto continuare la loro attività commerciale. Il problema è che una collega di S., che manifestava malesseri e a un certo punto anche alcune linee di febbre, dopo essersi recata al pronto soccorso dell’ospedale è stata ricoverata, e ciò ha determinato lo sconquasso dell’organizzazione del lavoro della panetteria, con il personale, compresa S., che ha dovuto necessariamente stare a casa almeno 14 giorni. Alla riapertura del locale commerciale, stante la rivoluzione determinata da un’altra persona risultata positiva (ma che non risulta poi essere stata fortunatamente mai ricoverata), S. è stata rioccupata in mansione a lei del tutto sconosciuta, vale a dire addetta alla cottura dei semilavorati nel forno elettrico. Ovviamente non c’era stato il tempo di formarla e darle le istruzioni specifiche necessarie per svolgere tale mansione, che comunque lei aveva visto fare per molto tempo, ma le caratteristiche relative al rischio non potevano esserle del tutto conosciute. Succede dunque che una decina di giorni dopo l’inizio di questa nuova attività S., nell’infilare il prodotto nella bocca del forno, per risolvere un impiglio, torceva la pala al momento dell’uscita e, benché fornita di guanti specifici, nello spingere e forzare la barra della pala la estraeva con troppa forza toccando con la lama arroventata la propria guancia e il collo. S. veniva dunque portata al pronto soccorso e nel frattempo interveniva lo Spisal locale (servizi Asl per la sicurezza del lavoro) che, per chiarire gli eventi, poneva sotto sequestro temporaneo i locali, provocando quindi nuovamente l’interruzione del lavoro. Ora S. è a casa con prognosi iniziale di 15 giorni, il panificio è chiuso temporaneamente, i dipendenti in cassa integrazione e il datore di lavoro rischia ovviamente di essere perseguito per concorso in lesioni personali e per non avere formato e istruito il lavoratore alla mansione a cui era addetto - art. 55 d.lgs. 81/08; rischia inoltre di dover risarcire S. del danno differenziale rispetto alla prestazione Inail di cui godrà, oltre che vedersi perseguito in rivalsa dallo stesso istituto. Sempre che il panificio riparta, già prima non navigava in buone acque.
4. Il dirigente medico sanitario. F. è un professore universitario primario di un reparto di Geriatria di un importante ospedale del territorio. Nel suo reparto, strutturato con circa una trentina di posti letto (generalmente anziani in grave difficoltà, provenienti dal pronto soccorso, o comunque ricoverati per cure importanti), l’arrivo del ciclone Coronavirus è stato ovviamente avvertito con molta apprensione.
Nel reparto lavorano circa una quindicina di medici tra strutturati (assunti) e specializzandi, oltre a una ventina di paramedici tra infermieri professionali ed Oss coordinati da una caposala cerbero, poco comunicativa, ma efficiente in termini di organizzazione. F. ci contatta una prima volta verso la metà di marzo 2020 per raccontare che era stato contestato da un rappresentante sindacale perché non c’erano mascherine né dispositivi di protezione individuale a disposizione di medici e paramedici; vuole sapere se può querelarlo, visto che le disposizioni dell’Amministrazione sono tassative: non si devono usare mascherine (né peraltro sarebbero sufficienti quelle a disposizione per più di un giorno o due) “per non spaventare i degenti” e quindi il presidio sanitario è ridotto al minimo. Alla mia sorpresa che non siano state già fornite almeno le mascherine sia al personale che ai degenti, sento dall’altra parte un certo imbarazzo: lui lo aveva fatto presente più volte all’Amministrazione nei giorni precedenti, ma questa continuava a ripetere che era sufficiente prestare molta attenzione nei servizi, mantenere la distanza, ecc. In un reparto geriatrico!!! Avete presente le necessità di un anziano, per di più ricoverato, sia nell’accesso al bagno (quando possibile), nel vestirsi, nel lavarsi, nel consumare il pasto…
F. si è reso conto già nel corso della telefonata che non solo una querela era del tutto improponibile, ma che la situazione rischiava di sfuggirgli di mano; in realtà l’impressione era che avesse chiamato per capire che margini di manovra avesse lui con l’Amministrazione, se cioè potesse in qualche modo opporsi alle direttive organizzative impartite. Seconda telefonata una settimana dopo: i primi casi di positività sia tra il personale che tra i degenti, le Rsu sindacali in fibrillazione, le mascherine, i guanti, i camici finalmente arrivati per tutti, ma forse troppo tardi. A questo punto vuole sapere come tutelarsi dai degenti, dai suoi operatori sanitari e dall’Amministrazione, perché lui era nell’impossibilità di avere strumenti protettivi a disposizione, e li aveva chiesti continuamente. Ci mostra una lettera inviata all’Amministrazione circa dieci giorni prima (siamo nella prima metà di marzo) con pressanti richieste a cui non era mai stato risposto. Lo consigliamo di predisporre una memoria precisa e puntuale, con date, riferimenti e mail, di tutto quanto è successo nel reparto da quando si è affacciato il problema del contagio del Coronavirus, rilevando che dovrà necessariamente difendersi nel momento in cui i contagiati potrebbero chiedere ragione della mancata predisposizione di strumenti protettivi. Ci accordiamo per esaminare lo scritto, che arriva di lì a tre giorni, corredato da riferimenti puntuali e ci sembra sufficiente. In ogni caso lo leggiamo con cura, valutando con attenzione tutti gli allegati onde evitare sorprese. Due giorni dopo richiamiamo il primario F., che ci risponde subito al cellulare. Anche lui riscontrato positivo, era a casa con la febbre; due giorni dopo il reparto è stato chiuso e i malati non contagiati trasferiti in altre strutture protette onde permettere una sanificazione generale. Nel conteggio dei decessi di questo periodo non è ancora noto il riferimento di questa struttura. Allo stato non risultano aperte inchieste giudiziarie della Procura su questo episodio, bensì sulla situazione disastrosa di altre due case di riposo con un tasso di mortalità tra i degenti intorno al 30%. Il primario sta meglio, ma non è ancora negativo e quindi è assente dal lavoro da circa un mese. Poi ha chiamato il rider fermato dai carabinieri, la studentessa fuori sede sanzionata perché rientrata a casa via ferrovia dalla città dove si era laureata il giorno prima, il dirigente di una categoria sindacale ricoverato per Coronavirus che ha determinato la chiusura dell’intera struttura sindacale (otto operatori a casa), e così via. Il lavoro nel tempo del Coronavirus ci ha impedito di annoiarci. Il 25 marzo è entrato in vigore il D.L. n. 19/20 frutto del Protocollo Governo-parti Sociali in materia di sicurezza del lavoro. Ci sarà da lavorare.
di politica e altro, problemi di lavoro
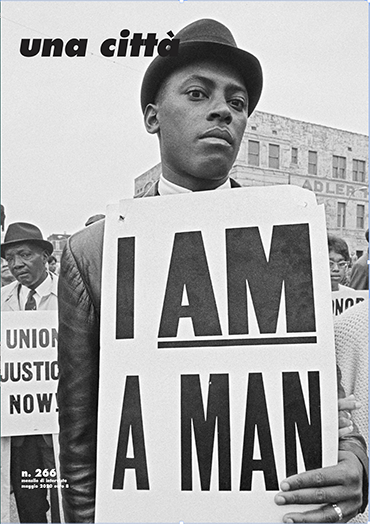
Una Città n° 266 / 2020 maggio
Articolo di Massimo Tirelli
IL LAVORO NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS
Le vicende, lavorative ed esistenziali, di un’infermiera in una Rsa, di un impiegato di banca, di una panettiera e del primario di un reparto di geriatria alle prese con lo stravolgimento della loro vita a causa della pandemia. Il diario di Massimo Tirelli, avvocato del lavoro.
Archivio
IL LICENZIAMENTO
Una Città n° 205 / 2013 Agosto-Settembre
Realizzata da Barbara Bertoncin e Gianni Saporetti
Realizzata da Barbara Bertoncin e Gianni Saporetti
Massimo Tirelli, avvocato esperto in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale, è consulente legale del Patronato Inas-Cisl e della Fim-Cisl di Verona e Trento.Che cambiamenti ha introdotto la Riforma Fornero sul fronte dei licenziamenti?La prima osse...
Leggi di più
UN DIRITTO IN CRISI
Una Città n° 256 / 2019 marzo-aprile
Realizzata da Barbara Bertoncin
Realizzata da Barbara Bertoncin
Alberto Piccinini, avvocato giuslavorista dello "Studio Legale Associato” di Bologna, già membro del collegio di difesa della Fiom in vari contenziosi, è presidente nazionale dell’associazione "Comma2-Lavoro è Dignità”. Massimo Tirelli, avvocato esperto i...
Leggi di più
Il caso Pfas (Antropocene e/o Capitalocene)
Una Città n° 299 / 2024 febbraio
Breve riassunto: dopo una combattuta Udienza preliminare, a seguito di rinvio a giudizio il 01/07/2021 si è aperto avanti la Corte di Assise di Vicenza il processo nei confronti di 15 imputati, coinvolti a vario titolo (vertici di Miteni e di socie...
Leggi di più
Ma quali cooperative cerchiamo?
Una Città n° 287 / 2022 ottobre
ai giornali del Veneto:
“Venerdì 20 maggio 2022, intorno alle 16, un mezzo pesante e un’auto sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo via Postumia, a San Pietro in Gù, ai confini con la provincia vicentina....
Leggi di più
Il salario minimo
Una Città n° 283 / 2022 aprile
Ma quanto ci vuole per affrontare il salario minimo?
Il fatto è presto raccontato: si rivolgono all’Ufficio Vertenze di un sindacato “maggiormente rappresentativo” (che passa il caso al nostro studio) un gruppetto di lavoratori d...
Leggi di più


















