Non è facile parlare del pensiero e della vita di Simone Weil (1909-1943), il caso più singolare nella filosofia occidentale del Novecento. Singolare perché fra pensiero e vita il legame è continuo. L’eccellenza illuminata della sua opera è del tutto estranea alla filosofia accademica e supera anche i confini della filosofia occidentale, attingendo spesso ai classici e alle tradizioni orientali.
La solitudine di Simone Weil nella cultura francese ed europea è dovuta anche, o soprattutto, all’indifferenza nei suoi confronti degli ambienti intellettuali e politici. Un’eccezione pressoché unica è stata quella di Albert Camus, che ne capì subito originalità e valore, iniziando e promuovendo la pubblicazione in volume di alcuni suoi scritti. Il destino di una tale opera mostra quanto poco la sua riflessione morale e politica derivi dalle prevalenti tendenze culturali degli anni Trenta. Dai suoi appunti, saggi, quaderni, lettere, abbozzi sono stati ricavati, dopo la sua morte precoce a soli trentaquattro anni, tutta una serie di volumi, tra cui (cito i titoli in italiano) L’ombra e la grazia (1947), La prima radice (1949), La conoscenza soprannaturale (1950), La condizione operaia (1951), La fonte greca (1953), Oppressione e libertà (1955). Ma l’insieme dei suoi scritti aspetta tuttora di essere adeguatamente valutato e compreso, anche a causa della loro frammentarietà antisistematica e occasionale. Il fatto è che la vastità e varietà dei suoi interessi speculativi, dovuta alle drammatiche crisi sociali e politiche fra le due guerre, non ha trovato che molto in ritardo l’attenzione di pochi studiosi. Si tratta infatti di un’opera che indaga, con totale libertà di pensiero e autenticità autobiografica, problemi etici, religiosi, conoscitivi e politici, senza appartenere né ai più consueti generi filosofici e letterari né alla memorialistica o alla pubblicistica ideologico-politica. Del resto non si spiegano del tutto gli scritti di Simone Weil se non li si considera in rapporto alle sue esperienze personali. E questo non perché abbiano bisogno di riferirsi semplicemente ed esclusivamente a una vicenda biografica, ma perché l’energica chiarezza del suo stile saggistico, l’evidenza e profondità del suo pensiero, nascono e si sviluppano insieme alle sue scelte di vita: una vita non determinata né influenzata da motivazioni professionali. Si potrebbe parlare, cioè, di una filosofia vissuta o di una vita filosofica, come era avvenuto nell’antica Grecia. In questo senso la Weil fa anche parte di una moderna tradizione moralistica europea che costeggia in parte una tradizione mistica che in Occidente si esaurisce con il XVIII secolo.
Il pensiero, per la Weil, non può che avere fondamento in una disciplina dell’attenzione che porti all’equanimità, all’obiettività e a una purezza mentale libera sia da desideri personali che da ideologie collettive. Per sottrarsi all’errore e all’inganno, l’attenzione alle esperienze e alle attività deve essere perfetta.
Uno degli equivoci maggiori in cui cadono gli studiosi moderni di filosofia è quello di fare della Weil, per comodità e semplificazione, una “pensatrice religiosa”. E questa è una subdola maniera per neutralizzare, rimuovendolo, il suo pensiero e il suo impegno sociale e politico. La Weil lesse precocemente sia Platone che Marx, volle fare esperienza del lavoro operaio nelle fabbriche Alsthom e Renault, partecipò nel 1936 alla guerra civile spagnola militando nello schieramento anarchico di Buenaventura Durruti. In effetti, nella vita e negli scritti della Weil, non si ha pensiero senza esperienza personale (cosa poco frequente negli accademici) né esperienza senza pensiero. Caratterizzano essenzialmente l’identità della Weil sia l’interesse all’idea di rivoluzione, ripresa da Marx, riformulata e criticata, nonché la devozione alla cultura greca, al cristianesimo evangelico e alla nozione di “sacro”. La diagnosi storica da cui partì era radicale: “Mai l’individuo è stato così completamente abbandonato a una collettività cieca, e mai gli uomini sono stati più incapaci non solo di sottomettere le loro azioni ai loro pensieri, ma perfino di pensare” (in Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, Adelphi 1984, pp. 76-77). Ma le pagine decisive e straordinariamente penetranti si leggono nella Prima radice:
Da un biografo di Hitler sappiamo che tra i libri che hanno esercitato una profondissima influenza nella sua gioventù ci fosse un’opera di infimo ordine su Silla. Che importa il fatto che fosse di infimo ordine? Quell’opera rifletteva l’atteggiamento della cosiddetta classe dirigente [...]. Se Hitler ha desiderato il genere di grandezza che veniva glorificato in quel libro e dovunque, non c’è stata colpa da parte sua. Quella è infatti la grandezza che ha raggiunto, la stessa alla quale noi tutti ci inchiniamo quando guardiamo al passato [...]. Immaginiamoci quell’adolescente, povero, sradicato, che vagabonda per le vie di Vienna, affamato di grandezza. Di chi la colpa se egli non ha saputo scorgere un altro genere di grandezza che non fosse quella del delitto? [...] Si parla di punire Hitler. Ma non lo si può punire. Voleva una sola cosa e l’ha avuta: essere nella storia [...]. Qualunque cosa gli si infligga, si tratterà sempre di una morte storica, di una sofferenza storica. Sarà storia [...] e soprattutto non impedirà, fra venti, cinquanta, cento o duecento anni, a un piccolo ragazzo sognatore e solitario, tedesco o no, di pensare che Hitler è stato un essere grandioso [...]. La sola punizione capace di punire Hitler e di distogliere dal suo esempio i ragazzi affamati di grandezza che vivranno nei secoli avvenire è una completa trasformazione del senso della grandezza che necessariamente lo escluda.
È una chimera, dovuta alla cecità degli odii nazionali, credere che si possa escludere Hitler dalla grandezza senza una trasformazione completa, tra i contemporanei, della concezione e del significato della grandezza [...]. È vano cercare fin dove giungano le somiglianze e le differenze fra Hitler e Napoleone. L’unico problema che abbia interesse è quello di sapere se si può legittimamente escludere dalla grandezza uno di loro senza escluderne anche l’altro [...]. Marco Aurelio, a proposito di Alessandro e Cesare, diceva più o meno così: se non sono stati giusti, nulla mi costringe a imitarli, nulla ci costringe ad ammirarli.
Qui la critica politica viene dedotta dalla critica culturale. Se una civiltà nutre l’idolatria di una nozione aberrante di che cosa è “grandezza”, misurata sull’importanza storica e non sul valore morale, allora non ci sarà mai modo di liberare la vita sociale e politica dai peggiori crimini. Di una tale schiavitù morale e mentale il mondo non si è ancora minimamente accorto.
Simone Weil filosofo inascoltato
di filosofia e altro
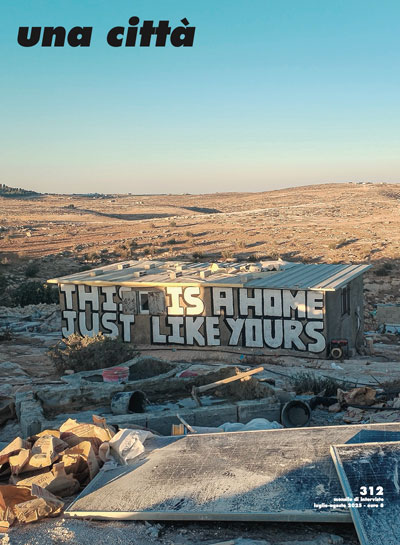
Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto
Articolo di Alfonso Berardinelli
Simone Weil filosofo inascoltato
Archivio
LA VARIETA’ DEL REALE
Una Città n° 35 / 1994 Ottobre
Realizzata da Rocco Ronchi, Franco Melandri
Realizzata da Rocco Ronchi, Franco Melandri
Nel suo ultimo libro lei sostiene che è in crisi l’autocomprensione che la pratica poetica ha avuto di se stessa nella modernità e quindi è necessario che la poesia si riapra, che ritrovi uno spazio comunicativo. Ma cosa vuol dire che la poesia, e la lett...
Leggi di più
E TU A COSA SERVI?
Una Città n° 116 / 2003 Ottobre
Realizzata da Katia Alesiano, Franco Melandri
Realizzata da Katia Alesiano, Franco Melandri
Alfonso Berardinelli, critico letterario e saggista, recentemente ha pubblicato: Stili dell’estremismo (Editori Riuniti), Cactus (ed L’ancora), Nel paese dei balocchi, (ed. Donzelli), La forma del saggio (Marsilio).Di che cosa parliamo quando parliamo di ...
Leggi di più
COSE FATTE, SEMPLICEMENTE
Una Città n° 27 / 1993 Novembre
Realizzata da Franco Melandri
Realizzata da Franco Melandri
L’attuale crisi italiana ripropone la discussione fra chi vede nella politica solo l’ambito della mediazione e chi invece ritiene che essa debba anche indicare scopi generali o modelli di società... Direi innanzitutto che oggi, come venti o trenta anni fa...
Leggi di più
BASTA CON AMLETO
Una Città n° 106 / 2002 Agosto-Settembre
Realizzata da Franco Melandri, Gianni Saporetti
Realizzata da Franco Melandri, Gianni Saporetti
Alfonso Berardinelli, critico letterario e saggista, recentemente ha pubblicato: Stili dell’estremismo (Editori Riuniti), Cactus (ed L’ancora), Nel paese dei balocchi, (ed. Donzelli), La forma del saggio (Marsilio).Uno dei principali obiettivi polemici de...
Leggi di più
Debenedetti e il romanzo del Novecento
Una Città n° 306 / 2024 dicembre 2024-gennaio 2025
In “Personaggi e destino”, un saggio pubblicato nel 1945, Giacomo Debenedetti, il critico italiano che più si è dedicato al romanzo novecentesco e alle sue innovazioni, scriveva che nella Repubblica delle Lettere, fra Settecento ...
Leggi di più

















