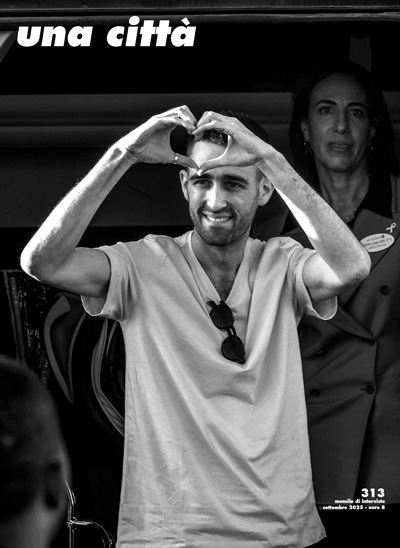Se la crescente affermazione elettorale delle destre sovraniste è, come è, un fatto generalizzato nelle democrazie occidentali, vuol dire che, di là dalle differenze e specificità nazionali, vi è almeno un fattore comune e in quanto comune rilevante che le accredita dinanzi al loro elettorato potenziale. Uno, a parere di chi scrive il principale, è il duplice orientamento politico-ideologico riduttivo e restaurativo proprio della destra sovranista. Riduttivo (o sottrattivo) perché punta a far credere ai propri elettori di saperne salvaguardare la condizione sociale peggiorando quella degli appartenenti ad altre categorie e gruppi sociali. Quel che conta è far loro percepire, nonostante il mancato avanzamento o il declassamento di fatto, un miglioramento nella posizione relativa, vale a dire del proprio status (definito dai livelli di reddito, di prestigio e di potere) rispetto a quello di altri. Viene così prospettato un modo di annullare o ridurre il sentimento di privazione relativa che angustia ampi settori della classe media. L’operazione è agevolata dal fatto di distinguersi dalla sinistra, che è manifestamente più attenta alle situazioni di privazione assoluta (povertà, disoccupazione, lavoro nero).
Quand’anche non sia pura propaganda, è un’operazione demagogica, dato che non mira, incidendo sulle cause, a ridurre la distanza sociale da chi sta sopra, ma ad aumentarla nei confronti di chi sta sotto o più o meno allo stesso livello. L’obiettivo è perseguito sostenendo provvedimenti di legge e fomentando pregiudizi atti a marginalizzare, escludere o reprimere soggetti deboli, in primis gli immigrati, Pur rispondenti ciascuno a motivazioni e calcoli politici variabili, ne sono esempi eloquenti le limitazioni poste al riconoscimento della cittadinanza, il rifiuto del salario minimo, l’opposizione al reddito di cittadinanza o, per stare al caso dell’America di Trump, gli enormi tagli all’assistenza sanitaria per poveri e disabili e ai sussidi per l’assistenza alimentare.
Merita notare come un analogo orientamento riduttivo venga adottato anche nei confronti di chi sta sopra, ma che (per motivazioni più politiche che sociali) lo sia in modo tanto selettivo e punitivo da essere riservato agli operatori della cultura, dell’informazione, della giustizia e della scienza. Accusati d’essere di parte o denigrati come parassiti, essi sono soggetti alla riduzione dei margini d’azione autonoma e al taglio di finanziamenti.
Riguardo in particolare alla questione degli immigrati, la forte influenza dei sovranisti sugli elettori è espressione di un senso di appartenenza che è l’opposto di quello della sinistra. Se l’una istiga a respingere il diverso, l’altra invita a identificarsi. Riflette l’opposizione tra una concezione localizzata e una estesa della partecipazione sociale e della lealtà politica: particolarismo contro universalismo. Sotto questo profilo, è come se nel confronto con gli immigrati, e più in generale con chi sta sotto, quegli elettori dicessero alla sinistra: “Sono diversi e voi ci assimilate, ci omologate, ci trattate alla pari”. Reciprocamente, non è meno rilevante notare che nel confronto con chi sta sopra -le categorie con elevato livello di cultura specialmente- è come se i medesimi dicessero alla sinistra: “Siamo simili ma ci differenziate, ci escludete”. Questo in una situazione in cui istruzione e cultura, per il fatto d’essere sempre più decisive e discriminanti per adattarsi alle innovazioni e al cambiamento, tendono a venir considerate dai ceti popolari come fattori di esclusione.
In un contesto sociale da tempo connotato in crescendo dal diffuso squilibrio di status (la discordanza tra i livelli di reddito, di prestigio e di potere), l’offerta di una politica restrittiva, restaurativa e punitiva, quale quella propagandata o, se al governo, praticata dalla destra nazionalista, vale per le tante persone che si sentono degradate come una promessa di riscatto e di vendetta (oggi più di vendetta che di riscatto). Ed è qui che si coglie un’altra decisiva differenza con la sinistra. Non soltanto perché questa s’impegna a far acquisire (giustamente) uno status riconosciuto a categorie come immigrati, lesbiche e gay, ma anche per il fatto di ricondurre (non di rado ridurre) lo squilibrio di status patito dal lavoratore alla sola dimensione del reddito e a trascurare l’effetto negativo indotto da cambiamenti economico-finanziari e tecnologici sul prestigio e il potere di tante pro ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!