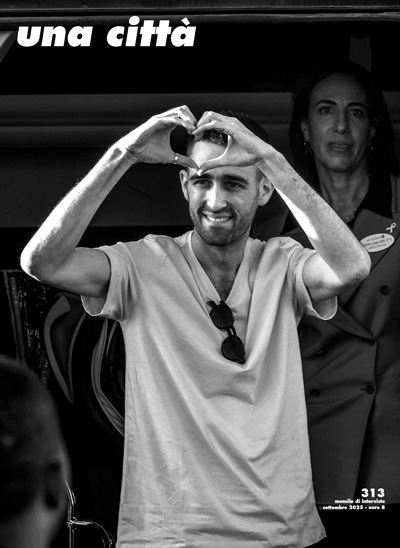C’è una cosa da imparare dal carteggio fra Alessandro Galante Garrone e Carlo Dionisotti, appena edito a cura di Gian Paolo Romagnani (Le radici della vita. 1941-1997, Edizioni di Storia Letteratura). Sorprende la concordia discors fra due amici che diventano sempre più vicini mano a mano che le rispettive posizioni si allontanano. Diversità di carattere. Dionisotti è perfido quando afferma che dal Settecento in poi “è esistita e esiste una innominata mafia torinese e piemontese, consorte di quella siciliana”, svelando che il Re è nudo, l’azionismo torinese una lobby, oppure quando invita l’amico a essere più “aspro”, a non entrare in polemica con Cossiga. Non ne vale la pena, scrive rammentandogli la saggezza del vecchio Quintino Sella che voleva abolire l’università di Sassari. La generosità operosa di Galante induceva Aldo Garosci a sgridarlo: “Sii più cattivo”; Jemolo inventava per lui una delle sue battute migliori: “Non credi al Paradiso, ma fai di tutto per meritartelo”; dall’altra parte c’è la durezza aspra dell’esule, dispatriato a Londra come Meneghello, che, more anglico, infierisce sulla mollezza e la retorica italica del “ministro diminutivo” (Spadolini), degli hegeliani di Napoli (i “vichini”), giocando con le parole (le machiavellerie), ma puntando il dito contro Piero Calamandrei, ultimo esponente della retorica oratoria ed epigrafica toscana, di cui Galante e Agosti avevano curato un volume di opere. L’amicizia fra i due aveva radici solide da rendere gradevolissima la lettura di un libro che ha in prima istanza i caratteri della commedia giocosa. Il Bello (Dionisotti il Bello) è il Cattivo che in vecchiaia diventa Brutto; il Buono (Galante) rimane Buono, ma in vecchiaia diventa Bello. Un western all’italiana, azionista? “Il Buono, il Brutto il Cattivo”. Dal 1967 in poi, con l’uscita di Geografia e storia della letteratura italiana, vero spartiacque nella corrispondenza fra i due, Dionisotti il Bello diventerà anche Dionisotti il Grande.
La sostanza del carteggio è però tragica, non comica. Il dissenso ruota intorno al tema della storiografia vindice e giustiziera. Le nostre conoscenze erano ferme al famoso articolo di Dionisotti, che nel 1945 si schierò a favore della condanna a morte di Gentile; molto s’è scritto intorno alla aspra reprimenda contro Guido Quazza, che negli studenti del ’68 aveva visto gli eredi dei partigiani. Alla nostra comprensione del problema mancava l’epilogo: “Contro l’opinione dei maestri nostri”, confida Dionisotti, “io credo alla storia giustiziera e vindice”. È l’omicidio di Casalegno nel 1977, che ci aiuta a capire la natura di quelle precedenti prese di posizione. Scrive Dionisotti: “Nato nel ’16, nato alla pace piuttosto che alla guerra, si era nutrito di fiducia e speranza piuttosto che di odio”. Una lettera drammatica, rivelatrice: “Per telefono ti ho detto che l’incapacità nostra di vendicare Casalegno, quali che fossero le sue idee (lontanissime certo dalle mie), di vendicare un amico e compagno della Resistenza, di Gl e del Partito d’Azione, significa, per me, che siamo ormai tagliati fuori, tutti quanti noi, da qualsiasi ingerenza negli sviluppi attuali della politica italiana”.
Una sorta di eterogenesi dei fini, rispetto alla controversia con Quazza. Il 1977 di Casalegno rende più vicino il 1945 di Gentile che il 68 di Quazza. Noi coetanei di Casalegno, spiega Dionisotti, siamo troppo vecchi per vendicarlo, ma i giovani del 68 dove sono? Avrebbero l’età giusta per vendicarlo, così dimostrandosi nei fatti e non in forza di soli slogan i legittimi eredi della Resistenza.
Dal 1977 alla fine dei suoi giorni, Dionisotti non fa che ritornare su questo punto, in maniera quasi ossessiva. Più di dieci anni dopo, Galante raccoglie in volume i suoi articoli sul tema dell’antisemitismo, su Israele, sulle leggi razziali. Intitola il volume Amalek, il dovere della memoria (1989). In quarta di copertina il ritratto dell’autore: “A distanza di 60 anni, una gentile nemesi storica vuole che il bello sia ora tu, non più io”, risponde Dionisotti. E subito aggiunge, appoggiandosi, come l’Ulisse dantesco in Se questo è un uomo, all’autorità del Sommo Padre: “In questa piccola vigilia vorrei dire molte cose. Nella Bibbia mia (Utet), leggo: ‘Cancellerai la memoria di Amalek di sotto al cielo’. Altra cosa è il ricordare. Avendo fatto il mestiere di storico, e anche per altri motivi, non sono disposto a cancellare”. Perdurava forse il ricordo dell’amico non nominato, Arnaldo Momigliano, morto due anni prima, i cui genitori sterminò Amalek.
Ma oggi? La lettera reca la data del 4 ottobre 1989: “Ogni volta a Torino guardo l’albero di corso Vinzaglio dove è stato ucciso ma anche vendicato, Vian”. Allo stesso albero dove fu impiccato il partigiano Ignazio Vian, il 30 aprile 1945 era stato impiccato il segretario federale fascista di Torino, Giuseppe Solaro: “Penso che immancabilmente sarà un giorno in cui sarà vendicato il nostro Casalegno”. Di nuovo risuona l’invito ad abbandonare Croce, a farsi storici vindici: “Noi siamo stati spettatori e corresponsabili di quel che è accaduto nella prima metà del secolo. Siamo incatenati come cani a quell’orrore. Dobbiamo soffrire e protestare in quel ricordo”.
Amalek, la vendetta, la storia
pagine di storia

Una Città n° 309 / 2025 aprile
Articolo di Alberto Cavaglion
Amalek, la vendetta, la storia
Archivio
QUEL TESTO DI GATTERMANN
Una Città n° 51 / 1996 Giugno-Luglio
Realizzata da Gianni Saporetti
Realizzata da Gianni Saporetti
Alberto Cavaglion è insegnante a Torino. Ha curato per la Loescher una guida scolastica alla lettura di Se questo è un uomo.Il concetto di unicità riferito alla Shoah resta molto controverso. Se da una parte c’è il rischio di ridurre Auschwitz a un orrore...
Leggi di più
DAL '22 AL '43
Una Città n° 232 / 2016 luglio-agosto
Realizzata da Cesare Panizza
Realizzata da Cesare Panizza
Alberto Cavaglion, studioso dell’ebraismo, insegna all’Università di Firenze.Anni fa hai scritto La Resistenza spiegata a mia figlia. Come si racconta a un giovane di oggi il fascismo, la Resistenza, la Shoah?La pubblicazione di La Resistenza spiegata a m...
Leggi di più
La libertà religiosa
Una Città n° 301 / 2024 aprile-maggio
Ciò che sta accadendo nelle università mette a nudo l’importanza di un problema di cui nessuno vuole parlare: la libertà religiosa. Ci si concentra sulla libertà di parola, che nelle aule universitarie dovrebbe essere gar...
Leggi di più
L'antifascismo espiativo
Una Città n° 302 / 2024 giugno-luglio-agosto
Lo scorso 18 giugno, presso la Biblioteca Gino Bianco, si è tenuto il quinto incontro del ciclo di “seminari conviviali” intitolato “Libri fondamentali”. Abbiamo invitato Alberto Cavaglion a parlare di “Luigi Meneghell...
Leggi di più
"Tra gli isolani era un barbone..."
Una Città n° 306 / 2024 dicembre 2024-gennaio 2025
Molto si parla in Italia di fascismo. Di continuità e discontinuità gli storici avevano iniziato a discutere subito dopo il 25 aprile, la letteratura in materia è vasta. Triste constatare che da così tante riflessioni poco sia ...
Leggi di più